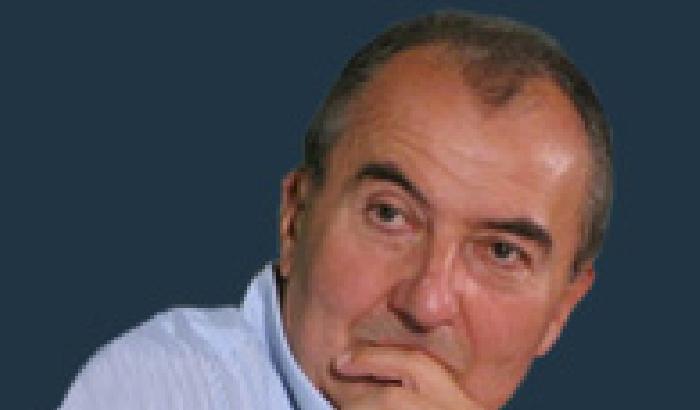di Giorgio Boatti
A volte viene da pensare che l’oblio sia davvero prezioso perché, senza oblio generalizzato e amnesie storiche e rimozioni culturali, la memoria civile rimarrebbe pericolosamente inoperosa.
Vale a dire che l’impegno a discernere quanto delle esperienze comuni trascorse merita di essere compreso – ovvero, letteralmente, preso con sé, nel tragitto che si sta compiendo – non solo non avrebbe modo di realizzarsi ma finirebbe col non avere senso se tutto quanto di significativo è accaduto nel passato, capace di guidarci nei passi da compiere e di ammaestrarci sugli errori da evitare (historia magistra vitae), fosse lì, costantemente disponibile e perennemente illuminato dal ricordo.
La storia è un deposito…
Senza l’oblio la storia, o almeno quella strana creatura che amiamo definire con questo nome, finirebbe con l’essere un affastellato deposito, simile, in qualche modo a quello che Jorge Luis Borges, in un suo racconto, attribuisce a Ireneo Funes, il personaggio che non dimentica nulla e che dunque dice “La mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti” .
Se l’oblio non svolgesse il suo meritorio e misterioso lavoro, tutto il passato sarebbe pervasivamente presente in ogni piega e spicchio del confronto pubblico.
Accadrebbe quello che oggigiorno succede in rete, per qualsiasi informazione, notizia, nozione: una volta che viene catapultata dentro la rete non potrà mai più essere cancellata. Non solo: basterà inserire nei programmi di ricerca qualche vago interrogativo che vi faccia riferimento per vedere assieparsi una folla di risposte, più o meno pertinenti, più o meno congrue. In questo assieparsi prenderanno posto, fianco a fianco, senza nessuna immediata e ragionevole distinzione, il vero e il verosimile, lo scrupolosamente asseverato e le stratificazioni di presunzioni, falsificazioni, strumentalizzazioni, fraintendimenti.
Non so bene perché ma, nel momento stesso in cui mi sono affidato a questa metafora della rete affollata di tante risposte che spesso risposte non sono alle domande poste, mi è venuto in mente che, dopo tutto, qualcosa di simile rischia di accadere quando la memoria del passato, nella sua dimensione di esperienza collettiva di ricostruzione del passato e dunque di ricordo civile, diventa un appuntamento fissato dalla legge e assume il ruolo di un adempimento istituzionale .
Negli ultimi anni l’intento di favorire l’opera della memoria collettiva al fine di rammentare il passato, evitare il ripetere di errori e orrori che ne hanno connotato alcuni tragici passaggi e magari generare gli anticorpi per precludere passi falsi alle future generazioni, ha dato vita a un fittissimo calendario di ricorrenze – giorni e giornate della memoria – che costellano tutti i mesi dell’anno, a partire dal 27 gennaio, giorno della memoria della Shoah. E altre proposte di giorni e ricorrenze celebrative si sono nel frattempo aggiunte in quantità tale che, se fossero approvate, avremmo una media di tre “giorni della memoria” al mese ….”
Testo di Giorgio Boatti per il “Giorno della Memoria”, letto quando l’Università di Ferrara lo aveva chiamato a parlare sul rifiuto opposto a Mussolini dai dodici professori che rifiutarono il giuramento al fascismo raccontato nel libro “Preferirei di no”, Einaudi editore.