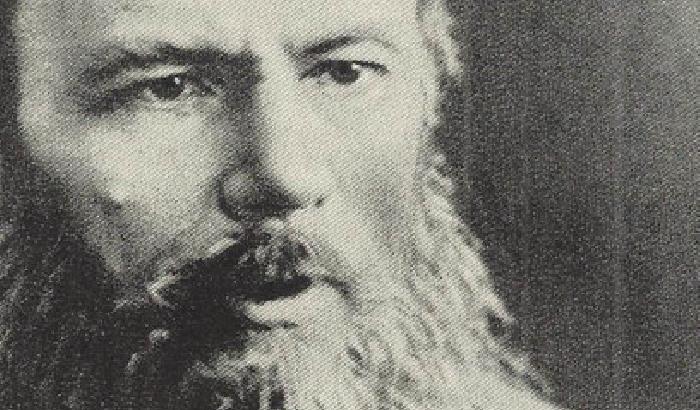La disgregazione dei grandi imperi, culminata nel primo conflitto mondiale, era cominciata ben prima e aveva visto in primo piano la spartizione della regione balcanica, considerata un cuscinetto fra Occidente e Oriente nel contesto geopolitico mondiale. Uno dei momenti chiave di questo processo viene segnato nel 1877, quando la Russia zarista dichiara guerra all’Impero ottomano per “liberare” i territori dei Balcani e contemporaneamente guadagnare uno sbocco al mare. I russi vengono fermati per quattro mesi a Plevna, poi si arrestano davanti a Costantinopoli fino al gennaio 1878, quando compare negli stretti la flotta britannica in aiuto ai turchi. L’importanza del momento storico è stata colta da pochi contemporanei, ma fra questi certamente vi è quello che ad oggi è considerato forse il più grande scrittore russo di tutti i tempi.
Fedor Dostoevskij è in quel momento conosciuto per i suoi “gialli d’autore”, pubblicati a puntate come dei feuilleton nelle riviste dell’epoca. Più tardi gli episodi, raccolti in volumi unici, avrebbero formato romanzi come “Delitto e castigo”, “L’idiota” e i “Fratelli Karamazov”. Lontano anni luce dagli ambienti politici, ortodosso convinto e soprattutto grande appassionato della “causa pan-slava”, Dostoevskij interpreta in un testo scritto di suo pugno, oggi pubblicato in serbo in esclusiva dal settimanale “Nedeljnik”, gli eventi di allora inglobandoli in una visione più ampia dove viene posta la questione degli “slavi dei Balcani”. Questi sono visti come frammentati, inquieti e pericolosi per la stabilità geopolitica internazionale, ma soprattutto protagonisti di un rapporto “amore-odio” verso la più grande Madre Russia.
Oggi il settimanale serbo, nel riproporre il testo, fa notare come siano “straordinariamente somiglianti” alcuni dettagli con quelli che caratterizzano il rapporto odierno fra gli slavi del Sud e Mosca. Altrettanto somiglianti sono le previsioni sulla costituzione politico-nazionale di tali popolazioni, sospesa fra le opzioni di una Federazione (come quella jugoslava fondata da Tito) o di piccoli “staterelli” sotto l’influenza di potenze straniere.
“Dirò così di passaggio alcune parole sulla questione degli slavi del Sud. Da molto tempo – scrive Dostoevskij – le voglio dire. Adesso da noi hanno cominciato tutti a parlare di una pace vicina e della possibilità di risolvere velocemente la questione. (…) Naturalmente, è difficile stabilire nei dettagli la forma concreta in cui questa loro libertà si potrà esprimere, almeno in un primo momento, se in forma di una qualche Federazione di tribù slave minori o se in forma di piccoli Stati al cui trono si troveranno dei governanti chiamati da diverse dinastie. Altrettanto non si può prevedere se la Serbia vorrà allargare il proprio territorio, se l’Austria cercherà di evitarlo, quanto sarà grande la Bulgaria e cosa ne sarà della Bosnia e dell’Erzegovina (…). Se, infine, tutti questi Stati saranno pienamente indipendenti o non saranno piuttosto sotto la sorveglianza di un ‘concerto di potenze europee’ fra cui la Russia (io penso che questi piccoli popoli pregheranno loro stessi di essere sotto il tetto di un concerto europeo, magari insieme con la Russia, ma per essere in questo modo difesi dall’amore russo per il potere)”.
Secondo Dostoevskij, ogni previsione è “impossibile a farsi”, ma la storia insegna che una quarantina di anni dopo sarebbe scoppiata proprio a Sarajevo la Prima guerra mondiale, con l’attentato all’Arciduca d’Austria commesso dal serbo Gavrilo Princip. All’indomani della Grande guerra, sarebbe stato proprio il Regno dei serbi ad espandersi fino a comprendere sloveni e croati. Dopo il secondo conflitto, infine, sotto il Maresciallo Tito sarebbe sorta una Federazione durata fino allo scoppio delle guerre jugoslave e alla nascita di diversi Stati autonomi. In quel 1877, secondo lo scrittore russo, “si possono tuttavia sapere due cose: la prima è che gli slavi della Penisola balcanica alla fin fine saranno liberati dall’influsso turco”. La seconda è proprio quella che “da tempo volevo dire”. Secondo Dostoevskij, la Russia “non avrà mai e mai ha avuto” persone così capaci di odiarla, di invidiarla, di parlarne male “e persino nemiche” come le tribù slave meridionali. L’affermazione suona come un paradosso per popoli che si sono sempre rivolti a Mosca come ad un punto di riferimento originario, per legami storici e di sangue: un esempio ne è la Serbia che in quel momento, come la Bosnia, subiva il dominio turco. “Forse per l’intero secolo a venire, e anche oltre, avranno ininterrottamente paura per la propria libertà e delle brame di potere russe. Si rivolgeranno agli Stati europei, estenderanno male parole ed intrighi contro la Russia”. La paura di fondo, secondo l’autore, è di essere “immediatamente inghiottiti” da Mosca, ovvero da un “Impero” che potrebbe ambire al riassorbimento di tutti i popoli slavi sotto il proprio tetto.
Dostoevskij si oppone a questa visione della Russia, la quale anzi “si deve preparare all’eventualità che questi slavi liberati si rivolgano verso l’Europa, fino alla perdita della propria identità infettandosi con forme politiche e sociali europee. (…) Deve passare così un lungo periodo di europeismo prima che comprendano la loro essenza (…). Questi Paesi litigheranno sempre fra di loro, si invidieranno sempre gli uni con gli altri e trameranno gli uni contro gli altri. E, si capisce, nel momento della maggiore sventura si rivolgeranno sempre alla Russia per ricevere aiuto”. Il “pan-slavo” Dostoevskij avrebbe forse condannato la politica “di mezzo” della Jugoslavia di Tito come pure la politica dell’odierna Serbia che guarda, secondo le parole del presidente Nikolic, “come una casa a due porte contemporaneamente a Oriente e a Occidente”, mantenendo legami saldi con il Cremlino e ponendo come “priorità in politica estera” l’adesione all’Ue. Secondo lo scrittore dell’Ottocento, questa tensione interna, tipica di tutte le popolazioni slave balcaniche, non potrà che portare piuttosto ad una “disintegrazione in pezzetti”di una regione alla perenne ricerca della propria identità.
“La Russia, e tutti qui lo sappiamo, si guarda bene dal pensare di estendere il proprio territorio verso gli slavi del Sud o dal farne dei governatorati. Tutti gli slavi del Sud però lo temono, e lo teme anche l’Europa. Dubiteranno di questo ancora per cent’anni. Ma che Dio salvi la Russia da certe mire”.
Fonte : Nedeljnik