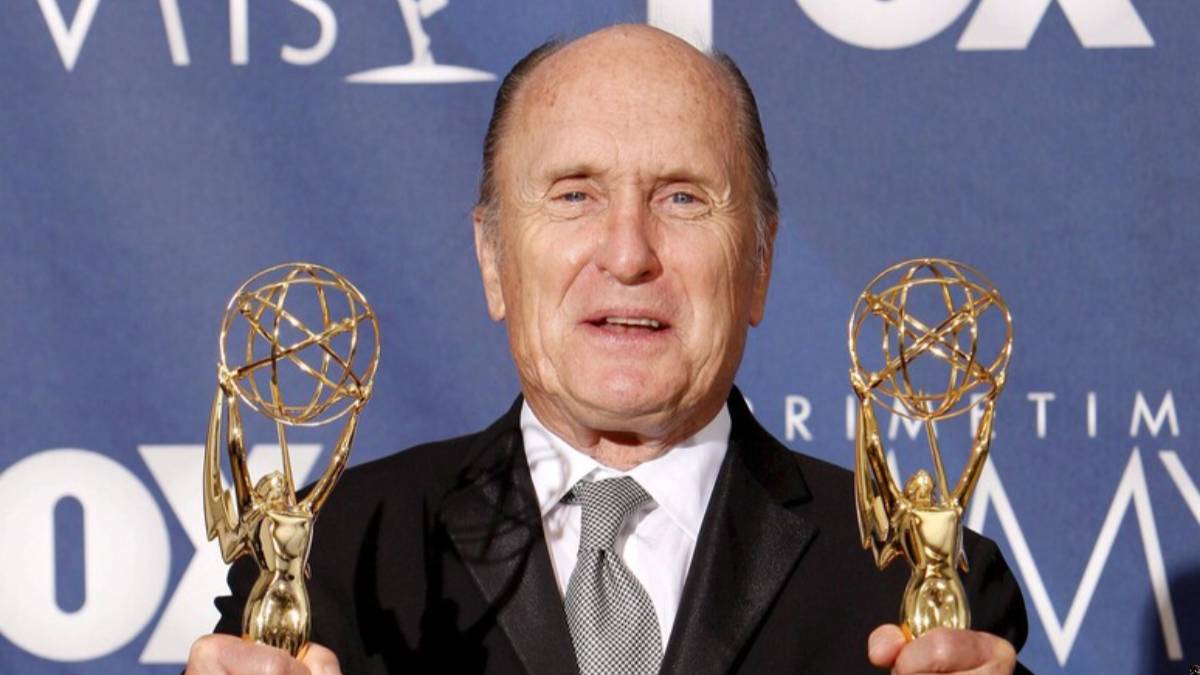Dopo la calda accoglienza ricevuta alla scorsa edizione del Festival di Locarno, e l’evento speciale tenuto alla Camera dei deputati, La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri sbarca nei cinema. Prodotto da Casa delle Visioni e Dschoint Ventschr, distribuito da Mescalito Film, il documentario del regista iracheno Samir ripercorre la storia dell’emigrazione italiana in Svizzera tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, istituendo un confronto tra quel drammatico passato e le dinamiche migratorie e sociali dei nostri giorni, in Svizzera come qui da noi. Ha debuttato nelle sale il 19 maggio all’Anteo di Milano, è approdato al Capitol di Bergamo il 20 maggio, il 21 all’Esperiadi Padova, il 22 allo Spazio Gloria di Como; sarà proiettato il 25 al Massimo di Torino, il 27 all’Astra di Firenze, il 2 giugno al Santo Spirito di Ferrara, il 5 giugno al Beltrade di Milano.
Prima di affrontare questa notevole opera, due parole sul regista. Nativo di Baghdad (1955), Samir si è formato come operatore di macchina, e ad oggi la sua filmografia assomma a oltre 40 titoli fra cortometraggi e lungometraggi. Insieme al documentarista Werner Schweizer, una trentina di anni fa rilevò la società di produzione Dschoint Ventschr Filmproduktion, che da allora sforna talenti nel cinema di oltreconfine. In Svizzera si trasferì bambino con i genitori, proprio nel momento di massimo afflusso di emigranti italiani che si riversarono in quel Paese in cerca di lavoro, finendone per costituire la maggiore manodopera nell’industria e nella cantieristica edilizia. Ha sperimentato sulla sua pelle le discriminazioni, i soprusi, la negazione dei diritti cui erano sottoposti i lavoratori stranieri in un Paese all’epoca scopertamente xenofobo, e ciò avvalora l’alto contenuto di verità del suo documentario.
Il film si apre con un concetto fondamentale della Dichiarazione universale dei diritti umani, “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese”, e principia in modalità autobiografica, con la voce narrante (di Lino Musella) che racconta la storia di un rifugiato iracheno comunista (il padre di Samir) in Svizzera. Quindi, attraverso materiali d’archivio (fotografie, documentari e reportage d’epoca, brani di film), testimonianze di lavoratori, sindacalisti, attivisti, disegni e animazioni, Samir intreccia storia personale e memoria collettiva per disseppellire dall’oblio le drammatiche vicende di milioni di italiani e di altri Paesi – contadini, braccianti, operai – che lasciarono le proprie terre in cerca di occupazione e di prospettive di vita più decenti, affrontando lavori massacranti, discriminazione, isolamento, razzismo.
Siamo così proiettati nel ventennio Cinquanta-Settanta del secolo passato, periodo cruciale per l’Europa, segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali. Il fenomeno migratorio è stato massiccio: nel 1962, una persona su cinque in Svizzera era straniera, il Paese aveva ricevuto oltre un milione di immigrati stranieri, che contribuirono grandemente alla sua prodigiosa crescita economica.
Ogni aspetto viene indagato, tramite l’esperienza di un gruppo di operai italiani, con i loro drammi quotidiani, le ardue sfide che dovettero affrontare. Attraverso le loro esperienze, il film esplora temi significativi come la xenofobia, la dignità del lavoro, le complessità dell’identità e dell’appartenenza. Nella Svizzera di allora (ma oggi accade lo stesso per migranti di altre etnie) gli immigrati erano esseri invisibili, servi privi di diritti, sottoposti a orari e condizioni proibitive, a pregiudizi, incomprensioni, emarginazioni.
Il film è diviso in nuclei tematici organizzati come capitoli: solitudine, necessità, miracolo economico, baracche, bambini clandestini (li chiamavano “bambini armadi”, poiché era lì che venivano nascosti quando arrivava la Fremdenpolizei, che si occupava dei visti, essendo negato il diritto al ricongiungimento familiare), riflusso, esclusione, la discriminazione dei bambini a scuola, le peculiari difficoltà che dovettero affrontare le donne, la loro esperienza di emancipazione lavorativa e sociale, l’irruzione del ’68, le grandi manifestazioni e i movimenti politici degli anni ’70, lo spionaggio verso gli attivisti (dossierati dalla polizia federale e non di rado espulsi), la crisi economica di quel decennio (nel 1975 furono licenziati 350.000 lavoratori, che rientrarono in Italia o continuarono il loro pellegrinaggio altrove), le colonie libere italiane, l’autorganizzazione e le lotte per i diritti civili e alla formazione, i luoghi d’incontro, la trasformazione seguita alla globalizzazione, la “vittoria” dell’italianità intesa come cultura.
Si rievocano eventi epocali, come la tragedia di Mattmark (1965), in cui per una slavina persero la vita 88 immigrati impegnati nella costruzione di una diga, uno scandalo anche per ciò che avvenne in fase processuale, dove i responsabili furono tutti assolti, e in appello i familiari delle vittime furono condannati al pagamento di metà delle spese processuali.
Ci si sofferma sul lessico razzista e xenofobo che circolava nel dibattito pubblico e nella politica (esisteva un partito anti-italiani che propugnava l’espulsione dei nostri concittadini, venivano indetti di continuo referendum per vietare loro i diritti fondamentali), come la parola Überfremdung (l’infiltrazione straniera): gli italiani furono vittime di un apartheid silenzioso, con tanto di ingressi vietati nei ristoranti e nei locali pubblici, soggetti allo stereotipo degli stranieri con il coltello in tasca. Furono poi vittime di aggressioni, anche violente, come l’omicidio di Alfredo Zardini, raccontato dal film di Tutsi Hall Tutte le domeniche mattina (1972): Zardini fu massacrato di botte fuori da un pub di Zurigo il 20 marzo 1971 da un sostenitore del movimento razzista. Giacque ferito sul marciapiede, nessuno gli prestò soccorso.
Ma Samir non si limita a ricostruire con puntuale filologia un tempo scomparso: il recupero di memorie così drammatiche acquisisce maggiore pregnanza poiché si istituisce un parallelo tra quella lontana esperienza e l’oggi, tra il contesto di industrializzazione capitalista di quegli anni e il mercato del lavoro globalizzato e iperliberista dei nostri giorni.
Nel linguaggio dell’epoca esisteva la classe operaia: un’identità collettiva, solidale, che si trasforma in soggetto politico portando avanti un progetto di cambiamento sociale. Definizione e concetto scomparsi, sostituiti da una nuova etichetta: “stranieri”, figure frammentate e marginalizzate a cui è negato ogni diritto. Dunque, “i migranti di oggi non costruiscono solo case: ci costringono a guardare in faccia chi siamo stati e cosa stiamo diventando”. I cosiddetti “richiedenti asilo” in Svizzera hanno preso nell’immaginario il posto degli italiani degli anni ’60, considerati con i medesimi stereotipi negativi riservati ai primi e privi di ogni tutela: soltanto nel 2002 è stato abrogato lo schiavistico statuto dei lavoratori stagionali, però mantenuto per i lavoratori provenienti dal terzo mondo.
In Italia la situazione è altrettanto disastrosa. Quel che accadeva un tempo nemmeno troppo lontano in Svizzera, avviene oggi qui da noi, con lo sfruttamento schiavistico di mano d’opera da parte di italiani, con la piaga del caporalato, di donne uomini e bambini provenienti dall’Africa e da Paesi disagiati. Il documentario termina con la struggente testimonianza dell’attivista e scrittore camerunense Yvan Sagnet, e con lo sciopero che gli immigrati raccoglitori di pomodori misero in atto in Puglia, fondando poi una cooperativa per affrancarsi. Il film di Samir invita quindi a riflettere sul paradosso di un’Italia mutata da terra di emigranti a paese di immigrazione, ma incapace di riconoscere nei nuovi arrivati la propria drammatica storia. Come è possibile, si chiede Sagnet, che proprio gli italiani, soggetti per secoli al razzismo e alla discriminazione, agiscano così? Già, com’è possibile?“L’umanità è incomprensibile” è la sua desolata chiosa. Lo è, e opere di questo genere sono preziose. Andrebbero diffuse ovunque, proiettate nelle scuole, affinché ci inducano a non dimenticare, a riflettere sui nostri lati oscuri, magari a recuperare quel brincello di umanità che in teoria ci differenzia dalle bestie.
Argomenti: Cinema