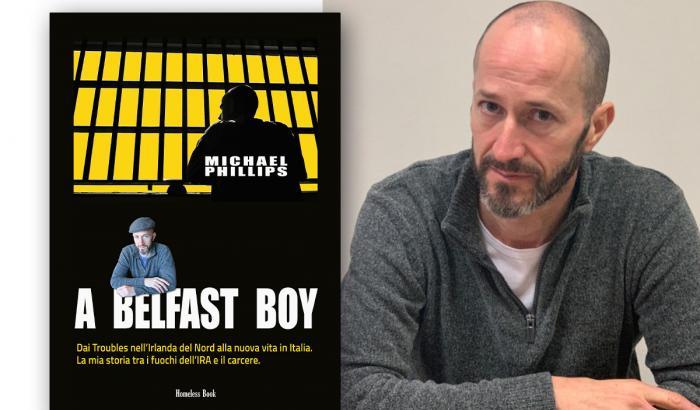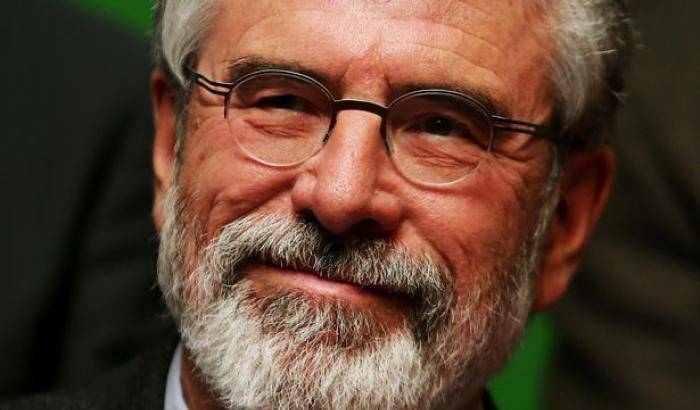di Rock Reynolds
Non è una vicenda nota al pubblico italiano. Eppure, cinquant’anni fa, il massacro della Miami Showband, un gruppo musicale popolarissimo in Irlanda, fece grande scalpore in patria così come pure in Gran Bretagna. Tre giovani vite spezzate senza il minimo senso sul ciglio di una strada di campagna, dopo aver regalato gioia a un locale stracolmo di gente appena a nord del confine tra la Repubblica di Irlanda e l’Ulster britannico. Tre giovani vite spezzate, ma pure altre vite che sarebbero rimaste segnate indelebilmente nel fisico tanto quanto nell’anima dei superstiti. Un episodio che si incastona su un fosco scenario di settarismo religioso che, soprattutto negli anni Settanta, insanguinò il travagliato Ulster, dimostrando al mondo quanto un odio per ragioni socioeconomiche mascherato da contesa religiosa possa avere strascichi incancellabili. Era l’odio dei cattolici per i protestanti aggrappati a privilegi secolari loro concessi dal colonizzatore britannico e quello dei protestanti per i cattolici, nel timore di perdere quegli stessi privilegi in favore di un sistema più equo.
Cinquant’anni fa, esattamente il 31 luglio, si compiva questo scempio. Non un fatto di per sé isolato, come si diceva, ma un atto di violenza gratuito, volutamente plateale per la popolarità delle vittime in esso coinvolte. Insomma, un’esecuzione vera e propria che intendeva fungere da monito alla comunità cattolica e all’IRA, peraltro inizialmente e artatamente accusata della strage, nel tentativo di spegnerne la sete di rivalsa.
Il giorno in cui morì la musica (Milieu, pagg 334, euro 20) di Riccardo Michelucci, un profondo conoscitore della questione irlandese, racconta con dovizie di particolari non solo e non tanto quel massacro ma l’ambiente in cui era maturata la scelta di compierlo e la reazione dell’opinione pubblica. Nonostante la scarsa attenzione rivolta a tale episodio dai mezzi di informazione italiani, il libro di Michelucci riesce ad avvincere il lettore e fornisce ottimi strumenti di conoscenza anche a chi è totalmente a digiuno di informazioni sul contesto storico dell’Irlanda del tempo.
Lei ha scelto un episodio che fece molto scalpore in Irlanda e in Gran Bretagna, ma che sostanzialmente passò inosservato nel nostro paese. Perché?
«All’epoca le notizie che arrivavano nel nostro paese dall’Irlanda erano sempre filtrate da Londra e dalle agenzie britanniche. Per l’intera durata del conflitto anglo-irlandese, dunque per quasi tre decenni, nessun grande giornale italiano si degnò di avere un corrispondente da Belfast, mentre gli inviati stavano spesso comodamente a Londra. In questo quadro non può stupire che la strage della Miami Showband, al pari di molte altre atrocità che coinvolsero l’esercito britannico, non abbia praticamente avuto alcun risalto in Italia e la storia sia arrivata quasi sconosciuta fino ai giorni nostri.»
Le connivenze tra forze lealiste, servizi segreti britannici, fanatismo religioso di stampo quasi fascista nell’Ulster e la strategia della tensione in Italia, con una Chiesa cattolica timida verso i nuovi slanci neofascisti, le bombe e i depistaggi mi sembrano un modus operandi dell’internazionale fascista…
«Indubbiamente. E aggiungerei che la paura nei confronti dei “terroristi” irlandesi ricorda molto quella che, ai giorni nostri, viene alimentata nei confronti dei gruppi palestinesi. Con un’aggravante tragica e grottesca: a quei tempi, venivano considerati terroristi solo i membri dell’IRA mentre si minimizzava o si sorvolava sulle attività dei paramilitari lealisti protestanti – spesso collusi con l’esercito e i servizi segreti britannici – sebbene questi si siano resi responsabili di gravissimi atti di violenza contro i civili. Penso alle bombe di Dublino e Monaghan del maggio 1974, che racconto anche nel libro, e che furono perpetrate dagli stessi autori della strage della Miami Showband.»
Svolgendo le sue ricerche sul massacro e facendo alla gente domande sulla Miami Showband, che idea si è fatto della passione popolare per quella band?
«Erano un gruppo famosissimo e molto amato che ha segnato intere generazioni di irlandesi. Se avessero potuto contare sulla forza che oggi hanno televisione, Internet e social media, sarebbero diventati molto probabilmente delle star planetarie. Il loro contributo all’esplosione del rock irlandese avvenuto a partire dai primi anni Ottanta è stato riconosciuto anche in un recente documentario andato in onda sulla tv nazionale irlandese e condotto da Adam Clayton, bassista degli U2.»
Lei è stato ripetutamente nei luoghi della tragedia e in buona parte dell’Irlanda. Malgrado il massacro della Miami Showband sia avvenuto cinquant’anni fa, ha incontrato resistenze, omertà?
«Non mi sono mai imbattuto direttamente in omertà anche perché mi sono limitato a intervistare testimoni, sopravvissuti e attivisti per i diritti umani impegnati nel caso. Però posso dire che sulla scena dell’attentato, dove sono stato più volte, si respira ancora appieno un clima pesante di negazionismo dovuto al fatto che quella è ancora una zona fieramente lealista, che preferisce dimenticare gli orrori che tanti anni fa sono stati perpetrati in suo nome.»
Gli Accordi del Venerdì Santo sono stati un momento epocale. Eppure, la pacificazione non è certo totale. Ci sono irriducibili cattolici che, pur avendo rinunciato definitivamente alla lotta armata, pensano che la pace sia un’onta sul movimento repubblicano e che abbia svenduto le enormi sofferenze a cui molti combattenti si sono sottoposti. Lei che ne pensa?
«Da osservatore esterno non voglio dare giudizi sugli esiti di una lotta che ha spezzato il cuore, il corpo e l’anima di intere generazioni. Però posso dire che capisco perfettamente e ho il massimo rispetto per le perplessità di certi dissidenti che non sono soddisfatti della forma che ha preso questa pace e ritengono che i propri ideali siano stati in parte traditi.»
Da conoscitore dell’Irlanda, che sensazioni le trasmette il paese? Crede davvero che la pacificazione sia compiuta? Oppure pensa che le violenze e i relativi lutti siano ancora troppo vicini e che una vera composizione non possa mai esserci finché l’Irlanda non tornerà a essere un paese unificato?
«Penso da tempo, e continuo a esserne fermamente convinto, che la guerra sia davvero finita. Ma credo anche che nei 27 anni che sono trascorsi dalla firma dell’accordo di pace siano stati fatti troppi pochi sforzi per creare una memoria condivisa di quanto accaduto in passato. Il percorso giudiziario che è stato intrapreso con lo svolgimento di tanti processi ai colpevoli (penso in primo luogo a quello ben noto sulla “Bloody Sunday” di Derry del 1972) sono stati in larga parte delle occasioni perdute perché il governo britannico non ha voluto riconoscere fino in fondo le proprie responsabilità. E la recente legge varata da Londra per garantire l’amnistia a tutti i colpevoli e chiudere tutti i procedimenti ancora aperti non farà che aggravare la situazione, cercando di cancellare il passato con un colpo di spugna.»
Come ha iniziato ad appassionarsi alla questione irlandese?
«Quando ho capito che la lotta irlandese è davvero una lotta universale, come diceva sempre un grande maestro e amico: Giulio Giorello. Per me la miccia si è accesa quando ero giovane, negli ultimi anni del conflitto, e da attivista assiduo di Amnesty International, cominciai a seguire a fondo una questione che all’epoca era al centro delle cronache internazionali.»
Non sapevo, prima di leggere il suo libro, che Bono nel 1974 evitò quasi di un soffio di restare coinvolto nelle devastanti bombe lealiste nel centro di Dublino. Sappiamo che proprio a una canzone sui Troubles, “Sunday Bloody Sunday”, si deve il lancio dei suoi U2. Eppure, nel movimento repubblicano sono in parecchi a criticarne la scarsa esposizione politica. Che gliene pare?
«Nel corso degli anni Bono ha fatto storcere la bocca a molti per un’attenzione a cause politiche e umanitarie che a volte sono apparse artefatte e funzionali al suo divismo. Penso però che nella fase decisiva del processo di pace, nella primavera del 1998, gli U2 abbiano avuto un ruolo importante che è stato riconosciuto anche da alcuni dei principali leader politici dell’epoca.»
Ha parlato con qualche superstite?
«Non ho avuto occasione di incontrare i sopravvissuti alle bombe lealiste di Dublino e Monaghan del maggio 1974. Ma ho intervistato a lungo Margaret Urwin, presidente dell’associazione Justice for the Forgotten che da molti anni si batte per la verità e la giustizia in quelle e in altre stragi.»
Lei pensa che il paese voglia mettersi la storia fosca alle spalle? Il paradosso assoluto è che buona parte dei modelli culturali seguiti è di matrice britannica…
«Tra le due isole esiste un legame profondo radicato nel corso dei secoli. I modelli culturali seguiti dall’Irlanda di oggi sono quelli britannici e occidentali in senso ampio, ma trovo da sempre piuttosto curioso che in una parte dell’opinione pubblica ci sia un orgoglioso desiderio di rivincita nei confronti del vicino britannico, ma che, al tempo stesso, a Dublino si stenti ancora ad accettare la lotta repubblicana condotta nel Nord negli ultimi decenni del XX secolo, che questa non sia ancora considerata la degna e naturale prosecuzione della Rivolta di Pasqua del 1916, ovvero l’evento storico fondante della moderna nazione irlandese. In questo senso spero che con il tempo anche nella Repubblica d’Irlanda vengano storicizzate grandi figure rivoluzionarie contemporanee (penso in primo luogo a Bobby Sands), riconoscendo appieno la loro importanza.»
Quali elementi comuni si sente di individuare fra la questione irlandese e quella palestinese?
«Le analogie sono molte e non è un caso che tra irlandesi e palestinesi esista da sempre una grande vicinanza e solidarietà. L’Irlanda è una delle nazioni più filo-palestinesi del mondo, non soltanto per quanto concerne l’opinione pubblica ma anche nelle istituzioni. Il motivo è radicato nella comune esperienza di colonialismo e violenza settaria che entrambi i paesi sono stati costretti a subire. Peraltro, in entrambi i casi sono stati gli inglesi la causa principale del problema. Per lunghi anni la popolazione dei ghetti cattolici dell’Irlanda del Nord ha subito una forma di discriminazione che ricorda quella a cui sono soggetti i palestinesi. A ulteriore conferma di questa equazione di stampo puramente coloniale c’è quanto accade anche ai giorni nostri nei quartieri lealisti filo-britannici di Belfast e di altre località dell’Irlanda del Nord, in cui sventolano le bandiere israeliane per ribadire l’alleanza suprematista e l’unità di intenti tra invasori.»