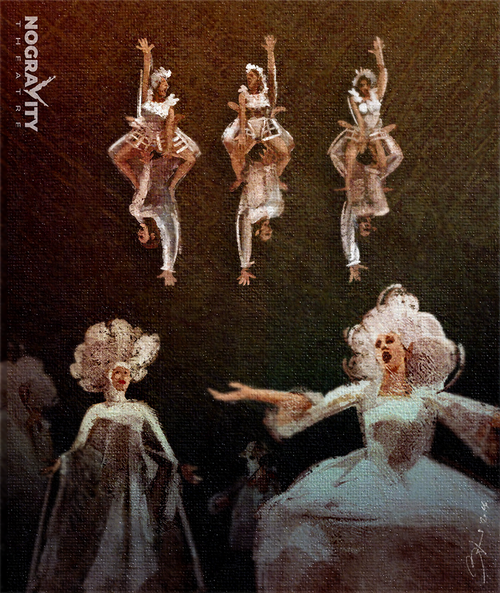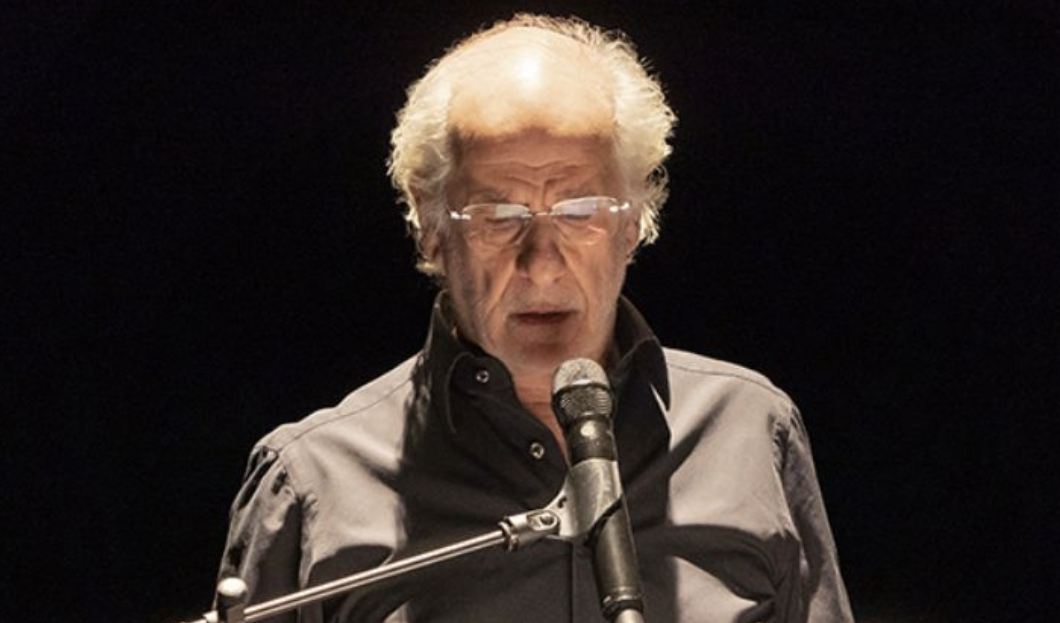di Alessia de Antoniis
Al Festival Terreni Creativi di Albenga, Ermelinda Nasuto ha condiviso con il pubblico la materia prima di quello che diventerà uno spettacolo. Non ancora una drammaturgia compiuta, ma gli appunti di questi giorni, come recita il sottotitolo, di un’esperienza che chiede di essere raccontata: la diagnosi di un carcinoma mammario a quarant’anni, in mezzo a un laboratorio teatrale.
Il progetto nasce da un’idea condivisa con Francesco Alberici, ed è portato in scena da Nasuto insieme a Olga Durano, in quella che si presenta, fin dal titolo, come una prima tappa di lavoro. Quello che abbiamo visto è teatro allo stato nascente, nella sua forma più elementare e necessaria: una donna che ha bisogno di dare forma scenica al proprio vissuto. La forza di questo work in progress risiede proprio nella sua incompiutezza dichiarata, in quella tensione tra il privato che diventa pubblico e la ricerca di una forma artistica che ancora si sta definendo.
Nasuto si muove sulla soglia tra confessione e performance, costruendo un discorso che alterna momenti di estrema intimità – dal momento della diagnosi io mi sono percepita come doppiata – a digressioni che sembrano procrastinare l’arrivo al cuore del dolore. È una dinamica che rispecchia fedelmente il modo in cui la mente si muove attorno al trauma: avvicinandosi e scartando, con la precisione di chi sa e la vaghezza di chi teme. Il linguaggio scelto è volutamente anti-letterario, colloquiale fino alla disarmonia: Tu hai mai ballato sui Daft Punk? Eh, allora mi capisci. Una scelta di campo netta, che rifiuta ogni retorica della malattia, ogni sublimazione poetica del dolore. E proprio in questa apparente semplicità, nelle esitazioni, nelle correzioni, nei ripensamenti, emerge una voce. Vera, cruda, scomposta.
Il racconto si fa via via più concreto. Le relazioni diventano materia narrativa. Colpisce il fastidio nel farsi fotografare – perché non voglio che questa fotografia un giorno serva a voi che rimanete, a dire ecco vedi, qui c’era anche Ermelinda – un rifiuto profondo di essere ridotta alla propria malattia, un atto di resistenza silenziosa contro la cristallizzazione del ricordo. E poi la difficoltà a comunicare la diagnosi agli amici, la sensazione di non poter vomitare addosso le mie angosce. Ma è proprio l’incapacità di piangere – nonostante la voglia di spaccare le cose – a diventare una chiave emotiva importante: una strategia di sopravvivenza che bypassa il lamento e si affida alla rabbia, al gesto, alla scena.
Il momento di massima intensità arriva con la mappatura ossessiva del quotidiano malato: i prelievi ogni sette giorni, i globuli da monitorare, il PIC che impedisce il bagno, l’Accofil da 93 euro a dose, e quel pensiero semplice, crudele, pensa, se li dovessimo pagare noi. È qui che il corpo smette di essere solo biografia e si fa corpo sociale. Attraversato da protocolli, numeri, liste di attesa, esclusioni. La mascherina – quando ho troppa voglia di abbracciare qualcuno – diventa una metafora involontaria ma potentissima: il desiderio trattenuto, la prossimità rimandata.
E poi c’è l’ode. L’elenco finale dei farmaci – Adriblastina più ciclofosfamide ad alti dosaggi, poi desametasone, famotidina… – trasformato in un canto, con una musica un po’ elettronica. È lì che la lingua clinica si fa teatro, mantra, parodia e preghiera insieme. Un momento di invenzione scenica che vibra più forte di tutti gli altri, perché è lì che la materia autobiografica si fa davvero drammaturgia.
Ma, come ogni prima tappa, anche questa porta con sé nodi ancora da sciogliere. La tensione tra il bisogno di raccontarsi e la costruzione di un’opera teatrale resta irrisolta. Il rischio dell’autocompiacimento narrativo è presente, così come quello di una certa dispersività che può allontanare lo spettatore. La presenza di Olga Durano, importante ma per ora appena accennata, sembra suggerire una ricerca in corso: un dialogo possibile, un dispositivo da costruire, un’interazione che potrebbe portare il racconto fuori dal perimetro del monologo.
Il debutto previsto a La Spezia per gennaio sarà un passaggio decisivo. Alberici e Nasuto dovranno compiere scelte precise: mantenere la dimensione confessionale o cercare una maggiore teatralizzazione? Sviluppare la presenza scenica di Durano o concentrarsi sulla sola voce dell’attrice? Stringere la struttura narrativa o difendere la fluidità associativa che è, forse, la cifra più autentica di questo primo tentativo?
La direzione giusta potrebbe essere quella di non tradire l’autenticità di questa prima condivisione, trovando invece gli strumenti scenici per amplificarla senza snaturarla. Dedicato ha il merito di toccare un nervo scoperto, ma deve ancora trovare il coraggio di trasformare la materia autobiografica in drammaturgia. Il però che bello vivere che l’autrice spera arrivi al pubblico rischia di rimanere sospeso, se non trova un impianto scenico capace di renderlo pienamente percepibile.
Un lavoro da seguire, sì, ma con l’aspettativa che sappia crescere oltre la propria origine testimoniale. Il teatro della malattia ha senso solo se riesce a parlare di vita. E per farlo, deve accettare di essere, prima di tutto, teatro.