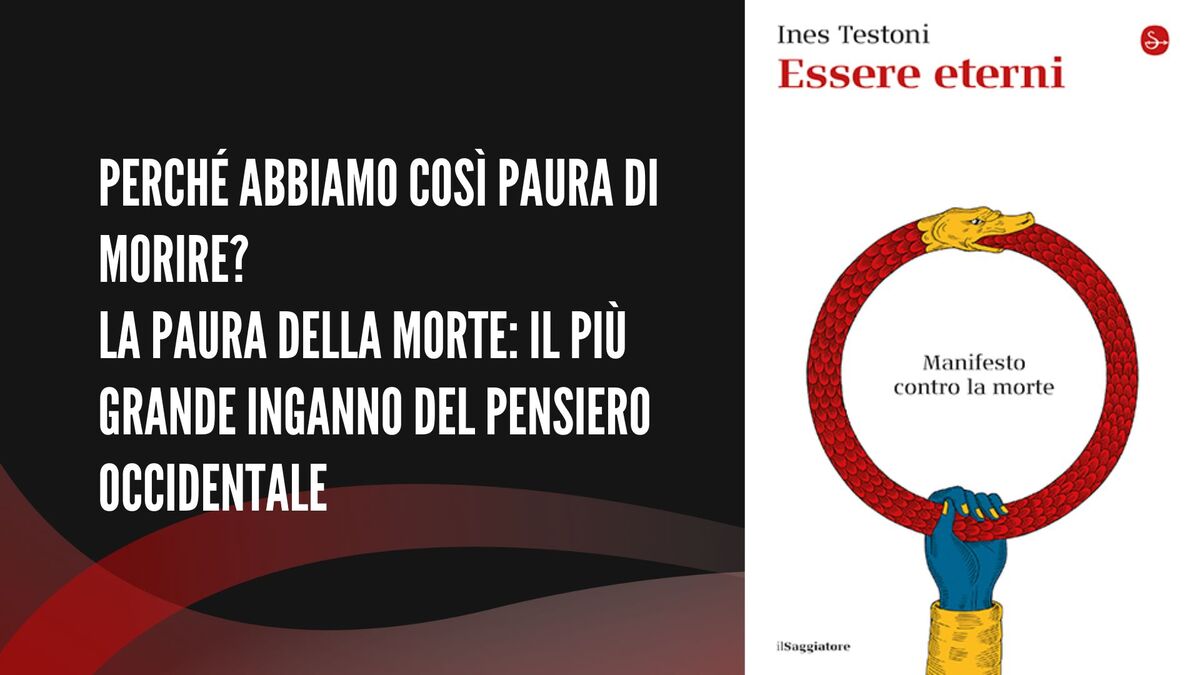Nel nuovo libro, Ines Testoni sfida l’idea di annientamento con la filosofia di Severino
C’è una domanda che attraversa tutto il nuovo libro di Ines Testoni: perché abbiamo così paura di morire? La risposta che propone l’autrice, già nota per “Il grande libro della morte“, è tanto semplice quanto radicale: perché crediamo nell’impossibile, cioè che la morte ci possa annientare. Ma se l’essere è eterno e non può diventare nulla, come sostiene il filosofo Emanuele Severino, allora tutto cambia.
“Essere eterni. Manifesto contro la morte” (Il Saggiatore, 2025) non nasconde le sue intenzioni: è un libro militante, che vuole smontare quello che considera il più grande inganno del pensiero occidentale. Testoni parte da un’idea precisa: il terrore della morte è alla radice delle nostre angosce e il terreno su cui attecchiscono tutte le forme di controllo: religioso, politico, sociale.
Il ragionamento procede per gradi. Se davvero comprendiamo che siamo “già da sempre salvi” perché l’essere non può diventare nulla, crolla l’intero edificio costruito sulla promessa di salvezza. Le religioni che ci chiedono obbedienza in cambio della vita eterna, le ideologie che danno senso attraverso il sacrificio, persino la scienza che promette di sconfiggere la morte: tutto si rivela illusorio se partiamo dal presupposto che non c’è niente da cui salvarsi.
L’autrice presenta questa tesi attingendo a un ampio repertorio filosofico – da Spinoza a Nietzsche, da Freud a Marx – e intrecciando teoria e memorie personali. Racconta le occupazioni studentesche, i dibattiti con un’amica che chiama “Ipazia”, i film di Pasolini, alternando questi ricordi a citazioni dense e analisi complesse. È un modo efficace per rendere più accessibili concetti non semplici.
Particolarmente interessante è l’analisi di fenomeni contemporanei come i populismi o le teorie del complotto. Testoni li legge attraverso la lente dell’angoscia di morte: QAnon, le “scie chimiche”, la ricerca di capri espiatori, diventano manifestazioni della nostra incapacità di pensare l’eternità. Quando non sappiamo affrontare la paura fondamentale, cerchiamo spiegazioni semplici a fenomeni complessi e finiamo per essere manipolati.
Il linguaggio del libro riflette questa duplice ambizione teorica e divulgativa. Testoni alterna termini tecnici (“sub specie temporis”, “ontologia immanentista”) a metafore efficaci (“braciere del terrore”, “passioni tristi”). Introduce anche un neologismo, “Diə” con la schwa, per indicare una concezione del divino libera dalle connotazioni patriarcali. È una scelta che ha un peso sia filosofico che politico.
Ma proprio il carattere militante dell’opera ne costituisce anche il limite principale. Testoni sceglie le sue fonti in funzione della tesi da dimostrare: privilegia pensatori europei coerenti con l’argomentazione — “Spinoza, Nietzsche, Severino sono i compagni di strada indispensabili” — mentre trascura visioni alternative o correnti interne alle religioni che critica. La parte dedicata a smontare le illusioni è molto più sviluppata di quella che propone alternative concrete: all’ampio capitolo in cui “le religioni… mantengono acceso il braciere del terrore” fa da contrappunto un’unica sezione costruttiva centrata sull’ontologia severiniana.
Inoltre, il libro tende a trattare le religioni come blocchi monolitici, riducendo lo spazio per forme di spiritualità che non rispondano al modello oppressivo descritto. Il modernismo cattolico, ad esempio, viene citato di passaggio come “illusione interna al sistema” e subito archiviato, senza indagarne il potenziale riformista.
Sul piano metodologico, il testo alterna concetti derivati dalla psicologia sociale e dalla filosofia morale — dalla Terror Management Theory alle “passioni tristi” di Spinoza — a conclusioni ontologiche sull’eternità dell’essere, come quando, dopo aver descritto la “tendenza innata alla pareidolia” e il “groupthink” come meccanismi di conformismo, approda alla tesi che “solo chi sa di essere eterno può liberarsi dal terrore”. Il passaggio è coerente con la logica interna del libro, ma resta implicito il ponte argomentativo tra i dati comportamentali e l’assunto metafisico: un salto importante, che il lettore non specialista potrebbe percepire come brusco.
La densità del linguaggio, pur coerente con l’ambizione dell’opera, rischia di risultare impegnativa. Chi non ha familiarità con il lessico filosofico potrebbe trovare ostacoli in un testo che pure ambisce a trasformare la coscienza comune. È il paradosso di molti “manifesti”: vogliono cambiare il mondo, ma si rivolgono principalmente a chi ha già gli strumenti per capirli.
Resta il fatto che Testoni affronta questioni centrali con strumenti concettuali rigorosi. In un’epoca dominata dall’ansia, propone una via d’uscita che non passa attraverso consolazioni facili ma attraverso un “esercizio di morte” inteso come liberazione dall’ossessione della finitudine. Non tutti accetteranno le sue conclusioni, ma difficilmente si potrà ignorare la radicalità delle domande che pone.
Il risultato è un’opera ambiziosa che si colloca tra filosofia, critica sociale e pamphlet politico. I suoi limiti metodologici non cancellano il valore di un tentativo di pensare diversamente la morte in un’epoca che sembra aver smarrito gli strumenti concettuali per farlo.