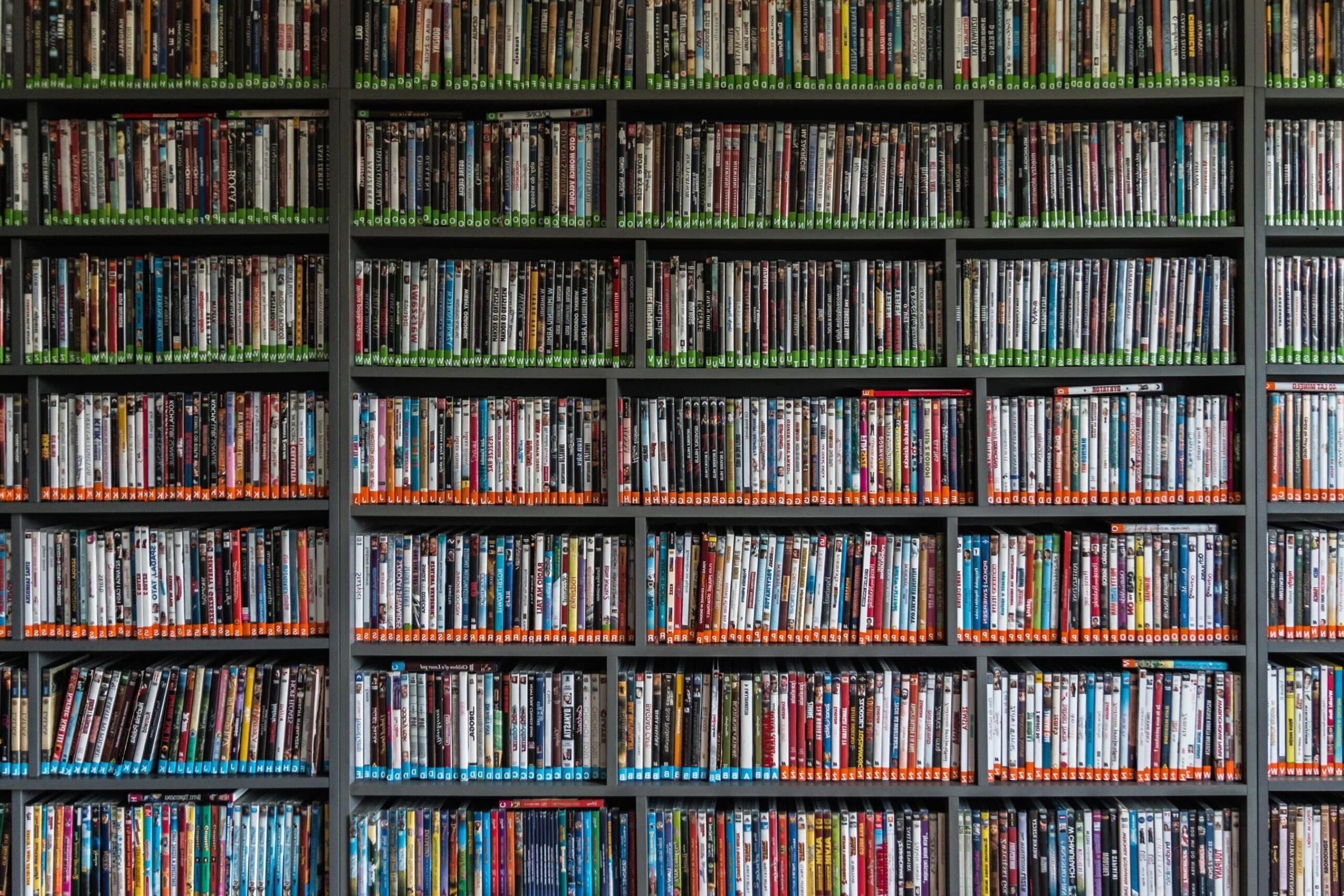di Antonio Salvati
L’ultimo romanzo di Elvira Serra, Le voci di Via del Silenzio (Solferino 2025 pp. 256 € 18), è un insieme di storie d’amore. Quella dei genitori adottivi di Luca – «arrivato come un dono, un gesto d’amore» – la cui adozione fu trasformata da un abbandono in un dono. Quella di Giulia – altra protagonista della vicenda – per la propria professione di giornalista e, in seguito, per Renzo fotoreporter. E, infine, l’amore – che rappresenta il “fil rouge” di tutto il volume – per la vita contemplativa. Sono queste vicende a rendere il libro di Serra avvincente e a favorire nel lettore quel senso di immedesimazione, fin dalle prime righe, con i protagonisti, facendo propri, immersi negli eventi, le loro domande, i loro dilemmi. Del resto, i romanzi non vanno letti solo per vedere come terminano. Anche per trovare risposte, indicazioni per la propria vita.
Potremmo dire che tutti i protagonisti del volume sono alla ricerca, pur nella loro irrequietezza, di un senso da dare alla propria esistenza, senza tralasciare le scelte compiute, gli egoismi o gli slanci che le hanno motivate, l’idea di felicità e sulla possibile permanenza di quella felicità oltre la contingenza.
Elvira Serra aveva scritto per il Corriere della Sera un reportage sull’Abbazia benedettina Mater Ecclesiale, sull’isola di San Giulio, non distante da Milano. Aveva trascorso più di una giornata all’interno del monastero di clausura per comprendere come si possa scegliere di vivere in un convento, in preghiera, lontane da tutto e da tutti. Quest’esperienza ha certamente favorito la nascita del romanzo.
Luca, giovane autore di podcast di successo, raggiunge il convento per intervistare la Madre Badessa, per sapere soprattutto cosa induce a vivere tra le mura di un convento di clausura, assorta in un’attività «inutile» come quella della preghiera? La Madre Badessa, ossia Giulia, non esita a raccontare la sua precedente vita di ex giovane inviata, che ha avuto l’opportunità di raccontare gli eventi più importanti di cronaca e storia, dall’attentato a Giovanni Paolo II all’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. E confida anche le prime crepe di una vita frenetica, seppur piena di soddisfazioni, della sua vita di giornalista: «le domande che mi rimbalzavano nella testa riguardavano quella rincorsa continua, l’inseguimento di un servizio dopo l’altro senza mai chiedermi cosa volessi io da me, non gli altri, come se la strada da seguire fosse una soltanto e non potessi deragliare se non distruggendo quanto avevo costruito fin lì ogni giorno». Scatta il desiderio di fermarsi, di capire cosa fare della propria vita. Si reca in Abbazia e chiede ospitalità. «In monastero mi lasciai nutrire dal silenzio. Mi feci cullare dalle lodi e dai canti delle monache. Trovai significato nelle piccole mansioni che questa volta mi erano state affidate: spolverare i mobili, togliere le erbacce nel giardino, servire alla tavola gli altri pellegrini. Scoprii nell’abbazia un luogo amico, privo dell’urgenza costante che condiva la mia quotidianità a Milano. E fu difficile ignorare il senso di pace e di radicamento che provai in quei giorni. Una luce bianca sembrava avvolgere tutto, tenendomi al riparo da ogni preoccupazione. Ignorai, invece, la voce dentro di me che suggeriva di restare. Era un azzardo già solo ammettere di sentirla».
Direbbe Enzo Bianchi che i monaci sono quelli che comprendono la realtà e il mondo altrimenti. E siccome «comprendono altrimenti, vivono anche altrimenti». Non hanno uno scopo, se non quello di tentare di vivere il Vangelo, nella forma del celibato e della vita comune. I monaci non hanno nessuna funzione particolare nella chiesa. Per Alex Corlazzoli, giornalista che vissuto insieme un’esperienza monastica, i monaci vogliono essere una memoria della communitas, un antidoto alle forze centrifughe, disgreganti, individualistiche. Tutto è per loro comune, e la stessa personalità del singolo non deve diventare singolarità contro o senza gli altri. Quanto a ciò che dà senso a ogni vita umana, ossia l’amore, anche a questo riguardo i monaci vivono altrimenti. Essi decidono di amare l’altro prima di conoscerlo, mentre normalmente nella vita prima si conosce qualcuno e poi lo si ama.
La vita monastica, attraverso il suo ritmo quotidiano, ci abitua a rimanere in un luogo limitato ma aperto ad orizzonti vasti, allena i nostri occhi a scrutare la storia attraverso le Scritture, ci abitua ad accogliere ogni giorno il mattino e la notte, ci educa al discernimento, ci pone di fronte alla incompiutezza del nostro mondo, ci prepara ad un incontro.
Colpisce quanto narra Giulia in merito alla vita fraterna in convento. «” E tu, Giulia? Sei felice?” Avevo già le spalle al muro, ma lei non mi stava lasciando nessuna possibilità di fuga. “Sto cercando di capirlo”. “Stai pregando? La preghiera aiuta. Hai ancora il rosario che ti avevo regalato?” Avevo fatto sì con la testa. “Non so se ricordi, ti dissi che non mi serviva più”. “Come dimenticarlo. Non ho ancora capito perché hai usato quelle parole. Non è un controsenso?” “No. A me davvero non serviva più, in quel momento. Me lo aveva regalato la badessa durante il primo soggiorno a San Giulio. Sgranarlo tutti i giorni mi aveva aiutato a trovare le risposte dentro di me sulla chiamata. Quando te lo diedi, avevo già deciso che non sarei più tornata nello studio del commercialista per cui lavoravo. Comunicai le dimissioni quel giorno stesso. Incontrarti mi fu di grande aiuto, mi hai mostrato chi ero prima e chi ero diventata”. “Ma non è possibile che tu abbia smesso di recitare il rosario!” avevo esclamato. “Certo che no. Ma quando ti ho conosciuta, ho sentito di dover passare il testimone. Era più importante che lo avessi tu. Usalo, Giulia. Prega ogni giorno. Vedrai che tutto si chiarirà”».
E aggiunge: «Non riuscivo a capire come quella donna potesse leggermi nel pensiero e dirmi sempre le cose giuste al momento giusto. Quella totale comprensione, senza giudizio, fece breccia nel mio cuore e sentii sciogliersi la tensione accumulata in giorni, in mesi, in anni vissuti senza chiedermi perché facessi quello che facevo, perennemente di corsa, un servizio dopo l’altro, un turno di notte dopo l’altro, un appuntamento con Renzo dopo l’altro. «Provo un senso di fatica micidiale. La vita come l’ho vissuta finora non mi rende più felice» riuscii a dire singhiozzando. Si infilò una mano nella tasca e mi offrì un fazzoletto di stoffa bianco, con delle piccole rose ricamate ai bordi. Lasciò che mi sfogassi».
I monaci si esercitano a vivere in comune, a possedere in comune, a intraprendere tutto in comune, a legiferare insieme: in una parola, a vivere la fatica e la bellezza della fraternità. Tutti, indistintamente, fanno lavori manuali: cucinare, lavare i piatti, pulire le case, fare lavori nel bosco o nell’orto. Ciò che conta è che sono fratelli e sorelle, solidali, coinvolti in una stessa vicenda. Capaci e poco capaci, forti e deboli, sani e malati, bisognosi e meno bisognosi, i monaci sono tutti uguali in dignità e tutti devono sottostare agli stessi doveri e godere degli stessi diritti. È a partire da questa unità, vissuta nelle differenze, che i monaci tendono alla fraternità. Così facendo, giorno dopo giorno si esercitano nell’amore e si sentono un corpo, membra gli uni degli altri.
Tra Luca e la monaca si avverte all’inizio un’immediata distanza. Luca si chiede com’è possibile rinunciare alla vita mondana. La badessa candidamente risponde: «Tutti dal di fuori pensano a quello a cui rinunciamo, ma non pensano mai a quello che troviamo. Si rinuncia per trovare qualcosa di più prezioso che abbiamo scritto dentro, per colmare la nostra sete di felicità, di infinito». La domanda di Luca è comprensibile e ricorda quella rivolta dai discepoli a Gesù. Pietro dice ad alta voce quello che probabilmente tutti gli altri discepoli hanno pensato: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa, dunque, ne avremo?». La risposta di Gesù – «chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» – è immediata: da un lato, infatti, i discepoli riceveranno cento volte di più di quello che hanno lasciato, sia sul piano delle cose possedute (case, campi), sia su quello delle relazioni umane (figli, fratelli, sorelle, madri).
La sequela di Gesù comporta delle rinunce, ma anche dei guadagni molto maggiori, già in questa vita. Dove si possono trovare – si è chiesto più volte il teologo Paolo Ricca – questi «guadagni»? Senz’altro nella comunità cristiana, concepita, come una grande, «vera famiglia allargata, in cui ciascuno è al servizio dell’altro, e ciascuno riceve ciò di cui ha bisogno in quel momento della sua vita, sia sul piano materiale, sia su quello morale e spirituale». La grande domanda è se la comunità cristiana sia stata nella sua storia e sia oggi capace di rispondere a ciò che Gesù si aspetta da essa. Il grande guadagno promesso «nel secolo a venire», cioè nel mondo futuro, è «la vita eterna», e l’ingresso nel regno di Dio non dipende dalla bontà delle nostre scelte, neppure da quelle più evangeliche che si possano immaginare, ma dalla bontà di Dio, il cui giudizio può ribaltare il nostro. Perciò, dopo aver fatto tutto quello che potevamo e dovevamo, il vero «guadagno» è affidarsi unicamente a Dio.