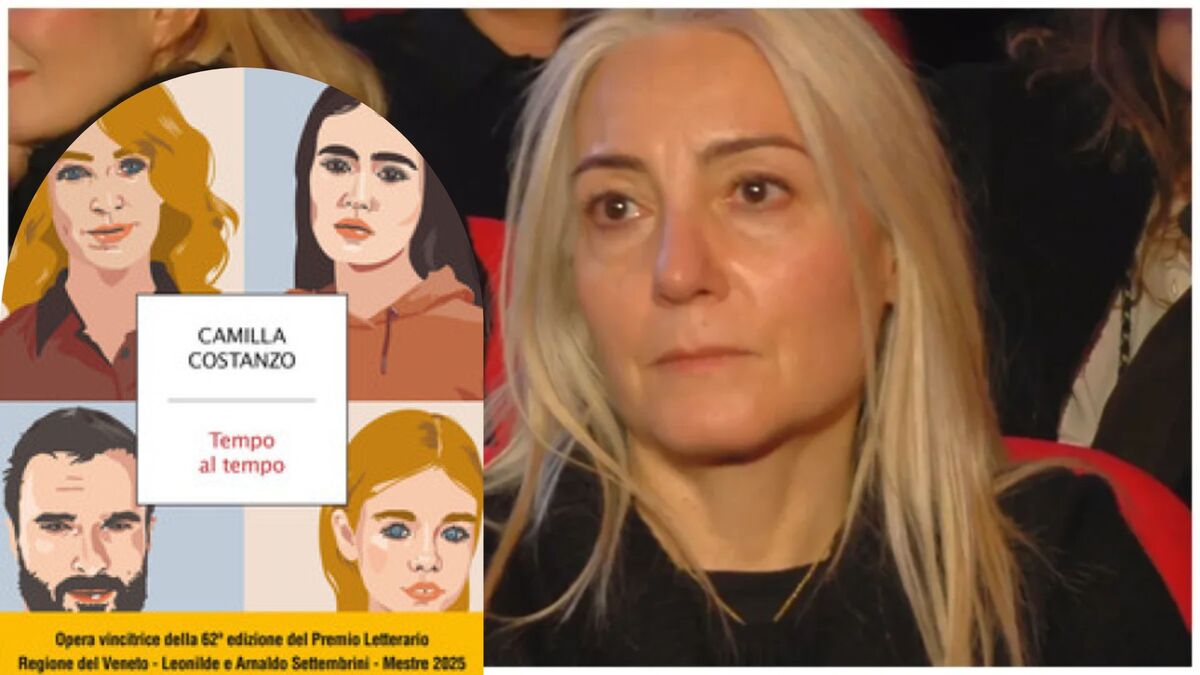di Alessia de Antoniis
“Oggi è il primo giorno di pace, oggi i campi che prima erano di guerra, sono solo erbe e cimiteri.”
Così si apre Titus. Why don’t you stop the show?, adattamento di Tito Andronico firmato da Davide Sacco che inaugura la stagione del Teatro Quirino di Roma (fino al 12 ottobre). Non siamo di fronte a Shakespeare, né a una sua rilettura: piuttosto a una riscrittura radicale, che conserva fabula e intreccio ma rielabora interamente il linguaggio e i personaggi, costruendo una drammaturgia autonoma e dichiaratamente politica.
Lo spazio scenico si dilata oltre i confini del palcoscenico, occupa metà della platea, sacrificando la visibilità di buona parte degli spettatori sulle balconate. È una scelta rischiosa che mette alla prova la relazione con il pubblico: dove lo sguardo non arriva, resta la voce, e lo spettacolo si trasforma, suo malgrado, in un radiodramma. L’impianto scenografico di Fabiana Di Marco, fatto di pedane mobili, botole e catene, punta a restituire un mondo instabile e brutale. Alcuni spettatori vengono collocati a terra, su cuscini, a ridosso dell’azione, in un’eco del teatro elisabettiano, quando il pubblico era parte integrante del rito scenico.
Davide Sacco lavora per sottrazione e al tempo stesso per accumulo: alleggerisce la selva di personaggi shakespeariani, ma moltiplica i toni urlati, trasformando la tragedia in un coro ossessivo. Tutti gridano, come in un incubo distopico che guarda a Arancia meccanica, senza però la mano chirurgica di Kubrick. La forza della drammaturgia, che ha il merito di snellire e attualizzare il testo, innervandolo di immagini contemporanee (“la politica cambia più veloce di un colpo di pistola”), rischia così di smarrirsi nella regia, che livella le temperature emotive.
Il cast offre prove diseguali. Francesco Montanari, Tito, impiega tutto il primo atto per liberarsi dalle scorie televisive di Suburra e solo a tratti ritrova la sua potenza teatrale. Il grido “dieci, mille, migliaia di bambini morti” è il primo momento che scuote davvero la sala strappando un applauso a scena aperta. Magari complice anche l’attuale situazione a Gaza. Nel monologo d’apertura del secondo atto, invece, la sua esasperazione resta imbrigliata e non esplode in quella furia tragica che il personaggio reclama. Montanari possiede il ruolo, ma almeno nella sera della prima non riesce ad abitarlo fino in fondo.
Marianella Bargilli è una Tamora elegante e feroce, regina gota che si muove con fierezza controllata. La sua perfidia è tanto più tagliente quanto più trattenuta: là dove riesce a scegliere il tono sommesso, il veleno arriva più a fondo che nel grido. Beatrice Coppolino, straordinaria Lavinia, trasforma il proprio corpo mutilato in voce scenica: dopo la prima battuta, restano singulti e lamenti, che però diventano parola teatrale, ferita incarnata. Un bravissimo Guglielmo Poggi regala un Saturnino fragile, ossessionato dal potere e a tratti caricaturale: la sua ironia alleggerisce la sanguinaria tragedia, strappando persino qualche sorriso. Claudia Grassi sostiene con credibilità il ruolo di Aronne, trasformato in figura femminile, schiava, complice e amante di Tamora: la sua presenza dà corpo alla contro-narrazione della vendetta, scelta registica forte che sposta l’asse del potere e della crudeltà sul femminile.
Il cuore dello spettacolo sta nella domanda continua di Tito: “Chi ha commesso questo delitto?”. È la ricerca di una verità che il corpo di Lavinia, ridotto a “pezzo di carne”, non può più testimoniare. Qui Sacco intercetta con lucidità la dimensione metateatrale: il teatro come spazio che interroga l’ingiustizia, ma che resta senza risposta. La disperazione del padre, che sogna “cento frecce, ognuna con una bestemmia inchiodata sulla punta da scagliare dritta nell’Olimpo”, diventa allegoria di un mondo senza dèi, senza etica, dove l’unica giustizia possibile è la vendetta.
Eppure, lo spettacolo finisce per strozzare la propria stessa forza: l’ossessiva reiterazione della violenza scenica, amplificata dal continuo urlare, rischia di scivolare nel rumore. Così la tragedia perde profondità e si appiattisce in un meccanismo disturbante ma prevedibile.
Alla fine resta la domanda del titolo, “Why don’t you stop the show?”, che suona come un monito: fermarsi prima che la rappresentazione della violenza diventi essa stessa complice dell’assuefazione che vorrebbe denunciare. Perché non dobbiamo mai abituarci all’orrore.