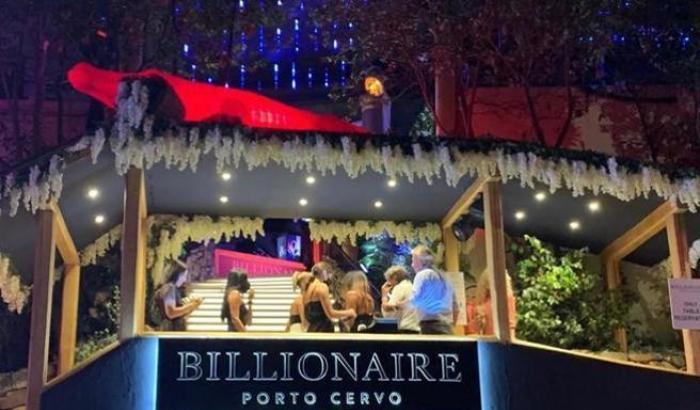Un check-up dell’etica. Prima o poi lo fanno tutti, al giorno d’oggi, un check-up; era necessario che lo facesse anche l’etica, la grande latitante. Rocco d’Ambrosio, docente di filosofia politica all’Università Gregoriana, ci ha provato a farlo, e giustamente il suo libro, che contiene i risultati del check-up, è stato commentato da una delle più autorevoli pubblicazioni cattoliche, La Civiltà Cattolica, (2025, ottobre, f. 4198, pp. 195-203).
Non è una recensione, ma un vero e proprio articolo-saggio, firmato da padre Giovanni Cucci, firma di punta della pubblicazione che sempre si ricorda che manda le sue bozze prima della pubblicazione alla Segreteria di Stato, per un check-up di “congruità”, quindi con qualcosa di ufficiale. Siccome quella di Rocco d’Ambrosio è una firma che i lettori di Globalist ben conoscono è opportuno approfondire un po’, o meglio, porre alcune domande all’estensore dell’articolo di Civiltà Cattolica e all’autore del volume, che si intitola “L’etica stanca. Dialoghi sull’etica pubblica”.
Con merito Globalist se ne è già occupato, ma uso l’opportunità del dialogo di padre Cucci con il libro per porre a entrambi la prima domanda: un’etica pubblica? Se noi guardiamo al mondo e ci rendiamo conto che ormai del diritto internazionale si constata che conta ma fino a un certo punto, abbiamo la fotografia perfetta delle condizioni del malato. Si è dovuto scomodare il papa per dire ai guerrieri culturali che uno che è contro l’aborto ma a favore della pena di morte, o per trattamenti inumani dei migranti, non è un pro-life.
Ecco allora che l’etica, che questo check-up mi conferma risiedere anche in ciò che affermiamo e questo mi induce a porre la prima domanda: questo volume non poteva intitolarsi “Parliamo della felicità”? La vera domanda che il volume ci invita a porci e che la recensione di padre Giovanni Cucci fa giustamente risaltare, a mio avviso è proprio questa: vogliamo essere felici?
La Chiesa, con il linguaggio che le è proprio ma che nessuno capisce, lo dice da tempo: “andare controcorrente rispetto alle logiche mondane”. Chi capisce molto spesso obietta “cominciasse a farlo lei”. Sembra una ripicca e in parte lo è, ma in parte è anche la conferma che abbiamo bisogno di modelli, non per convertirci, ma per ammettere che abbiamo difficoltà a capire come essere felici. Il vero punto è capire come essere felici per i secolarizzati e per i credenti. Così arrivo alla seconda domanda: Dio non è il nostro desiderio di essere felici? Se così fosse dovremmo interrogarci su cosa sia questa felicità. Ecco allora che diviene incalzante quanto scrive padre Cucci: “l’etica, per quanto stanca, non è quindi da inventare piuttosto, da riscoprire; il lavoro del filosofo consiste nel rimuovere e gli equivoci che ne hanno offuscato la bellezza”. La bellezza? Certo, per me è la felicità. E padre Cucci con evidente riferimento a un capitolo del libro chiarisce cosa ci sia da chiarire e come nella conclusione del dialogo con il volume, dove si occupa dell’umorismo: mi ha colpito che non citi- pur conoscendo certamente la sua rilevanza al riguardo- papa Francesco, che pure ha inserito tra le dieci raccomandazioni che faceva ai suoi preti quella di non perdere mai il buon umore ed ha invitato i maestri della satira e dell’umorismo in Vaticano. Forse lo ha fatto per uno sforzo di non confessionalizzare l’umorismo; scelta che apprezzo, ma tra tanta consuetudine al “grigismo” ecclesiale e al formalismo curiale un po’ di umorismo “autoprodotto” fa proprio bene. Comunque l’umorismo, spiega padre Cucci, è “la capacità di cogliere cose che sfuggono alla sguardo superficiale”. Come quello con cui ci domandiamo se vogliamo essere felici. E’ qui che, da secolarizzato, non capisco perché non dire che la felicità è Dio, creduto o desiderato che sia. Sapere che Dio esiste, per qualcuno senza sapere chi sia, vuol dire sapere che esiste, la felicità; bisogna scoprire quale. Questo a me sembra che sia ciò che sfugge allo sguardo superficiale.
Ecco allora che mi sono ripetuto che se in nome di Dio mi guardano in cagnesco perché non devo fare questo o quello, ovviamente al 99% in ambito sessuale, io non percepirò come via verso la felicità le loro raccomandazioni. Ma se qualcuno mi portasse a guardare nella felicità-sfida che vedo nel prendere furtivamente il portafoglio che occhieggia dallo zainetto lasciato distrattamente aperto dalla persona che mi è accanto in metropolitana sfidandomi poi ad allontanarmi frettolosamente, a sgattaiolare con grande abilità per sottrarmi grazie alla folla agli eventuali inseguitori, dimostrandomi più bravo di loro, più scaltro, potrei capire la privazione di una felicità maggiore: dire io per primo alla persona che mi sta accanto che ha lasciato lo zaino aperto, tutti i suoi averi potrebbero cadere per terra: questo non mi rende ancora più scaltro? Non sarei più felice non nello sparire, ma nel guardare uno sguardo a me grato?
Proseguendo nel discorso si arriva certamente al rimorso che cancella la felicità; il rimorso esiste, basta leggere “Delitto e castigo” per saperlo: ma leggere a volte non basta, occorre conoscerlo di persona il rimorso. Dunque abbiamo sbagliato, pensavamo che la felicità fosse possedere un portafoglio, ottenere un guadagno illecito, godere di un rapporto sessuale con un/una partner sposato/sposata; immersi nel mimetismo, noi desideriamo ciò che desiderano gli altri, per uscirne dovremmo imparare a desiderare ciò che ci fa bene. Difficile arrivarci senza passare attraverso le forche del rimorso. Il rimorso va provato per essere capito, è la via per capire cosa ci rende davvero felici, al di là del mimetismo che ci condanna a vivere come vive un mondo di infelici.
Proseguendo al riguardo va osservato che d’Ambrosio scrive pagine molto impegnative sulla virtù, da Aristotele in avanti. Ma il punto è questo, o non è sentirci sollecitati a ribellarci al senso divenuto comune di cosa sia la virtù? L’autore spiega bene cosa non vada nel detto “vizi privati e pubbliche virtù” e lo vedremo, è giustissimo, ma con un pulpito che ci sollecita alla rivolta capiremmo che il modello che a noi si attaglia è quello di una felicità opposta a quella imposta dall’ “arricchitevi” del neoliberismo: non è stato questo il fascino del pontificato di Francesco? Il papa in utilitaria, senza insegne imperiali, che rinuncia agli ori, che (criticato!!!!!!!!) va in Basilica come un semplice malato, con un poncho sulle spalle… E’ questa la cattedra dalla quale ci ha indicato la felicità? Restare liberi, se stessi, anche lassù…
Il libro, in modo affascinante, ci pone il punto “etico” ricorrendo alla metafora dell’abito, e poi scrive: “ sto misurando con un metron le proporzioni giuste perché il mio abito non sia né troppo stretto, né troppo largo, ma sia “perfettamente” della mia misura. E più sarà confezionato senza sbavature di parti troppo larghe o troppo strette, tanto più sarò… virtuoso, cioè vestirò abitualmente l’abito che fa per me e che mi permette di essere eticamente all’altezza del contesto in cui sono inserito. Di seguito, riporto un elenco di virtù e vizi: potrebbe servire a verificare cosa riteniamo virtù e cosa vizio e quale metron, quale bussola applichiamo per considerarli tali; a ricercare le ambiguità presenti in alcuni atteggiamenti (il mondo non è mai tutto nero da una parte e tutto bianco da un’altra; né bene e male, quaggiù, sono sempre nettamente distinti); potrebbe anche servire a fare una piccola classifica personale e una sociale di vizi e virtù ancora sul mercato, cioè abiti di moda, e di altri fuori commercio ormai da tempo. Insomma un piccolo esercizio di discernimento personale e comunitario”. Segue un ragionato elenco di vizi e virtù e poi D’Ambrosio scrive: “ Tutte queste virtù e vizi sono abiti che indossiamo sia nella sfera privata che in quella pubblica. E di ciò ne sono pienamente convinto. Per questo motivo mi ha sempre fatto pensare l’espressione “vizi privati e pubbliche virtù”. Essa mi suona come una “schizofrenia etica” dove il modo di “vestire” in privato è completamente opposto a quello pubblico; mi ricorda molto i vizi piccolo borghesi di una certa fascia sociale italiana”. Sto a quanto indicato alla lettera “O”: “Odio, oltraggio, orgoglio, ostilità”. In tutto questo posso vedere la felicità: sono felice di odiare chi mi odia, di oltraggiare che oltraggia, di essere orgoglioso, o ancor di più ostile a chi mi mostra ostilità. Ma vorrei chiedere all’etica di liberarmi di tutto perché scopro che così copio il meccanismo che mi viene imposto da ciò che normalmente si desidera: non devo sperimentare che odiare chi odia mi rende uguale a quel brutto ceffo che odio? Non sarò felice se riuscirò a sottrarmi a questo meccanismo mimetico, cioè a non desiderare di diventare come lui?
Ecco che mi serve il rimorso, cioè il passare per le acque torbide dell’errore, e qualche amico che con ironia me lo faccia notare. Ma mi serve anche qualcuno che mi inviti a sottrarmi a un ordine ingiusto! Così vorrei chiedere un’autorità morale che mi faccia scoprire Dio- che io creda o non creda conta poco- nel sentirmi in rivolta: non certo una rivolta metafisica, al contrario, una rivolta che si fa qui, ora, contro il mimetismo che mi capovolge e finalmente arrivare ad essere felice. Il papato irripetibile, quello di Francesco, non ci ha parlato di questa rivolta anche con il suo modo di presentarsi? E’ questa un’altra etica pubblica?
Siamo così ai modelli, all’educazione, ai valori che ci sono nella nostra società. Valori da correggere? Ovviamente non siamo tutti uguali, pur nei nostri valori; per esempio ci viene facilmente insegnato di dire sempre tutta la verità. Eppure è lecito ritenere che ci siano dei casi in cui non mi sentirei felice dicendo tutta la verità, perché la sento insopportabile, troppo cruda e dura per il mio interlocutore. Così posso dirne solo metà. Ma se questi possono apparire dei “casi”, l’etica stanca di cui ci racconta tante cose d’Ambrosio non sarà il prodotto di un mondo che si fonda su ciò che non è etico e che quindi ci porta a rifiutare la felicità, o l’ indurci a crederne vera un’altra?
Parlare di etica come felicità fonda una rivolta: la rivolta non contro le regole, ma contro il loro capovolgimento. Non si tratta di adeguarsi alla logica della nostra società, ma di dire che bisogna capovolgerla per scoprire la felicità. Non è questo che la Chiesa dice invitando ad andare controcorrente rispetto alla “mondanità”? Ma questo termine rende il mondo non etico per definizione, la non eticità come prodotto naturale del mondo. E’ così? Non è invece il prodotto del mimetismo che ci cattura, imponendoci di desiderare ciò che desiderano gli altri? Solomon Arsch ha dimostrato che se vengo inserito in un gruppo dove tutti (istruiti in tal senso a mia sola insaputa) rispondono in maniera palesemente errata, anch’io darò la stessa risposta. Serve l’umorismo rivoluzionario, che ricorda quello di cui parla nella recensione padre Cucci e che nel libro viene presentato con splendide parole nelle pagine a ciò dedicate dal volume: “ La Arendt diceva che il riso scuote le basi dell’autorità.” L’esperimento di Arsch ci dimostra quale sia l’autorità. Forse non sbagliava Bakunin, “una risata vi seppellirà”? ( In Italia fu “la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà” ). Devo aggiungere che tra le mie semplici domande d’Ambrosio ha lavorato d’anticipo e inserito una risposta inattesa: “Se le parole oggi rischiano di essere logore, se la comunicazione interpersonale – in presenza l’abbiamo definita durante la pandemia – è in crisi, se le guerre tolgono la parola a chi soffre o è schiacciato dalla fatica, se la parola è povera e debole perché non accompagnata dal contatto fisico, allora dobbiamo lasciare che la poesia sia una boccata d’aria per la mente e il cuore, in ogni ambito privato e pubblico”.
E dopo la boccata d’aria riaffiora la domanda: possiamo risvegliare l’etica non dicendo che questo ordine è ingiusto e quindi proponendo un altro mimetismo? E’ un po’ quello che i cattolici chiamano “sequela di Cristo”, ma che va mostrato nella realtà sociale, personale, culturale dei mondi d’oggi. Nel libro d’Ambrosio, scrivendo della coerenza, tocca un tema decisivo: se noi dobbiamo sovvertire un ordine mentale per cui felicità sarebbe il diventare ricchi, essere invidiabili, avere l’ultimo telefonino, riuscire a collezionare un bel po’ di like, non a dire ciò che ci tormenta, dobbiamo anche indicare un’altra strada per la felicità, che non può essere quella della sofferenza. Non siamo felici perché poveri, derisi, privi dell’ultimo telefonino, senza like; come imparare una nuova felicità? Questa felicità mai citata indica la dimenticanza di Dio? Scrive d’Ambrosio: “Non possiamo negare che le tante incoerenze gravi a cui assistiamo ci portano a scoraggiarci. Continua Silvia Godelli: «Quello a cui stiamo assistendo, e non solo nel nostro Paese, è un fatale arretramento nella scala dei valori della civiltà. Gli anticorpi dove sono? Dove saranno? Questo è l’interrogativo più inquietante». Ma il suo argomentare riporta a una domanda storica: in termini etici, le incoerenze odierne sono peggiori di quelle del passato?”.
In effetti ci culliamo nel pessimismo e non diciamo che il mondo col divorzio (magari consensuale) è migliore del mondo senza, perché la felicità non può essere costrizione a mantenere in vita ciò che è morto. Ha quindi ragione Sant’Agostino, che nel libro viene citato per dirci che “ uno giudica felice proprio il tempo passato perché, in quanto passato, non è ormai più suo”.
Altrimenti l’orizzonte si restringe e senza un amico con il dono dell’umorismo non vediamo che il nostro problema, completamente soli, è non sapere più come essere felici, quale altro desiderio altrui inseguire, e diventare sempre più infelici. Una Chiesa rivoluzionaria, o meglio una Chiesa in rivolta nella moderazione e nella nonviolenza invocate per l’uomo in rivolta di Camus, che inviti a cercare dentro di noi un altro sistema, un’altra strada per arrivare alla felicità, forse è un’esigenza di tutta la società. Difficile trovare qualcun altro da affiancarle, oggi, ma possibile domani, se si riparte. Senza moralismi, ma con la ricerca della prassi della rivolta. Dico senza moralismi perché la politica è un animale indomabile, non può essere giudicata dal moralismo: un politico una volta ha detto che per attraversare il fiume servono le scarpe sporche: aveva certamente letto Jean Paul Sartre. Il discorso però può diventare auto-assolutorio, estendersi all’infinito, sfociare nel tradimento: un rompicapo da considerare, e forse è il rompicapo che spiega perché siamo arrivati dove siamo. Dunque come uscirne? Padre Cucci indica la strada degli esempi, citando Clive Steples Lewis: “sono i piccoli cenacoli di amici che voltano le spalle al mondo, quelli che realmente lo trasformano”.
Non posso porre termine alle mie domande senza farne una sull’identità, tema importantissimo che viene trattato in modo profondo e convincente. Personalmente guardo con un po’ di distanza al “comunitarismo” pur stimando le relazioni sociali, ma i gruppi chiusi, rigidi, li temo. Non discostandomi di molto dall’autore credo che l’identità di ciascuno di noi sia fatta dagli incontri che abbiamo avuto, oltre che dai geni. La metafora delle radici non mi appartiene, meglio pensarci come i fiori di un prato, soggetti a impollinazione. Il libro esprime concetti non lontani e questo mi ha fatto ovviamente piacere, ma, per colpa dell’anagrafe, ricordo che esistevano anche le classi sociali, alle quali si “apparteneva” , ed esprimevano culture. Oggi è rimasta solo la cultura borghese, ma non tutti siamo borghesi nel senso di appartenenti a questa classe sociale. Questo non è anche un problema etico?