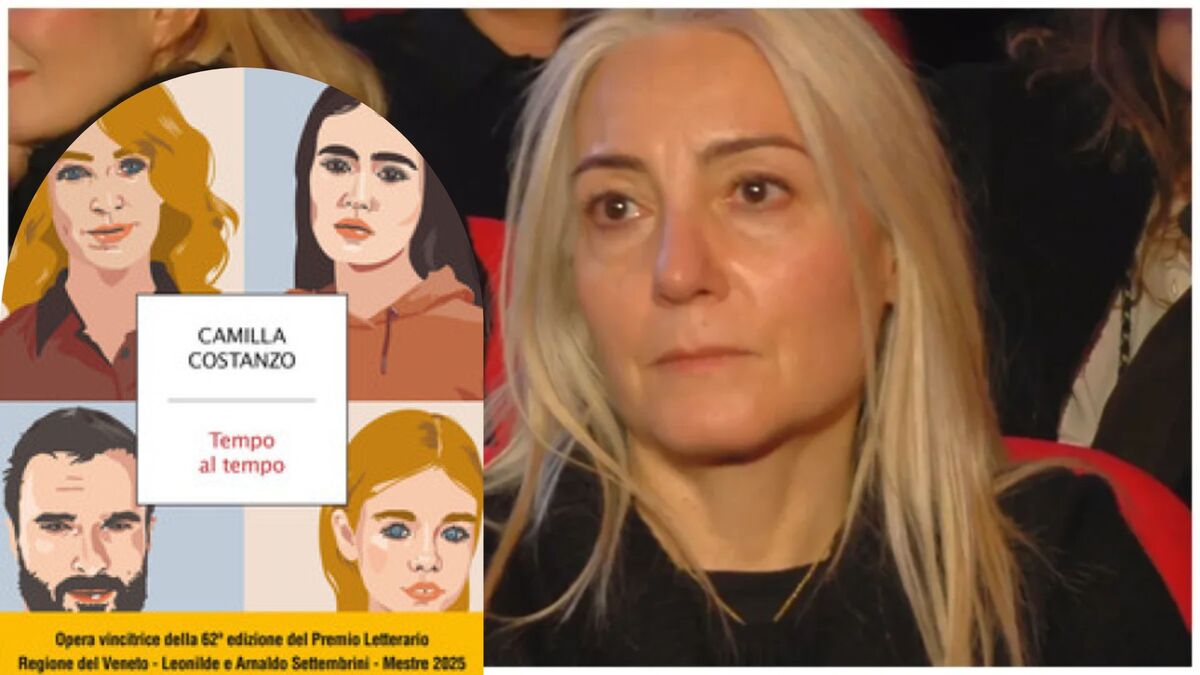di Alessia de Antoniis
Un cane investito, un’auto ferma ai margini del deserto, una donna incinta, una bambina in auto, il rumore metallico di una protesi che taglia il silenzio. Così comincia It was just an accident, il film presentato alla Festa del Cinema di Roma di Jafar Panahi, tornato in libertà nel 2023 dopo anni di detenzione.
“It was just an accident,” dice la moglie del torturatore al marito, minimizzando l’investimento di un cane. Un titolo ironico, perché nulla, nel cinema di Panahi, accade per caso, nessun incidente è mai solo un incidente. L’incidente diventa la metafora di un Paese dove anche il destino ha una conseguenza politica.
Vahid, meccanico, riconosce nel cigolio di una gamba artificiale il suono della propria tortura. Crede di aver ritrovato il carceriere che lo umiliò in prigione, lo rapisce e parte nel deserto con altri ex detenuti: una fotografa, una sposa ancora in abito bianco, un operaio e un uomo divorato dall’odio. Ciascuno con la propria idea di giustizia.
Panahi filma con la precisione di chi lavora in clandestinità, rendendo ogni gesto essenziale. Le inquadrature strette del furgone diventano celle, il deserto una prigione aperta. Eppure, nonostante la potenza visiva e la densità morale, il film non sempre regge il proprio peso: alcune sequenze si allungano, altre ripetono ciò che già era stato detto. It was just an accident non è tanto un film lento, quanto un’opera che a tratti si piega su se stessa nel bisogno di ribadire.
Lo stesso Panahi, raccontano i produttori, ha tagliato venti minuti nell’ultima fase di montaggio. È il limite di un film che alterna momenti di grande lucidità ad altri più compiaciuti, come se la necessità di dire, dopo anni di silenzio forzato, abbia prevalso sul ritmo del racconto. Un film che a tratti preferisce spiegare anziché evocare.
La Palma d’Oro solleva una domanda: quanto è stato premiato il film e quanto il simbolo, l’autore che sfida la censura e che ha trasformato la propria biografia in un atto politico?
Eppure, proprio questa imperfezione lo rende necessario. It was just an accident è un cinema che non consola, ma interroga: scardina la nostra percezione dell’Iran filtrata dalle cronache e restituisce un punto di vista interno, radicale. È un film che parla di tortura, ma anche di memoria, di corruzione, di usi lontani dai nostri; di come le ferite mai rimarginate si infettano di odio, si trasmettono, e rischiano di contagiare un’intera società.
Un road movie claustrofobico, un teatro di volti e sospetti in cui ogni inquadratura misura la distanza tra la verità e la vendetta. Le sue immagini sono asciutte, precise, mai decorative; il suono della protesi del torturatore è la cicatrice sonora di un sistema che continua a camminare anche quando sembra morto.
Girato in segreto, montato tra Teheran e Parigi, dopo anni di arresti, divieti e clandestinità, Panahi può girare il suo film più libero. Le donne non portano il velo, le strade non hanno più padroni, la verità si mostra nuda anche quando è scomoda. È un cinema che non chiede pietà, non vuole spiegare l’Iran a chi lo guarda da lontano, vuole costringere lo spettatore a guardare dentro se stesso, dentro le proprie zone grigie. Ci ricorda così che le dittature non nascono nei palazzi, ma nella pigrizia morale di chi smette di reagire.
C’è però un “ma”. Nel 2015 Panahi, sotto divieto di fare cinema, firma un film libero come Taxi Teheran, dove il taxi diventa il set di conversazioni libere e senza censura. Dieci anni dopo, libero, è come se Panahi non avesse saputo gestire la libertà. Allora aveva messo in scena l’Iran quotidiano, tra norme, divieti, umorismo e dolore, riuscendo a trasmettere il senso di resistenza del cinema stesso. Oggi, onestamente, se questo film fosse stato girato da un regista esordiente o meno conosciuto, senza la storia di martirio politico che ha il cineasta iraniano, avrebbe avuto la stessa accoglienza? Sarebbe stato insignito della Palma d’oro?
It Was Just an Accident è sicuramente un film che andrebbe mostrato in ogni talk show dove si fa geopolitica da divano e ci si illude che la libertà sia un hashtag. Un film per capire, per non dimenticare, quanto costi essere vivi in un Paese che punisce chi guarda. Ma, per assurdo, respira meno libertà e meno resistenza dei film che aveva girato in clandestinità.
Argomenti: Cinema