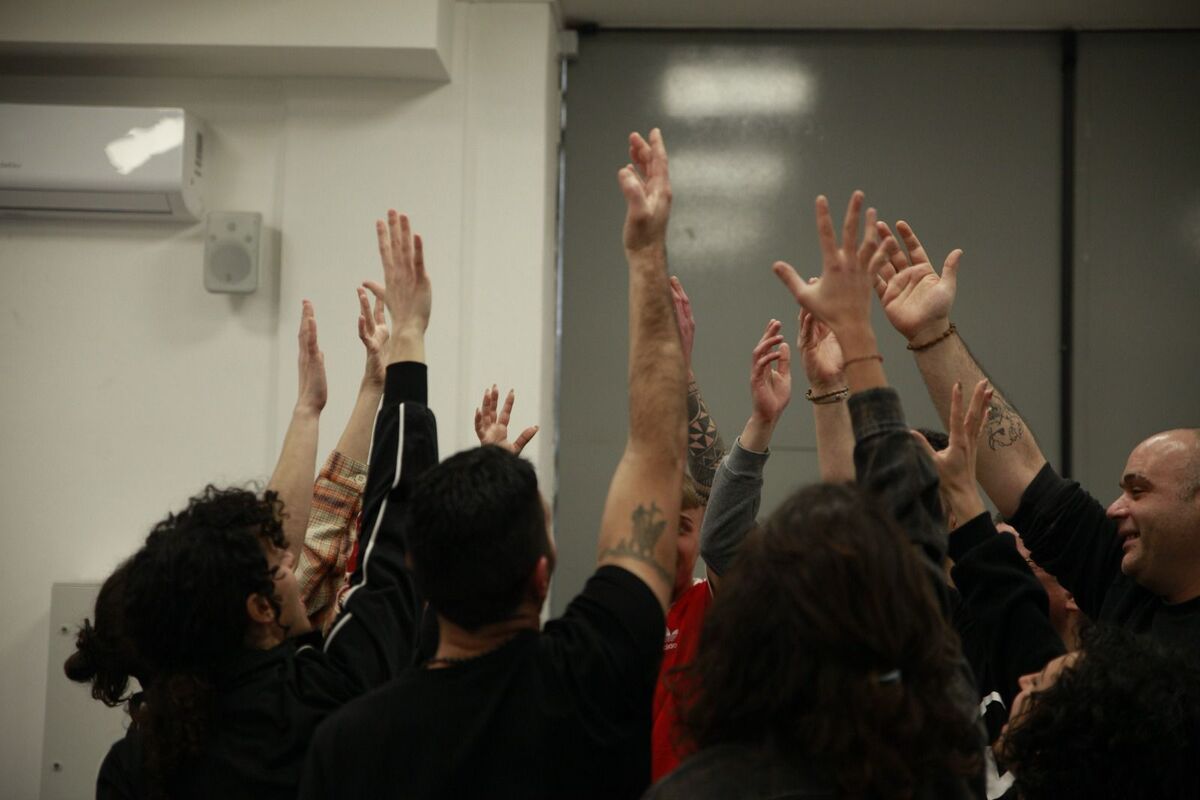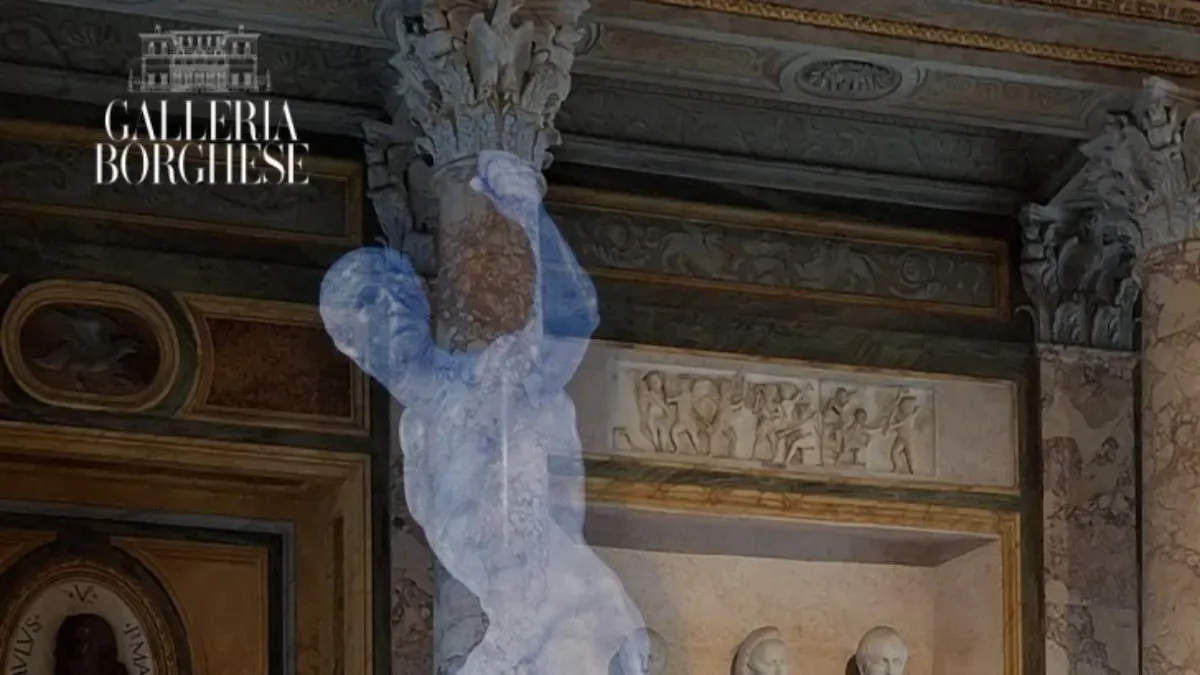di Alessia de Antoniis
Ci sono artisti che non raccontano il teatro: lo custodiscono. Lo tengono nelle vene come un ricordo di infanzia, come un odore rimasto appeso ai velluti di un palcoscenico. Pino Strabioli appartiene a questa razza rara: attori del racconto, eredi di chi saliva in scena non per mostrare, ma per tramandare.
Lo incontro alla vigilia del debutto romano di Ve ne dico quattro (Off/Off Theatre, 19–23 novembre 2025), un omaggio vibrante e umano a quattro presenze che hanno inciso il nostro immaginario teatrale: Paolo Poli, Franca Valeri, Dario Fo e Valentina Cortese. Con una breve apparizione di Gabriella Ferri.
Stare “di qua” è strano. Siamo abituati a vedere Strabioli nelle veste di intervistatore. “All’inizio avevo difficoltà – ammette – Mi sto via via abituando. Forse perché, ascoltando i grandi che ho intervistato negli anni, da Mariangela Melato a Luca Ronconi, da Carla Fracci a tanti altri, ho capito che si impara osservando e restando in ascolto. Credo che la scuola serva, ma anche l’incontro con l’altro è una forma di apprendimento potentissima. Dieci anni di televisione e di interviste mi hanno aiutato a stare più sereno dall’altra parte.”
“Ve ne dico quattro”: suona un po’ come un rimprovero, un monito…
Sono quattro le personalità che racconto, anche se c’è un piccolo innesto su Gabriella Ferri. Ve ne dico quattro è un invito a non dimenticare chi ci ha preceduti, chi ha vissuto un’esistenza votata all’arte, alla passione, all’impegno. Viviamo in un Paese con la memoria corta, che a volte rischia perfino di riscrivere la storia. Questo spettacolo è un modo per non sprecare ciò che queste figure ci hanno consegnato.
Ve ne dico quattro è un omaggio a tutte le persone che, nella prima giovinezza, mi hanno indicato una possibile strada. È una carrellata che mi diverte: c’è lo sfrontato coltissimo Paolo Poli, la popolarissima e graffiante Franca Valeri, il Nobel Dario Fo. E Valentina Cortese: l’ultima, ma forse l’unica, diva del teatro italiano.
Oggi che tutto è reperibile in rete, cosa conserva il racconto orale?
È la forma più emozionante, più vera del racconto. Io ho una passione per il racconto orale: nasce dalla radio, dalla televisione e dalla vita. Sono un grande ascoltatore. Sul palco porto spettacoli essenziali, senza effetti scenografici. E mi accorgo che il pubblico ritrova il piacere di ascoltare, di lasciarsi condurre. Da ragazzino andavo a teatro e rimanevo incantato da sconosciuti che mi trascinavano in storie impossibili. Il racconto mi rassicura: ne conosco l’inizio e la fine. Lì dentro non ci sono le paure dell’esistenza: la malattia, la morte. È un territorio diverso.
Parli di libertà di espressione contrapposta al politicamente corretto. Eppure Poli, Valeri, Fo erano provocatori, erano pericolosi per il loro tempo…
Libertà, per me, significa persone libere, con un pensiero libero. Valeri, Poli, Fo sentivano l’urgenza di trasmettere un pensiero: quello era un atto politico, anche senza comizi. Sono stati a modo loro dei rivoluzionari. Il teatro resta uno spazio libero. In televisione mi censuro un po’: non tradisco il mio pensiero, ma imposto la mia voce pensando a chi guarda. A teatro no: chi entra ti sceglie. Uso comunque un linguaggio che può sembrare politicamente corretto, ma chi sa leggere percepisce il senso di ciò che voglio dire.
Oggi ci censuriamo anche per chi sta sopra, non solo per chi ci ascolta…
Sì, oggi la censura esiste e prende molte forme. Dario Fo è stato vittima della censura dei dirigenti Rai a Canzonissima. Lui e Franca Rame furono allontanati dalla televisione per uno sketch sulle morti bianche, le morti sul lavoro. Rivedendo alcuni testi di Franca Valeri, mi sorprendo: avevano una forza enorme e non furono censurati. Perché? Non so rispondere. Forse alcuni dirigenti non coglievano ciò che stava arrivando nelle case, forse erano più illuminati…
Quando racconti queste persone devi tradirle, è inevitabile. Cosa è rimasto fuori? Per delicatezza, per pudore, per necessità teatrale…
Non credo nel tradimento. Certo, esiste una scrittura teatrale che seleziona, ma ho seguito un criterio emotivo. Con Paolo Poli, con cui ho lavorato e scritto il libro Sempre fiori, mai un fioraio, ho scelto di non condividere alcune sue confidenze personali: per educazione, per rispetto. Per il resto non ho né santificato né esaltato nessuno. Con Paolo e Franca ho ricordi più intensi perché con loro c’è stata un’amicizia vera, ci ho lavorato. Dario Fo l’ho incontrato una decina di volte. Con Valentina Cortese c’era un’amicizia telefonica, fatta di colazioni a Milano, di interviste, di pomeriggi passati insieme quando stavo a Roma. Sono ritratti diversi: più calorosi per alcuni, più distaccati per altri. Ma l’impronta resta.
Perché Fo e Cortese adesso?
Dario Fo è entrato quasi per caso: non mi ero neanche accorto del centenario. Ma ci sono incontri che ti segnano per sempre. Da ragazzo andai all’Argentina a un suo seminario e rimasi sconvolto dalla forza, dalla fisicità, dalla sua visione di teatro. Valentina Cortese, invece, fu un colpo di fulmine: uno dei primi spettacoli che vidi fu Maria Stuarda di Zeffirelli, con lei e Rossella Falk, a Orvieto. Quelle due signore erano lontanissime dalle donne della mia provincia. Rimasi folgorato. Valentina mi ha regalato una dimensione del teatro completamente diversa da quella di Fo: più borghese, più recitata, più “paludata”. Ma era una meravigliosa pazza, forse la più pazza di tutti.
Franca Valeri è la prima volta che la porti in scena?
Sì. Con lei ero tornato sul palcoscenico in quelle che chiamava “le nostre seratine”, e mi divertivo moltissimo. Ma ho sempre avuto una certa resistenza: Franca è inarrivabile. Come fai a mettere in scena Franca Valeri?
C’è un incontro mancato che ti pesa?
Marcello Mastroianni. Lo sfiorai a un pranzo a Todi, insieme a Silvano Spada che mi accoglie nel suo teatro per questo spettacolo. Ma ero troppo giovane e troppo intimidito. Mi sarebbe piaciuto passare ore con lui. Avevo davanti un uomo che diceva: “Non sono Marcello Mastroianni, sono un uomo”. Ma in quel momento per me lui era immenso.
Esistono eredi oggi o erano figure irripetibili?
Credo nell’eredità. Quelle che racconto sono figure irripetibili, ma oggi abbiamo attori straordinari: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Iaia Forte, Filippo Timi, Elio Germano… Continuano piccole rivoluzioni, con coerenza. Il passato non va rimpianto: va coltivato.
Li abbiamo mitizzati noi o allora era più facile creare un mito?
Forse sono le epoche a creare i miti. Paolo Poli nasce nel 1929, dichiaratamente omosessuale; Franca Valeri affronta le leggi razziali; Dario Fo è figlio di un contadino e diventerà Nobel. Gabriella Ferri, prima del successo, faceva la commessa a piazza di Spagna e il padre vendeva lamette nei mercati. Gli attori che ho citato prima, sono figli del boom economico. Noi non abbiamo conosciuto la fame, la guerra, la paura. Questo ci ha dato molto, ma forse ci ha tolto qualcosa in quella ferocia creativa che trasforma il dolore in arte.