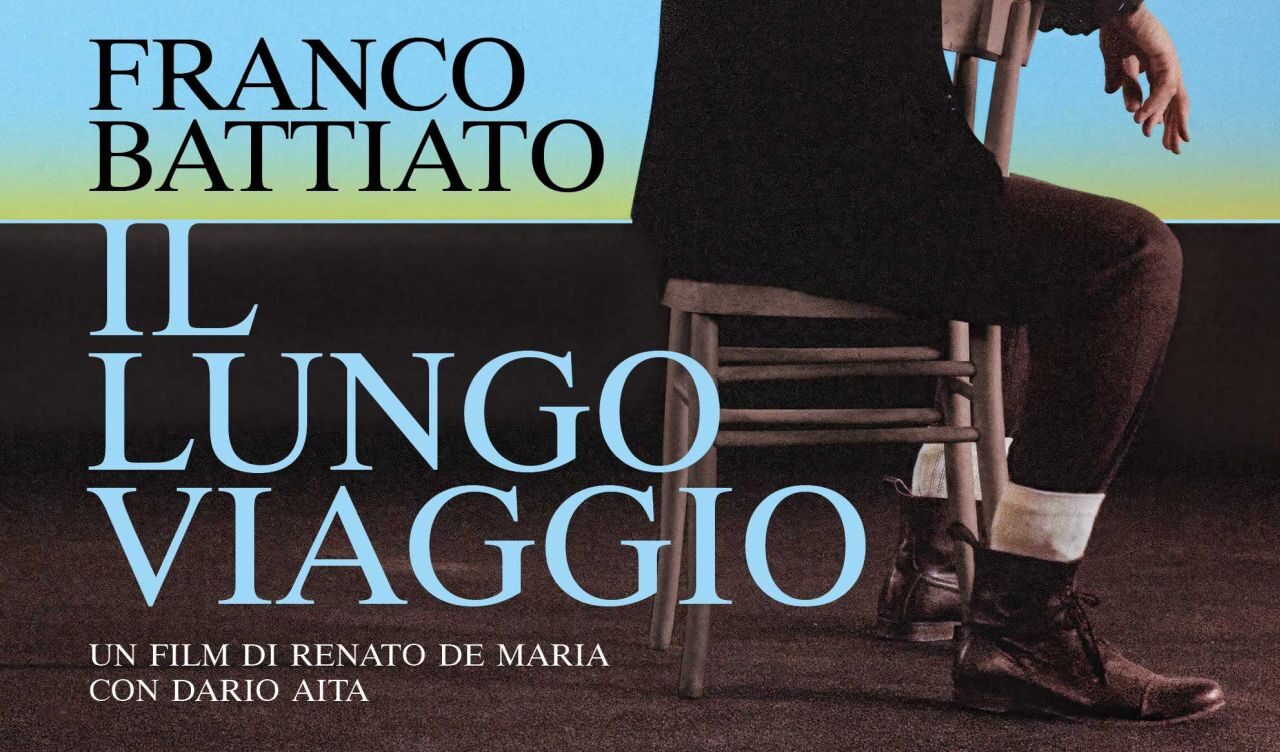di Alessia de Antoniis
In un panorama saturo di racconti sul confine, Invisible America sceglie deliberatamente di spostare lo sguardo qualche metro più in là, quando la sabbia del deserto è già stata attraversata e la barricata fisica non è più il problema. Il film scritto, diretto e interpretato da Christian de la Cortina non si interessa tanto al “come si arriva” negli Stati Uniti, quanto al “che cosa succede” a chi ce l’ha fatta. È lì, nella routine di una fattoria lattiero-casearia del Vermont, che il sogno americano rivela il suo lato più sinistramente efficiente: quello di un sistema che ha bisogno di corpi senza diritti per continuare a funzionare.
Fernando Barrera, il protagonista, è tutt’altro che il cliché dell’illegale senza voce. È un giornalista messicano, costretto a fuggire dopo aver toccato nervi scoperti con il proprio lavoro. Lo vediamo picchiato al confine, braccato in patria; poi catapultato dal sole feroce del Messico a un paesaggio di neve e silenzio, dove l’unico modo per sopravvivere è accettare un lavoro in nero in una dairy farm – una fattoria per la produzione di latte – sperduta. Alla caviglia porta un braccialetto elettronico: è la prova di una procedura d’asilo in corso, ma nel film diventa soprattutto un simbolo di libertà sotto condizionale, una catena digitale che scandisce tempi, movimenti, paure.
La fotografia di Nicolas Venne rende questo passaggio geografico un vero salto emotivo. Il Messico è ricordato in bagni di luce calda, negli azzurri del mare, in colori ambrati che avvolgono abbracci, minacce, addii: un luogo anche pericoloso, ma pulsante. Il Vermont, al contrario, è un mondo lattiginoso, fatto di bianchi accecanti e grigi industriali. La neve appiattisce lo spazio, i capannoni della fattoria sembrano corridoi di un carcere senza sbarre. Il linguaggio visivo racconta che Fernando è passato da un inferno visibile a un purgatorio gelido e senza testimoni.
La fattoria gestita da Dorothy, a cui Kim Huffman presta un volto gentilmente glaciale, è un piccolo laboratorio di capitalismo contemporaneo: niente fruste, niente catene, ma turni massacranti, salari miseri e, soprattutto, la minaccia costante di una telefonata alla polizia migratoria. L’episodio del latte rovesciato, in cui un incidente azzera in pochi secondi ore di lavoro, è il momento in cui la dinamica di potere esplode in tutta la sua chiarezza. La furia della proprietaria non riguarda solo la perdita economica; è un promemoria a tutti: qui siete sostituibili e, soprattutto, espellibili.
Attorno a Fernando si muove una piccola comunità di lavoratori senza documenti: Pablo (Jorge Martínez Colorado), che lo ha aiutato nelle pratiche d’ingresso; Carolina (Sonia Martinez), infermiera in fuga da violenze domestiche e istituzionali; Raúl (Luis Oliva), padre guatemalteco che ha perso una figlia lungo il cammino. De la Cortina non insiste sulle backstory con lunghe spiegazioni: i dettagli arrivano per frammenti, tra una pausa sigaretta e una mungitura, e bastano a suggerire un arcipelago di traumi. Si potrebbe obiettare che alcuni di loro restino più funzioni simboliche che personaggi pienamente sfaccettati, ma fa parte della scelta di campo del film: ciò che conta è la condizione collettiva, la massa di vite in sospeso più che il singolo caso esemplare.
La deviazione rispetto alla narrazione consueta sta nel profilo del protagonista. Fernando è un intellettuale, un uomo abituato a usare le parole come strumento di verità. Quando discute di diritti, quando cita il pensiero latinoamericano sulla dignità della persona, il film ribalta l’immagine paternalista del migrante da compatire. Non è la sua presunta ignoranza a metterlo in pericolo, ma esattamente il contrario: la sua lucidità politica. È proprio questa consapevolezza a rendere insopportabile la nuova forma di subordinazione in cui è caduto. L’America che lo ospita non è meno violenta del potere che lo ha costretto all’esilio: ha semplicemente raffinato i propri strumenti di controllo.
Sul piano della messa in scena, de la Cortina opta per una regia sobria, quasi trattenuta. La macchina da presa si avvicina ai corpi nei momenti di massima fragilità: un volto sporco di letame, una schiena piegata, un braccialetto che lampeggia. Ma evita di compiacersi della sofferenza. Le sequenze più brutali, come i flashback di tortura in Messico con gli elettrodi applicati sulla pelle nuda, sono costruite per creare un parallelismo con la violenza più sottile che Fernando sperimenta da “ospite” in Vermont. Il dolore fisico del passato e quello psicologico del presente sono due forme della stessa logica: spezzare resistenza, ottenere obbedienza.
La colonna sonora di Juan Manuel Langarica accompagna questo percorso con discrezione. I temi musicali che accarezzano l’arrivo di Fernando nella neve lasciano intravedere, per un attimo, l’idea di un nuovo inizio. Man mano che la trama procede la musica tende a diradarsi, lasciando spazio a un rumore di fondo fatto di ventilatori, tubi, mungitrici. Anche qui la scelta è coerente: l’America che il film mette in scena è un luogo in cui la macchina del lavoro sovrasta e schiaccia ogni voce.
Invisible America rifiuta con ostinazione qualsiasi catarsi rassicurante. L’ipotesi di una fuga in Canada, altro Nord, altra “terra promessa”, non viene trattata come soluzione definitiva, ma come reiterazione di una spirale. I responsabili dello sfruttamento restano al loro posto, il sistema non viene nemmeno scalfito e, per ogni Fernando pronto a scappare, ce ne saranno altri pronti a prendere il suo posto. È una chiusura frustrante, ma perfettamente in linea con l’urgenza del film: qui non si cercano eroi, si indicano meccanismi.
Christian de la Cortina come regista trova un equilibrio interessante tra dramma intimo e pamphlet sociale. L’approdo on demand su Apple TV (iTunes), Prime Video e sulle principali piattaforme digitali del suo film indipendente, gli offre la possibilità di intercettare un pubblico ampio.
In un’epoca in cui molta produzione si limita a inserire il tema migratorio come sfondo decorativo o come trigger emotivo, Invisible America sceglie la strada opposta: rinuncia alla consolazione per guadagnare in onestà. Non è un film accomodante, non è pensato per rassicurare il pubblico progressista sulla propria coscienza. È un invito scomodo a guardare nei luoghi in cui il sogno americano si regge su mani che non compariranno mai nelle foto ufficiali.
Argomenti: Cinema