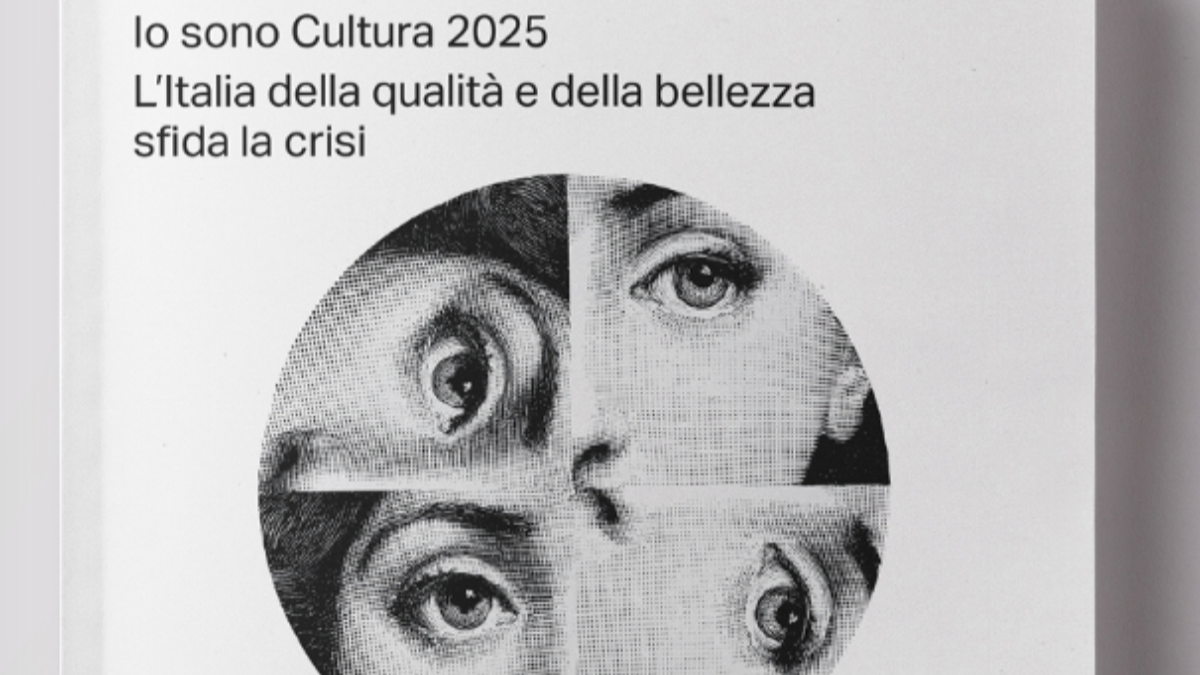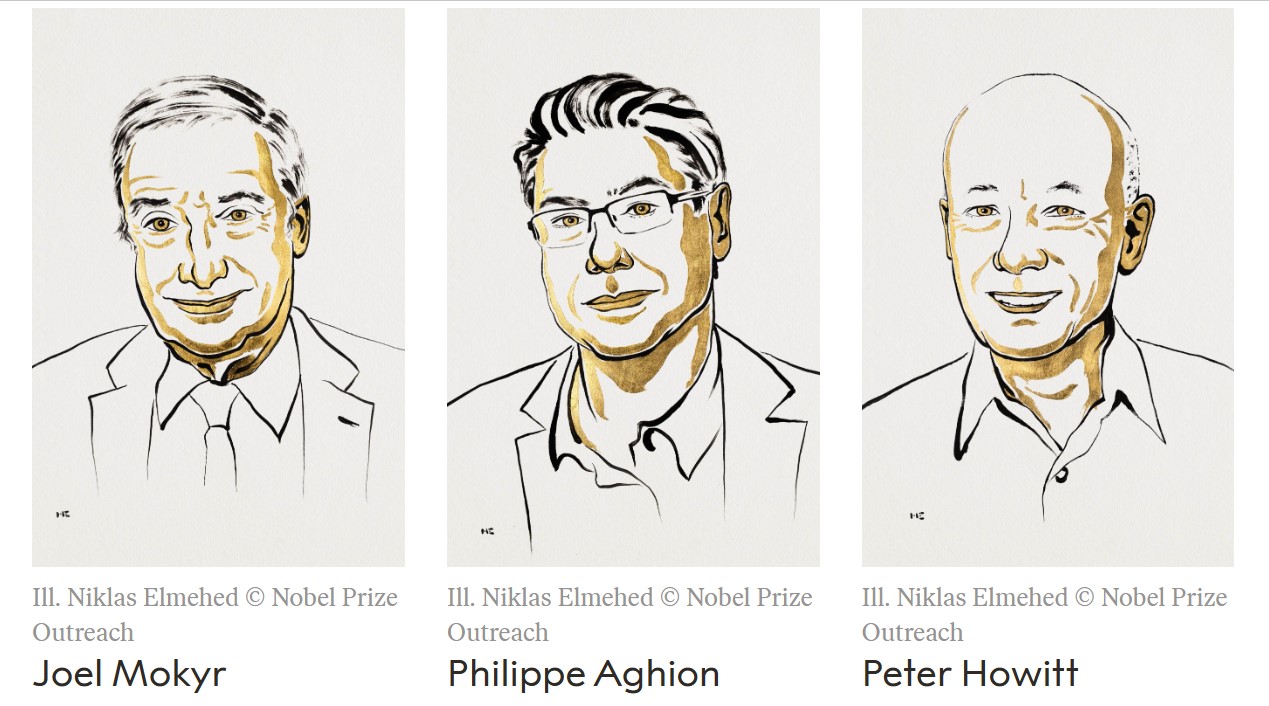di Alessia de Antoniis
Una lettera in cassetta. Un’intimazione di pagamento su carta intestata, firmata da un avvocato, con un linguaggio che sembra quello di un tribunale. Ma non è un atto del giudice. È un atto di parte, che può diventare esecutivo come una sentenza. È il cuore della riforma sul recupero crediti in discussione al Senato: un provvedimento che promette velocità e snellimento burocratico, ma rischia di trasformarsi in una giustizia privata che scavalca il controllo terzo dello Stato.
Il recente disegno di legge sul recupero crediti, a firma Erika Stefani (LSP-PSd’Az) e seguito in Senato dai senatori Gianni Berrino e Salvatore Sallemi (Fratelli d’Italia), parte da quello che è unanimemente considerato un presupposto virtuoso: accelerare e rendere più efficiente il recupero dei crediti nel nostro sistema giudiziario.
È un tema cruciale per la competitività economica del Paese e, insieme, uno dei talloni d’Achille che più penalizzano la percezione dell’Italia agli occhi di investitori e imprese.
Non è un mistero che tempi e costi del contenzioso civile abbiano contribuito a frenare investimenti e fiducia nel sistema.
Il nuovo DDL prende di petto la questione, eliminando passaggi burocratici e riducendo gli arretrati per alleggerire i tribunali e incoraggiando l’autoregolamentazione professionale.
Fin qui, l’intenzione è lodevole.
Il passaggio cruciale: il filtro del giudice scompare
Ma, come troppo spesso accade, la spinta alla semplificazione si traduce in un salto nel buio per le garanzie.
Il cuore della riforma è una novità che cambia la natura stessa del procedimento: l’intimazione di pagamento non passerà più dal vaglio di un giudice, ma sarà emessa direttamente dall’avvocato del creditore. ( “Si propone […] di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo […] direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio.”)
Se il debitore non si oppone entro 40 giorni, l’atto diventa titolo esecutivo, come una sentenza.
Il testo affida la verifica dei requisiti non a un organo terzo, ma allo stesso legale di parte, demandando agli ordini professionali eventuali sanzioni in caso di abuso.
È difficile non leggere, in questa logica, una rinuncia alla terzietà: il difensore del creditore si trasforma in giudice di se stesso, in nome dell’efficienza.
Per chi si trova dall’altra parte (debitore, piccolo imprenditore, lavoratore autonomo, cittadino non assistito) l’impatto rischia di essere pesante.
Riceverà un’ingiunzione privata, redatta nel linguaggio dell’autorità, senza alcuna verifica autonoma, e con quaranta giorni per reagire.
È una asimmetria di potere che mina il principio di uguaglianza processuale e rischia di scaricare sul più debole la responsabilità di difendersi, laddove oggi almeno il giudice funge da filtro, anche se spesso solo formale, contro gli abusi.
I numeri della riforma
Secondo i dati Istat e Ministero della Giustizia, nel 2023 in Italia sono stati avviati oltre 400.000 procedimenti monitori, la forma principale di recupero crediti presso giudici di pace e tribunali, con un’incidenza del 35-40% sul totale del contenzioso civile. Significa che oltre 400.000 debitori (cittadini e imprese) saranno ogni anno direttamente toccati dalla nuova procedura semplificata. È su questa platea che il DDL interviene, affidando a un avvocato di parte la funzione che finora spettava a un giudice dello Stato.
Da buon proposito a rischio per i diritti: un copione già visto
I sostenitori della riforma hanno buon gioco nel ricordare una verità scomoda: i tempi biblici della giustizia civile italiana non penalizzano solo i debitori. Anzi. In molti casi, la lentezza è diventata un’arma nelle mani di chi non vuole pagare, a danno di piccoli fornitori, artigiani, professionisti che aspettano anni per vedere riconosciuti crediti legittimi.
L’Italia ha uno dei peggiori tassi di recupero crediti d’Europa. Questo favorisce l’evasione, il sommerso, la sfiducia contrattuale. E penalizza soprattutto chi non ha le spalle larghe: la microimpresa che ha anticipato materiali, il freelance che ha completato la prestazione, il piccolo fornitore che rischia il fallimento perché il cliente non paga. In questo senso, velocizzare il recupero crediti non è solo una questione di efficienza: è anche una forma di tutela per chi, pur essendo nel giusto, viene stritolato da un sistema che premia chi temporeggia.
Il vero rischio: armare chi ha già più armi
Velocizzare il recupero crediti è sacrosanto. Ma in concreto, questa legge non riequilibra il sistema. Lo inclina ulteriormente a favore di chi ha più mezzi, più consulenza, più capacità di agire rapidamente. E questo, in un Paese dove gli squilibri di potere sono già strutturali, è il vero punto critico.
Chi ha una struttura legale interna o un avvocato di fiducia potrà attivare ingiunzioni in pochi giorni. Chi è dall’altra parte – il debitore che magari contesta la somma, o ha ragioni valide per opporsi – dovrà organizzare una difesa in 40 giorni, spesso senza nemmeno sapere che quell’atto “privato” può diventare un pignoramento.
E questo vale soprattutto per i crediti piccoli, quelli sotto i 5.000-10.000 euro, dove il costo e la complessità di un’opposizione scoraggiano qualsiasi reazione. Proprio la fascia dove il rischio di abuso è più alto e il danno per il singolo più difficile da assorbire.
Non si tratta di criminalizzare i creditori, né di negare che esistano debitori in malafede. Si tratta di capire che, in un sistema già sbilanciato, togliere il giudice dal processo significa togliere l’unico soggetto che – almeno sulla carta – non ha un interesse diretto nell’esito.
Proteggere troppo il debitore può paralizzare l’economia, è vero. Ma l’errore è pensare che la soluzione sia spostare tutto il peso dall’altra parte. I “deboli” non stanno solo da un lato della barricata: includono anche artigiani, freelance, piccole imprese che non vedono mai pagati i loro lavori. Ma includono anche chi, di fronte a un’ingiunzione ingiusta, non ha gli strumenti per difendersi.
Resta poi una domanda: chi controllerà i controllori, quando i controllori sono parte in causa?