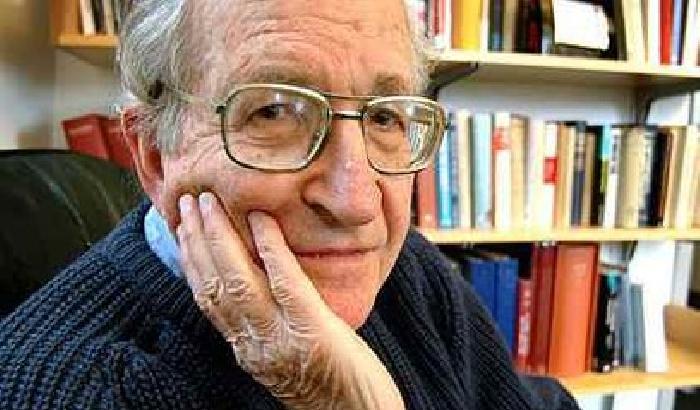C’è un momento, in mare aperto, in cui capisci che la navigazione non è soltanto un movimento tra due coordinate geografiche. Può diventare resistenza e testimonianza. È quello che abbiamo vissuto a bordo della Life Support, la nave di Emergency che ha accompagnato il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande spedizione mai organizzata per tentare di rompere l’assedio a Gaza dal mare. L’ho raccontato nel podcast Verso Gaza, un daily che ora che la missione è finita diventerà settimanale, per non spegnere i riflettori su Gaza.
Il termine sumud in arabo significa resilienza, ostinazione. Non a caso è stato scelto come nome per la flottiglia. Perché ciò che questa missione ha cercato di incarnare non è stato solo il trasporto di aiuti, ma un messaggio politico e umano: mostrare che la società civile internazionale non è disposta a rimanere in silenzio di fronte a un genocidio trasmesso in diretta, giorno dopo giorno.
A bordo delle imbarcazioni c’erano persone molto diverse tra loro. Attivisti esperti e giovani alla prima esperienza, giornaliste, medici, avvocate, ma anche uomini e donne in pensione o in ferie, persone che sapevano guidare una barca o organizzare una stiva e che avevano lasciato le proprie vite per mettersi in mare e testimoniare. Tutti sapevamo che non sarebbe stato semplice, che le possibilità di successo erano ridotte, eppure eravamo consapevoli che fermarsi non era un’opzione.
Più ci avvicinavamo alle coste palestinesi, più la notte sembrava più buia e minacciosa. Le comunicazioni disturbate, i radar che segnalavano presenze sconosciute, le voci via radio che parlavano di droni, di motovedette, perfino di sottomarini. Navigare sotto minaccia significa imparare a convivere con una tensione costante, che filtra in ogni conversazione e in ogni gesto. Eppure, in quella tensione, ho visto nascere qualcosa di più forte: una solidarietà intima, un senso di comunità che ci rendeva meno vulnerabili.
La notte dell’intercettazione la Life Support era lontana dalle barche: ci eravamo fermati a 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza per non permettere all’esercito israeliano di impossessarsi della nave con cui Emergency da ormai tre anni salva centinaia di persone all’anno in mare.
Ci siamo riuniti tutti in Day Room, nel salone principale, collegandoci alla diretta streaming che ci permetteva di vedere cosa succedeva sulle barche e parlando al telefono, ciascuno di noi, con chi conoscevamo dei vari equipaggi. Poi, l’attacco. Un copione già scritto, che tutti sapevano come affrontare per non innescare violenza.
Ma l’immagine che porterò sempre con me non è di quella sera, ma di un paio di sere dopo. Marinette, una delle imbarcazioni più piccole della flottiglia, era rimasta indietro e arriva al punto in cui le sue barche sorelle sono state intercettate ore dopo le altre. Sa che verrà fermata dalla marina militare, ma continua lo stesso la sua missione. A un certo punto un soldato armato sale a bordo, il mitra puntato, e la prima azione è quella di spegnere la telecamera, interrompere ogni comunicazione. In quell’istante, la sproporzione di forze si mostra in tutta la sua brutalità: civili armati solo di bandiere, canzoni e speranza da un lato; un esercito con armi, prigioni e potere dall’altro.
La mia esperienza personale sulla Life Support è stata un continuo oscillare tra tensione e commozione. Tensione, perché la minaccia era reale, costante, tangibile – non tanto per noi, quanto per chi era su quelle piccole imbarcazioni. Commozione, perché lo era anche la solidarietà: nei volti stanchi ma determinati dei passeggeri, nei piccoli gesti di cura reciproca, nel grido che si levava ogni volta che la tensione saliva: Free Palestine.
Sono stati fermati, detenuti, alcuni si trovano ancora nelle carceri israeliane. Ma il viaggio non si misura soltanto nelle miglia percorse. Si misura nella forza del messaggio che ha lasciato dietro di sé. In Italia, in Grecia, in Francia e in tanti altri Paesi, piazze piene hanno risposto alla notizia del sequestro della flottiglia. Hanno dimostrato che la società civile ha strumenti che i governi non sanno o non vogliono usare: la solidarietà, la pressione pubblica, la memoria condivisa.
E proprio la memoria è forse il cuore di questa esperienza. Penso che la Global Sumud Flotilla ci abbia insegnato che non si può solo chiedere agli aggrediti di fuggire, ma si deve chiedere agli aggressori di fermarsi. Ci ha ricordato che raccontare quello che abbiamo visto e vissuto è un dovere. Siamo diventati testimoni oculari non solo della sproporzione militare, ma anche della sproporzione narrativa: da un lato il tentativo di cancellare, di criminalizzare, di ridurre tutto a “vicinanza a Hamas”; dall’altro la realtà di centinaia di civili che hanno scelto di rischiare in prima persona pur di rompere un muro di silenzio.
Il mare, in questi giorni, è stato insieme barriera e possibilità. Barriera, perché la Marina israeliana ci ha impedito di raggiungere Gaza. Possibilità, perché tra le onde è nato un racconto diverso, che ha attraversato confini e media, arrivando in tante case e scuotendo coscienze.
Se c’è un messaggio che porto con me dalla Life Support è questo: i diritti umani o sono universali, o non sono niente. Non possiamo accettare che vengano selezionati, concessi a qualcuno e negati ad altri. Non possiamo accettare che il mare diventi un confine invalicabile per aiuti umanitari, mentre resta aperto al transito delle armi.
La Global Sumud Flotilla è stata fermata. Ma il suo viaggio continua. Continua nelle piazze che si riempiono, nelle voci che si alzano, nelle mani che scrivono. E continua in chi, come me, è tornato a terra con una convinzione ancora più forte: non si può spegnere la coscienza collettiva di chi rifiuta di restare in silenzio.