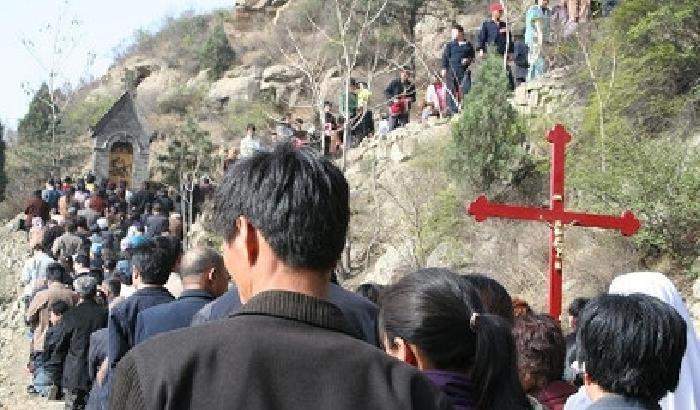di Massimo Faggioli
In un paese come l’Italia in attesa di una discontinuità politica, è singolare che tutte le attenzioni si rivolgano alla chiesa cattolica, un’istituzione che premia la fedeltà alla continuità e alla stabilità: ma si sa che la cultura politica del cattolicesimo non si è ancora completamente riavuta dall’età delle rivoluzioni. Tuttavia, non è singolare che la chiesa italiana sia stata percepita da molti italiani, fino ad oggi, come uno dei tanti partner di fatto di Berlusconi e del berlusconismo. Ora, al più autorevole di questi partner di fatto, alla chiesa italiana e ai suoi vescovi in particolare, si chiede di prendere le distanze in via definitiva non solo da un governo zombie, ma anche da uno stile politico e da una certa “cultura di governo” incarnata dal premier.
Nel discorso del presidente della CEI, cardinale Bagnasco, la presa di distanza c’è stata: ma se la questione del futuro politico della chiesa e dei cattolici nell’Italia post-berlusconiana è ancora aperta, non meno aperta è la questione ecclesiale che sta a monte della questione politica. Nel suo discorso Bagnasco ha dedicato qualche riferimento all’associazionismo come “soggetto culturale e sociale” in grado di interloquire con la politica di domani. Ma un cambio di regime del genere contiene diversi elementi di novità che vanno ben oltre la “scomunica” ad un premier già screditato o la benedizione ad un movimentismo cattolico da sempre impegnato nel sociale. Infatti, per quanto l’opposizione in Italia sia comprensibilmente restia a qualificare quello berlusconiano come “regime” per timore di impropri confronti col regime fascista, dal punto di vista storico la soglia che si para davanti alla chiesa italiana è quella della fine di un regime. La reimmissione, a nuovo titolo, dei cattolici italiani all’interno del circuito della politica italiana è complicato, anche al netto dei ragionamenti sugli schieramenti: specialmente dopo la scalata al governo di politici cattolici autonominatisi garanti della morale cattolica del berlusconismo, sedotti e abbandonati ai piedi dell’altare politico da un fidanzato, Berlusconi, di cui avevano presunto, se non la castità, almeno la cautela.
I “cattolici italiani” sono una categoria politica di cittadini nata con la fine dello Stato pontificio, di cui la chiesa italiana ha avuto il coraggio (per nulla ovvio) di festeggiare i 150 anni. Dal punto di vista storico, la loro partecipazione alla vita politica italiana si può dividere in tre macro-fasi: nella prima fase, all’inizio del Novecento, in meno di trent’anni tre preti, Buonaiuti, Murri, e Sturzo, fondano la cultura e la politica dei cattolici italiani. Nella seconda fase, tra gli anni Trenta e la fine della guerra, cattolici come Dossetti, De Gasperi, Lazzati, Moro, Fanfani, La Pira rifondano la partecipazione alla politica italiana dei cattolici in proprio: tutti laici, molti di essi usciti dall’Università Cattolica di padre Agostino Gemelli, ma tutti legati all’istituzione ecclesiastica non meno di quanto non fossero devoti alle forme della vita cristiana e alla sua cultura profonda. La terza fase si presenta, oggi, assai diversa: dopo la prima generazione, quella dei preti, e la seconda, quella dei laici consacrati (anche dal punto di vista del diritto canonico) alla chiesa e alla politica, oggi la chiesa italiana deve affidarsi ai cattolici di un laicato cattolico senza aggettivi, tout court. Vi è un’ulteriore differenza rispetto al passato: la mancanza di un papa italiano e di una Curia romana consapevoli della posta in gioco dal punto di vista politico.
Nella chiesa globale è finito per forza di cose il neotemporalismo papale, ed è sul laicato cattolico italiano che la chiesa e la politica italiana devono interrogarsi. Se all’ecclesiologia è lecito farsi (ancora una volta) nascosta ancella della politica, conviene dire che il cattolicesimo italiano oggi ha molte risorse a cui attingere. Al netto del “progetto culturale” del cardinale Ruini di cui forse vedremo i frutti un giorno, sono l’associazionismo e il movimentismo cattolico che costituiscono il serbatoio di energie, esperienze e idee che possono essere catalogate non abusivamente come “cattoliche”. Il patriottismo costituzionale del cattolicesimo italiano non è una risorsa trascurabile. Basterebbe comparare il vocabolario dei cattolici italiani da un lato, e quello di altri cattolicesimi (anche quelli emergenti, come quello statunitense) dall’altro, per comprendere il profondo patrimonio di cultura costituzionale che emerge dal cattolicesimo italiano. Diversamente da altri cattolicesimi, in quello italiano “Stato” e “Costituzione” sono ancora elementi unificanti per una visione di società in cui il vivere comune non sia tenuto insieme soltanto dalla carità intesa come elemosina: lo tenga presente chi, da entrambe le parti, ha già liquidato i cattolici italiani come geneticamente predisposti al moderatismo.
Argomenti: silvio berlusconi