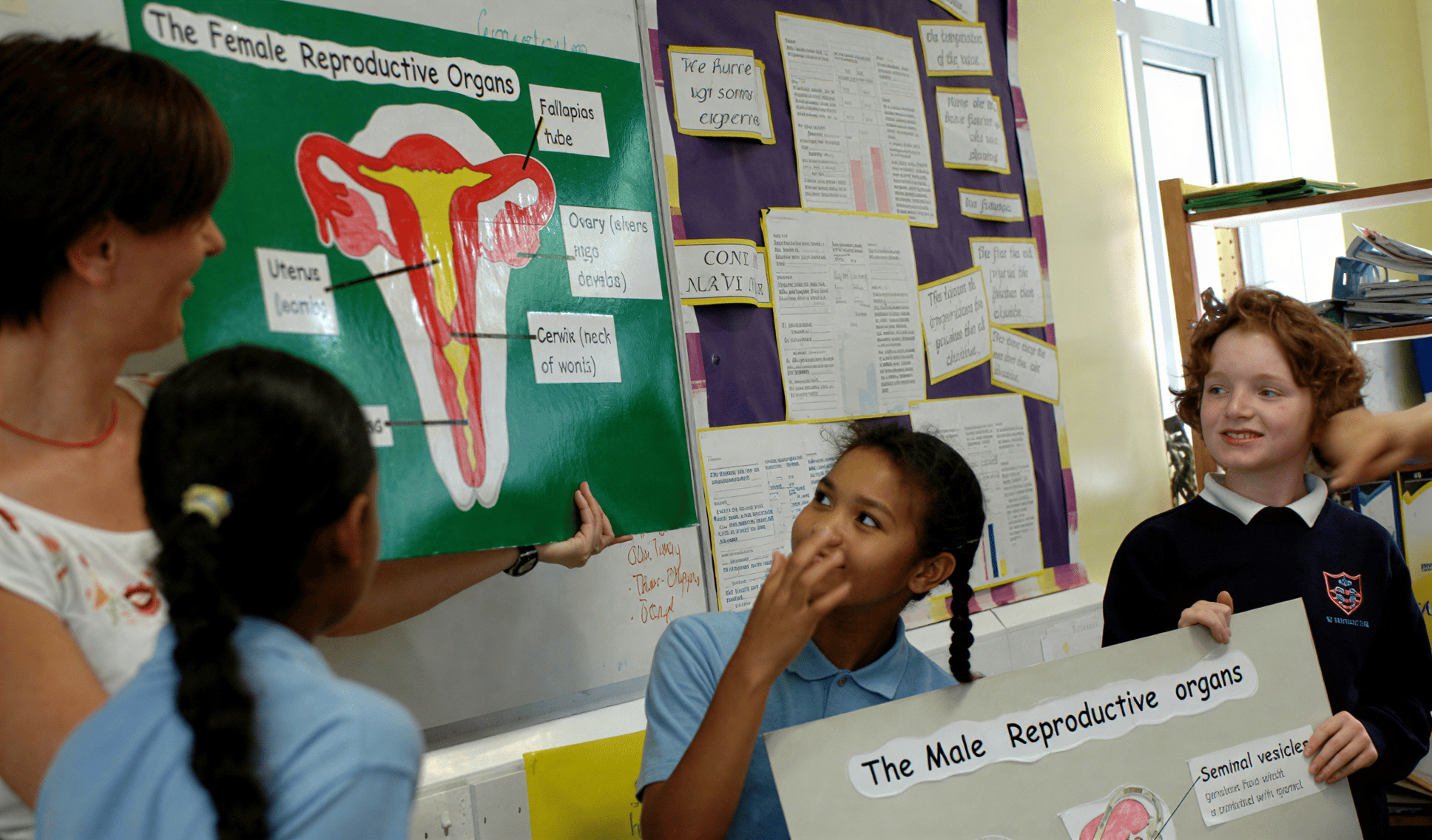Nel pieno dello sviluppo finanziario di New York, nella metà dell’800, all’interno di uno studio legale collocato a Wall Street, Herman Melville, lo scrittore di Moby Dick, racconta la vicenda di uno scrivano, un copista di nome Bartleby, che mette in scena una delle rivolte più misteriose e inquietanti che la letteraturi abbia mai proposto.
In un crescendo sempre più incomprensibile lo scrivano si rifiuta di adempiere ai suoi doveri di ufficio, e per giustificare la propria indisponibilità si limita a rispondere che preferirebbe non farlo. Nell’originale inglese questo diniego viene espresso con la formula I would prefer not to, senza ulteriori spiegazioni. Il comportamento di Bartleby non muta, nonostante i tentativi del datore di lavoro, la sua cocciutaggine lo spinge in un baratro, che si conclude con l’arresto, la prigione e la morte per inedia.
In questi giorni alcuni studenti si sono rifiutati di rispondere alle domande dell’orale dell’esame di maturità. Uno di loro ha giustificato la propria decisione dicendo “Io mi fermo qui”. Sono stati tutti promossi, poiché avevano raggiunto il punteggio minimo per il superamento dell’esame e l’acquisizione del diploma. Il Ministro Valditara ha replicato con durezza ed ha promesso che cambierà le regole dell’esame, perché non si può permettere di prendere in giro gli insegnanti, i compagni e tutti coloro che credono nelle regole, dal momento che, conclude il Ministro, a quel punto “sarebbe legittimo rifiutare tutto ciò che non ci piace”. Tra gli studenti che si sono rifiutati di sostenere il colloquio qualcuno di loro ha spiegato la ragioni del rifiuto, individuate soprattutto nel sistema scolastico che premia la competizione e scoraggia il dialogo educativo, ed ha suggerito un’idea alternativa di scuola, non più fabbrica di voti e di prestazioni, ma luogo di incontro, di scambio e di crescita culturale e umana.
C’è qualche collegamento tra lo scrivano Bartleby, lo studente Gianmaria Favaretto e gli altri suoi colleghi che lo hanno seguito in questa rivolta?
Bartleby è un copista, deve trascrivere in maniera meccanica e ripetitiva atti giudiziari, il suo lavoro è alienante, fa parte di un sistema nel quale l’individuo è un semplice ingranaggio, privato di autonomia, di capacità decisionale; anche l’istruzione è diventata un sistema rigido, regolato dal principio di prestazione, valutata secondo i criteri dell’efficienza e dell’utilità, e gli studenti, come in realtà anche i docenti, sono esecutori di una logica che si conforma alle dinamiche della produzione industriale, piuttosto che alla trasmissione del sapere e della conoscenza. Nell’attuale sistema scolastico gli studenti devono memorizzare e ripetere delle nozioni, secondo standard quantitativi, che vengono rigorosamente calcolati e tradotti in valutazioni numeriche, che diventano la misura della loro produttività. L’impianto dell’istruzione non prevede la partecipazione attiva dello studente, perché ogni momento del cosiddetto dialogo educativo è finalizzato alla messa in opera di una prestazione, che il docente dovrà valutare.
La logica di questa relazione, che viene comunemente accettata, è assurda, ed è stata riassunta magistralmente da Ionesco nella Lezione, un testo teatrale ispirato al rapporto educativo, seppure in forme paradossali. Il professore propone delle semplici questioni di aritmetica, di filologia, di fronte alle quali l’allieva si disorienta, mandando in collera il suo istitutore, che reagisce in maniera sempre più violenta e irrazionale. Il testo di Ionesco mette in scena l’assurdo dell’educazione: il docente rivolge delle domande al discente, per mettere alla prova l’abilità dell’allievo, senza tuttavia interrogarsi sul valore formativo, educativo dei contenuti della lezione. L’allievo, incalzato dall’interrogatorio, si smarrisce e, divorato dall’ansia, non sa più rispondere, finendo per sembrare un perfetto idiota.
Di fronte a questo scempio ci si chiede: qual è lo scopo dell’istruzione? Creare persone, individui pensanti e libere di giudicare e di scegliere, oppure formare in maniera violenta nuovi servi che imparino ad eseguire ordini?
Gli studenti che si sono rifiutati di sostenere il colloquio hanno ricevuto critiche anche sulla scelta dei modi con cui hanno espresso il dissenso. Alcuni hanno parlato di indignazione, lasciando intendere che fosse del tutto inutile e sterile, ma forse è il caso di ricordare che Stéphan Hessel, combattente della Resistenza francese e diplomatico, scrive e pubblica nel 2010 un pamphlet che si chiamava proprio Indignatevi!, rivolto soprattutto ai giovani, con il proposito di attivare forme di ribellione nei confronti di tutto ciò che nel mondo deve essere cambiato. Indignarsi per le guerre, le ingiustizie sociali, la negazione dei diritti umani, l’emergenza climatica ed ecologica, è il segno che c’è ancora coscienza e speranza di cambiamento.
Sorprende e dovrebbe far riflettere gli adulti e soprattutto il mondo della scuola la forma di questa indignazione. Una protesta silenziosa, al limite della disobbedienza civile, lontana dalle coreografie colorate dei cortei, delle occupazioni, degli scioperi; si è trattato di una rivolta individuale e muta, come se il dissenso non avesse più un vocabolario, un lessico adeguato, e il mutismo di fronte alla richiesta dell’ennesima prestazione fosse l’ultima forma di resistenza, un appello che al momento non ha trovato alcun ascolto, ma la furiosa reazione di un potere sempre più chiuso nella propria autosufficienza.