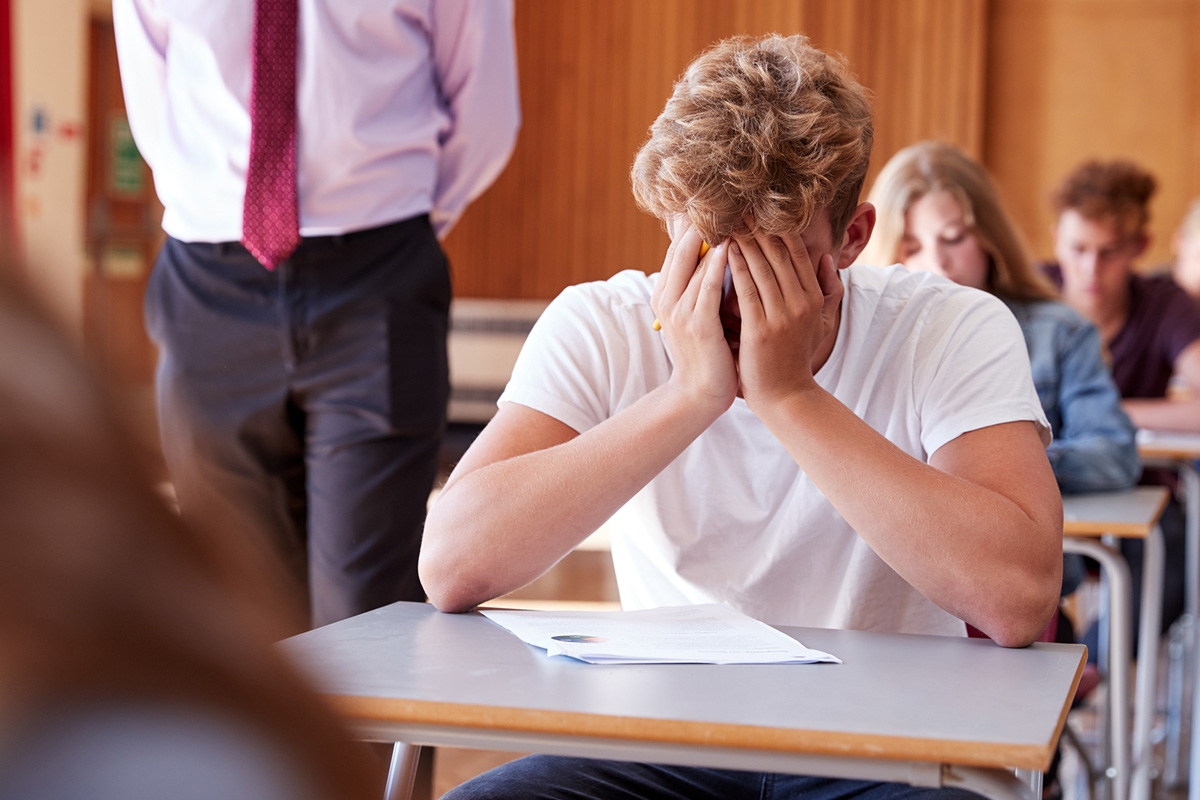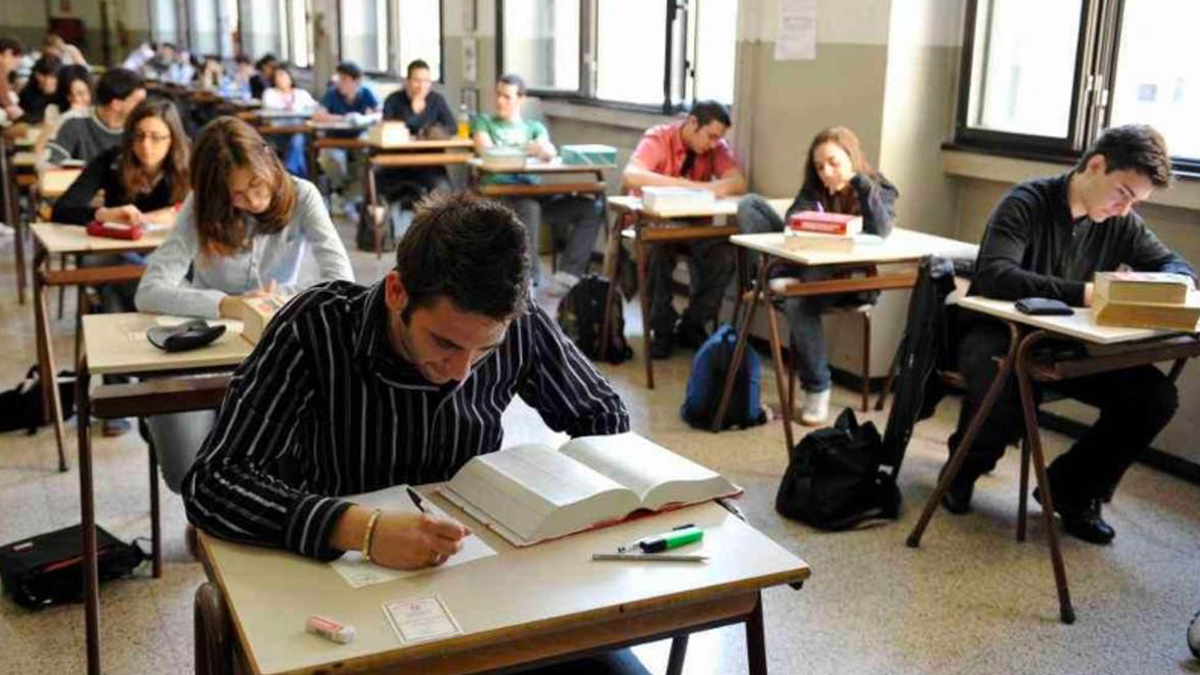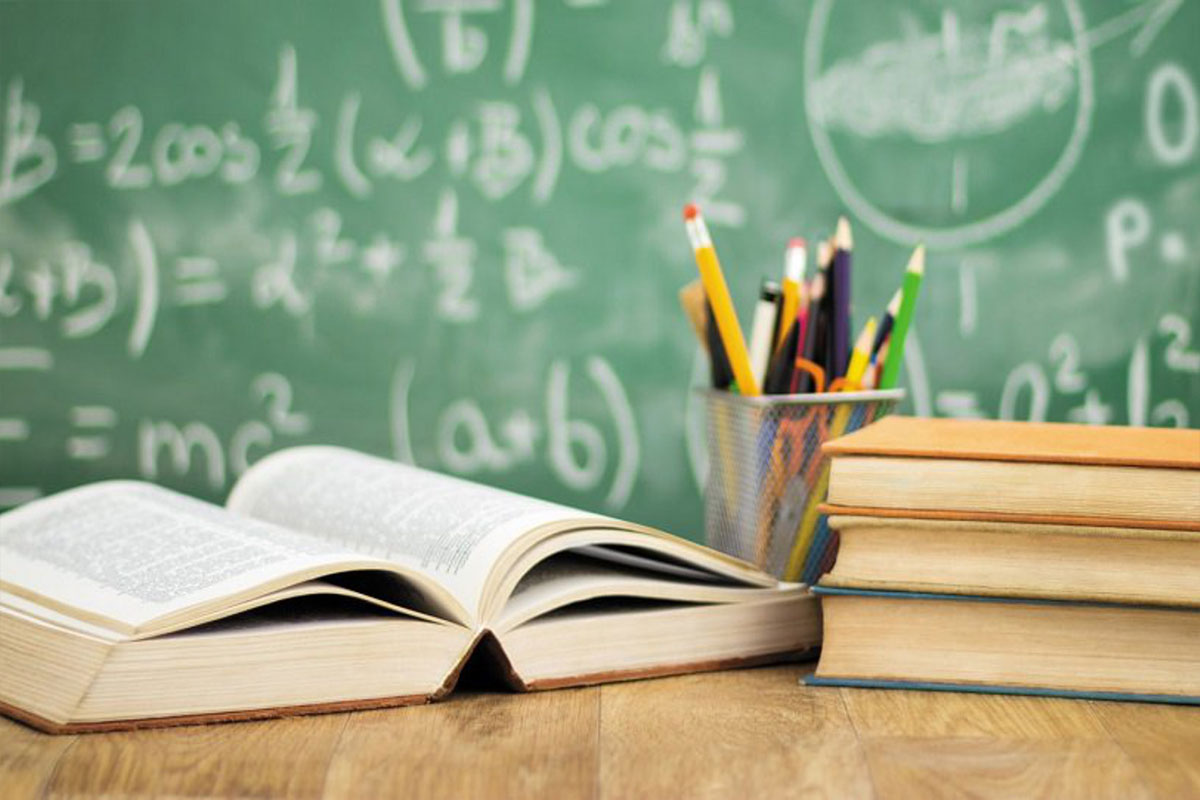Sui ragazzi che hanno rifiutato di sostenere la prova orale durante l’esame di maturità ne sono state dette di ogni. E in questo rincorrersi nell’esprimere giudizi mediatici su ciò che è accaduto ci si dimentica, spesso, di guardarsi criticamente indietro.
Quando i giovani studenti degli anni Sessanta protestavano per promuovere un cambiamento culturale, sociale e politico, contro le guerre e il classismo, le generazioni adulte di allora li additavano come ingenui e utopisti, che non conoscevano la realtà del mondo e cercavano un cambiamento senza sapere davvero cosa volesse dire governare o costruire qualcosa di solido.
Eppure, quelle stesse proteste non solo hanno portato alla rivoluzione culturale più importante del secolo scorso, ma nel 1969 in Italia, spinsero per la promozione della legge Codignola, che ha aperto le porte degli atenei a tutti gli studenti provenienti da qualsiasi istituto superiore.
Quando quelle rivolte studentesche si sono unite a quelle degli operai che occupavano fabbriche contro il caporalato, la crisi economica e le disuguaglianze, nel 1970 hanno ottenuto lo Statuto dei Lavoratori, che oggi resta un testo fondamentale per il Diritto del lavoro. È accaduto di nuovo quando questi movimenti hanno affrontato la questione femminile portando alla legalizzazione del divorzio, alla riforma del diritto di famiglia e all’approvazione della legge sull’aborto.
E ancora: negli anni Ottanta con l’obiezione di coscienza, per protestare contro la leva militare obbligatoria, frutto dell’occupazione delle scuole, degli scioperi e delle contestazioni contro il sistema dell’istruzione. Negli anni Novanta e Duemila con i sit-in contro i tagli ai fondi, con le manifestazioni contro il classismo e la penalizzazione di alcuni istituti della legge Moratti e il calo dell’offerta formativa della riforma Gelmini.
In tutti questi casi, negli anni Sessanta come oggi, i giudizi critici e ideologici sono sempre state le sole e uniche risposte da parte delle classi dirigenti e di una parte della società adulta alle lotte (non violente) dei giovani studenti che manifestano per i propri diritti.
I ragazzi che hanno rifiutato di sostenere la prova orale durante l’esame di maturità sono così entrati di diritto in una spirale critica: additati come figli di una generazione di disertori del dovere; come giovani che hanno (riporto testualmente) “preso pochi schiaffi da piccoli”; che devono imparare a vivere e fare la gavetta; che sono degli “scansafatiche amorali che non conoscono il significato della parola rispetto”. Il paternalismo inutile di chi nasce incendiario e muore pompiere, di chi si dimentica di essere stato giovane e studente, che non funzionava allora e non funziona nemmeno oggi.
C’è anche chi, leggendo i vari interventi sulla questione, si indigna quando alcuni, come la sottoscritta sta per fare, mette insieme queste proteste con quelle vere, quelle degli anni Sessanta e Settanta. E mi domando: perché? Perché una protesta ha più diritto di essere giudicata come tale rispetto ad un’altra? Perché quelle di questi ragazzi che hanno rifiutato di sostenere l’orale non può essere una protesta, ma solo un capriccio di una generazione di social-inebetiti?
Eppure, per antonomasia, ogni protesta giovanile racconta un disagio, esprime un parere contrario a forme di ingiustizia e la volontà di cambiare qualcosa che non funziona, al di là delle forme o dei gesti compiuti. E invece di andare a fondo, di capirne i motivi, continuiamo solo a giudicarne i modi, criticando le modalità di protesta e tutto il fastidio che creano al sistema e alla società.
Ma le proteste nascono per dare fastidio, per essere plateali, rumorose e fuori dagli schemi; non c’è un libretto delle istruzioni o manuali da seguire e questi studenti hanno trovato il loro modo di protestare, di far sentire la propria voce. Dovremmo invece essere contenti di aver a che fare con giovani che – nonostante le storture della loro generazione che tutti freneticamente vogliono evidenziare – hanno trovato la loro dimensione per parlare di ciò che oggi nelle nostre scuole non va.
La verità è che – come dichiarano molti docenti – in un sistema scolastico che spinge gli insegnanti ad essere empatici, a costruire la scuola dell’inclusione, a formarli per redigere progettazioni complicatissime per favorire la centralità dello studente, una didattica inclusiva, attenta ai bisogni di tutti e alle diverse modalità di apprendimento, in realtà avviene esattamente il contrario.
Alla prima manifestazione di maturità degli studenti, alla prima dimostrazione di autonomia di pensiero e di responsabilizzazione delle proprie azioni, argomentando pienamente le scelte fatte contro un sistema di regole ingiuste, vengono sanzionati e penalizzati con giudizi ignobili e diffamatori e con minacce. Una scelta dimostrativa, quella di questi ragazzi che, purtroppo, non trova sostegno dove dovrebbe, e cioè proprio nella scuola.
La scuola serve a dare parola e possibilità a tutti, a rendere gli studenti dei coscienti cittadini, soggetti consapevoli delle proprie capacità, lavorando “dal basso” affinché ogni individuo possa acquisire una conoscenza e sviluppare il pensiero critico. E viste le argomentazioni fornite dagli stessi studenti “disertori” in sede d’esame, mi sembra inutilmente ridondante continuare a dibattere ancora su questo.
Anche perché, ci terrei a sottolineare come, secondo le normative ministeriali vigenti, oltre alla conoscenza delle materie, la prova orale dell’esame di maturità 2025 sussisteva in “un colloquio multidisciplinare, per valutare le capacità dello studente di collegare, argomentare criticamente e riflettere sulle proprie esperienze”. È una protesta che ha, in parte, battuto la scuola del merito al suo stesso gioco, rivelando come il nostro sistema educativo – e soprattutto quello d’esame – sia pronto ad accorre in aiuto allo studente che fa scena muta per impreparazione ma non per insubordinazione.
Forse quindi non è nemmeno un problema di merito in questo caso, ma per le classi dirigenti è un problema di (mancata) disciplina. Valditara, infatti, dice che “chi boicotta la maturità non può farla franca” e chiede il rispetto delle regole che però, secondo il decreto non sono state violate (forse il ministro ha bisogno di una rilettura delle leggi da lui stesso scritte) promettendo una riforma – l’ennesima – per evitare che mosse come questa si ripetano.
Di nuovo così si ripete sempre la stessa risposta, quella del giudizio critico, del fastidio e dell’ostilità nei confronti di una generazione che vedrà ancora più limitati i suoi margini di espressione di libertà.
Finiamola di essere degli integerrimi difensori della morale e del rispetto pubblico e ad ogni generazione riconosciamo la sua forma di protesta, che siamo d’accordo o meno. Piuttosto apriamo le orecchie, ascoltiamo il disagio che questi studenti manifestano, perché quando avranno smesso di protestare, quando non parleranno più, sarà allora che, moralmente, la scuola e la società avranno perso valore.