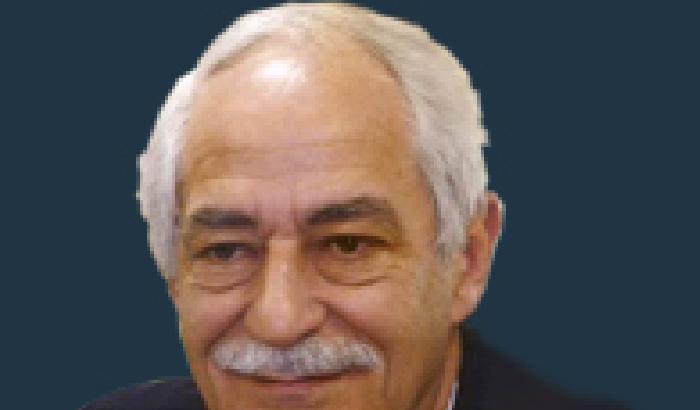Cercherò di lasciare ad Antonio Spadaro il tempo necessario per entrare nel vivo del suo nuovo libro Da Leone a Francesco, che contiene anche un’intervista inedita al cardinale Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV. Si tratta di una conversazione che Prevost tenne anni fa in una parrocchia agostiniana dell’Illinois: un testo molto interessante per comprendere Papa Francesco letto attraverso gli occhi di un suo amico e confidente, e per riflettere sul modo in cui egli presentava il senso della misericordia e della Chiesa.
Prima però, qualche parola sull’autore. Qualcuno diceva poco fa: “Io la vedo sempre in televisione”. Lo confesso, è vero anche per me: Spadaro riesce a farmi accendere la TV, cosa che mi capita di rado. Non tanto per i programmi in sé, ma per le conversazioni che lo coinvolgono: hanno sempre qualcosa di interessante. Forse perché Antonio Spadaro, oltre a essere giornalista e direttore de La Civiltà Cattolica, rivista dei gesuiti nota per la qualità del suo giornalismo culturale, è anche un teologo. Ed è proprio questo che lo distingue: riesce a unire rigore e capacità comunicativa.
Talvolta, lo confesso, alcuni suoi libri mi lasciano un po’ smarrito: parlano da teologo a teologi, e non è facile seguirli. Ma altre opere, come questa, hanno un carattere divulgativo nel senso più alto del termine: riescono cioè a comunicare in profondità, senza ridurre la complessità, superando il linguaggio degli “addetti ai lavori”.
In Da Leone a Francesco Spadaro riesce ancora una volta a fare proprio questo: unire teologia, giornalismo e capacità narrativa. Il libro ci permette di attraversare la soglia tra due pontificati, cogliendo il filo che li lega. Un filo che, secondo Spadaro, si può riassumere in una parola: inquietudine.
E allora gli chiediamo di raccontarci come è nato questo libro, che cosa raccoglie dell’eredità di Francesco, che cosa rivela del nuovo Papa e in che senso l’inquietudine rappresenta la chiave di continuità tra i due.
Antonio Spadaro
Buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui, finalmente. Gianni Cipriani mi insegue da un anno e mezzo per questa presentazione: non volevo fare il prezioso, ma la mia vita è un puzzle difficile da comporre. Domani mattina dovrò già prendere un aereo, quindi cercheremo di essere essenziali.
Vorrei partire da una domanda semplice: perché ho scritto questo libro? In realtà non avevo intenzione di farlo. Poi, come era accaduto nel passaggio da Benedetto XVI a Francesco, mi sono accorto che era necessario. Anche allora scrissi un libro, Da Benedetto a Francesco, perché in ogni passaggio di pontificato si trasmette qualcosa, un testimone, un’eredità viva.
Il modo in cui un Papa lascia e un altro arriva diventa un sismografo della vita della Chiesa e del mondo. È un momento di intensità storica che rivela più di quanto sembri. Stavolta, però, c’era anche una motivazione personale: ero legato a Papa Francesco, che ho accompagnato in 63 Paesi del mondo. Un’esperienza che ti segna profondamente, e di cui sto ancora cercando di comprendere fino in fondo gli effetti.
Nel passaggio tra Francesco e Leone XIV ho percepito qualcosa che mi ha spinto a scrivere: il modo in cui questo nuovo Papa veniva subito interpretato – o meglio, mal interpretato. Appena eletto, il cardinale Prevost è stato presentato sui social come o il “Francesco II” o il suo opposto, “l’anti-Francesco”. Il dibattito si è acceso su dettagli marginali: la mozzetta, le scarpe, la fascia. Tutto, tranne che sulle sue parole. Nessuno ascoltava ciò che Leone XIV stava dicendo.
Allora ho deciso: ascoltiamolo davvero. Il libro nasce da questa esigenza, come un sismografo del passaggio tra due pontificati.
E che cosa ho scoperto? Innanzitutto che Leone XIV ha dichiarato apertamente che il programma del suo pontificato è l’eredità del Concilio Vaticano II, letto alla luce dell’Evangelii gaudium. E questa è una scelta netta, di continuità.
Vorrei ricordare un episodio personale. Il 28 agosto 2013, mi trovavo a Santa Marta con Papa Francesco, mentre concludevamo l’intervista che sarebbe uscita su La Civiltà Cattolica e che fece scalpore in tutto il mondo. In quel colloquio si fronteggiavano in me due anime: il giornalista, che pensava “questo è uno scoop incredibile”, e il prete, che diceva “attenzione, queste parole vanno maneggiate con cura”. A un certo punto gli dissi: “Santo Padre, alcune di queste cose non possiamo pubblicarle”.
E lui rispose: “No, scrivile. Te le sto dicendo perché voglio che siano dette”. In quel momento capii di essere seduto su un vulcano. E in effetti quella fu l’eruzione iniziale del pontificato, con gesti di forte discontinuità e un impatto mediatico enorme.
Leone XIV, invece, si è presentato con un passo diverso — direi, felpato. Ma non per discontinuità: semplicemente, perché ogni tempo richiede un ritmo proprio.
Francesco ci ha parlato di una “Chiesa in uscita”, “ospedale da campo”. Leone parla di una “Chiesa estroversa”. Due immagini affini, due spiritualità che si corrispondono: quella gesuitica, fondata sul discernimento, e quella agostiniana, radicata nel cuore inquieto dell’uomo.
Questa parola — inquietudine — è la chiave. Mi è rimasta impressa dal giorno in cui, proprio al termine dell’intervista del 2013, Papa Francesco mi salutò dicendo: “Inquietudine”.
Dove andava? Alla chiesa degli Agostiniani, per incontrare padre Prevost. L’omelia che pronunciò quel giorno conteneva la stessa parola che, dieci anni dopo, ha segnato l’inizio del pontificato di Leone XIV. Le due omelie iniziano quasi con le stesse parole. Da lì ho compreso la continuità profonda.
Per entrambi, l’inquietudine è una grazia spirituale. Francesco diceva: “Solo l’inquietudine dà pace”. Non la quiete piatta, ma il cuore in movimento. Leone, figlio di Agostino, conosce bene questa tensione: inquietum cor nostrum, finché non riposa in Dio. Entrambi condividono una fede che non teme il divenire della storia, ma lo abita con fiducia.
L’inquietudine di Francesco nasceva dal percepire le tensioni reali. Una volta, durante un Sinodo che sembrava scorrere serenamente, mi disse: “Non va bene. Se non vedo tensioni, significa che non le stiamo affrontando”. Poco dopo mi chiese di “fare qualcosa”, e quando lo feci — vi risparmio i dettagli — scoppiò un putiferio. Lui sorrise, sollevato: finalmente vedeva le forze in gioco, e poteva discernere. Solo l’inquietudine dà la pace.
Da questa eredità spirituale discende tutto: la misericordia, la fratellanza, la libertà dello Spirito. Francesco diceva: “Dio non è cattolico”, non per provocazione, ma per ricordare che lo Spirito soffia dove vuole. Dio agisce nei cuori, anche oltre i confini della fede istituzionale. Il suo pontificato ha cercato questa libertà, questa apertura: Todos, todos, todos — tutti, tutti, tutti.
Leone XIV ne ha raccolto il testimone. Lo si vede già dal suo primo documento, Dilexit te, dedicato ai poveri: una chiara eredità del “vorrei una Chiesa povera per i poveri” di Francesco. Lo si vede nella sua attenzione alla pace e all’ecologia integrale. La sua prima parola dalla loggia è stata “pace”: non “pace a voi”, ma “pace a tutti voi”.
E nei suoi discorsi ha descritto con lucidità il nostro tempo: “Emergere di nuovi centri di gravità, instabilità di antiche alleanze, influenza senza precedenti delle multinazionali e delle tecnologie”. In due righe, la fotografia del mondo.
Il tema della misericordia
Riccardo Cristiano
Nell’intervista a Prevost, c’è un passaggio in cui egli cita Papa Francesco: “Ci sono già molte persone che condannano. Non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di ministri che vivano e offrano la misericordia, il perdono e la guarigione di Dio”.
Prevost aggiunge: “Se solo riuscissimo a capire che Francesco è esattamente questo”.
Vorrei capire meglio: che cosa significa, davvero, misericordia, in questo contesto?
Antonio Spadaro
È un tema strutturale nel pontificato di Francesco. In italiano, la parola “misericordia” suona talvolta pietistica, ma in realtà è potente. È nel suo motto episcopale — Miserando atque eligendo — e lui stesso coniò il verbo “misericordiare”. Arrivò perfino a inventare la “misericordina”, un gesto ironico ma rivelatore: la misericordia come medicina per il cuore.
La parola ha anche una portata interreligiosa. In un dialogo con un imam amico, ricordo che mi disse: “Dio è Al-Rahman, il Misericordioso”. E nei contatti con i buddisti ho scoperto che “misericordia” è più comprensibile di “carità”: per loro Buddha è il misericordioso. Francesco ha trovato una parola che unisce, una lingua spirituale comune.
La misericordia è il primato dell’incontro sull’ideologia, del cuore sul giudizio. Francesco lo ha mostrato in gesti concreti: visitando Emma Bonino malata e portandole cioccolatini e fiori, nonostante le differenze politiche e religiose. O lavando i piedi a carcerati, donne e persone transessuali. Persino al momento della sepoltura volle accanto a sé carcerati e trans, ognuno con una rosa bianca.
La misericordia, in fondo, è questo: riconoscere l’altro come luogo della presenza di Dio, prima di ogni giudizio.
Inquietudine e politica
Domanda dal pubblico.
Padre Spadaro, lei ha parlato del ruolo morale del Papa. Ma non pensa che tra Francesco e Leone XIV ci sia un rapporto diverso con la radicalità del Vangelo, con quella libertà profetica che sfida le logiche del potere?
Antonio Spadaro
È una domanda cruciale. Ogni Papa risponde al proprio tempo. Francesco è stato profetico e, in certo senso, “scapigliato”. Leone è figlio di un’altra storia: americano di Chicago, agostiniano, missionario in Perù, uomo di frontiera. Non proviene dalla Curia, e questo è già un segno. La sua vocazione è pastorale, concreta, vissuta tra la gente.
La sua priorità è la pace, dentro e fuori la Chiesa. Non un ritorno al passato, ma un abbassare il volume per permettere alle voci di emergere. Ha ascoltato con lo stesso rispetto il cardinale Burke, legato alla messa in latino, e padre James Martin, promotore del dialogo con le persone LGBTQ+. È uno stile che lascia spazio, un modo diverso di essere radicale: non gridando, ma ascoltando.
Alla fine, la sfida di entrambi è la stessa: mantenere l’unità nella diversità. L’ultimo Sinodo di Francesco si è chiuso con un documento approvato dal 97% dei membri. È il segno che l’inquietudine, se abitata con fede, può generare comunione.
Fare “lio”: la ribellione dell’inquietudine
Domanda dal pubblico.
C’è una parola di Francesco che mi ha sempre colpito: hacer lío, “fare casino”. Quanto è importante, oggi, questa provocazione?
Antonio Spadaro
Fondamentale. Ricordo bene quando la pronunciò per la prima volta, in Brasile, durante la Giornata Mondiale della Gioventù. I media vaticani non sapevano come tradurla. Ma il senso era chiaro: hacer lío significa non restare immobili, non lasciarsi anestetizzare dal conformismo. È l’inquietudine che diventa azione, profezia.
Francesco non voleva il caos, ma il movimento. Diceva: “I cervelli non devono finire all’ammasso”.
Lo si è visto in due momenti emblematici: a Cuba, quando invitò i giovani di ogni orientamento — cattolici, comunisti, credenti e non — a lavorare insieme per il bene comune; e in Iraq, quando chiese a musulmani e cristiani di costruire insieme la patria. “Fare casino” significava questo: unire le forze diverse per costruire una società più giusta e più unita.
Discussione con padre Spadaro su “Da Francesco a Leone”
Transizione tra pontificati, misericordia e inquietudine Discussione con padre Antonio Spadaro sul suo libro “da Francesco a Leone”. all’iniziativa “Tivoli città della pace e del dialogo”
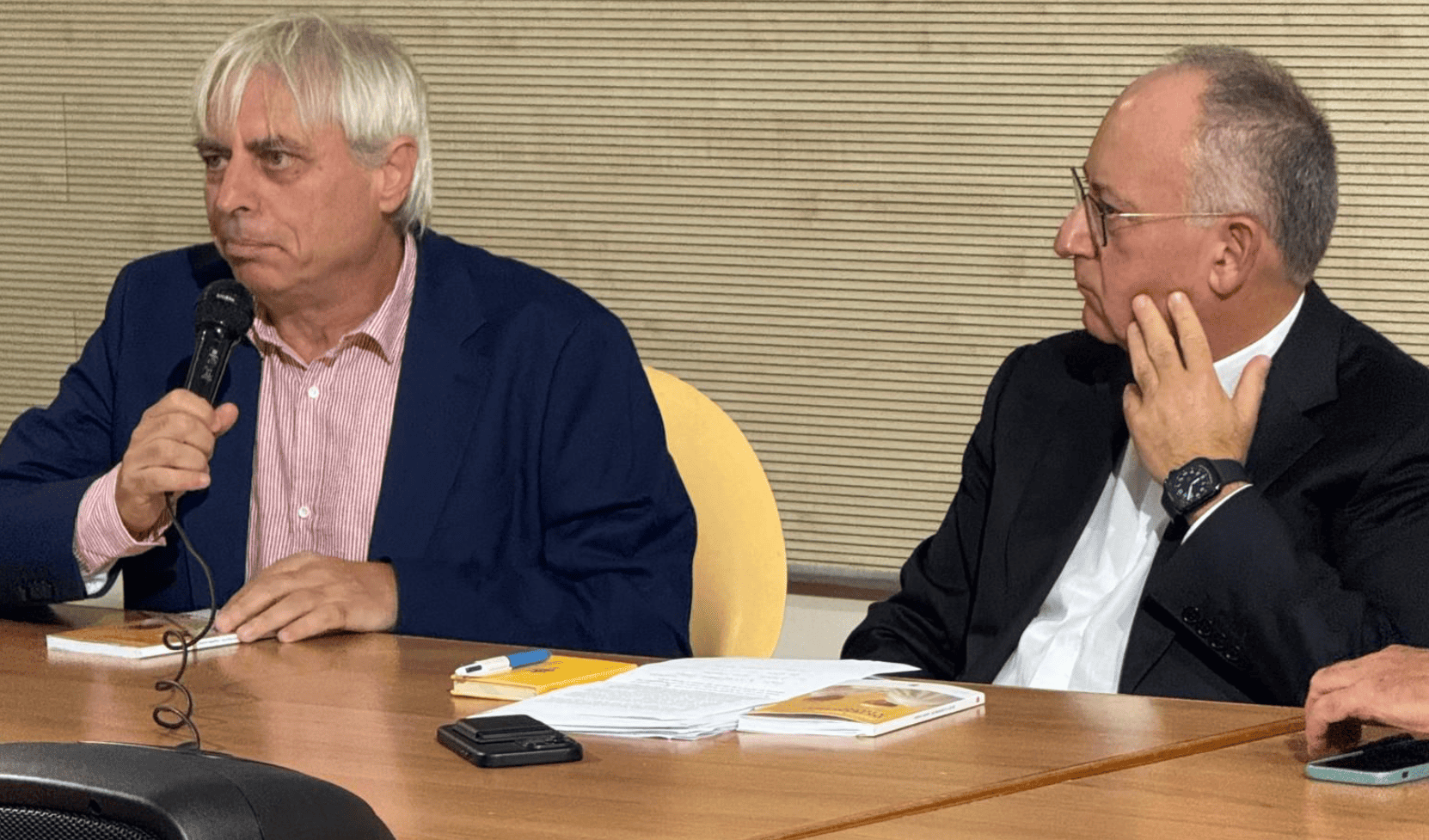
Preroll
Riccardo Cristiano Modifica articolo
24 Ottobre 2025 - 15.31
ATF
Native
Articoli correlati