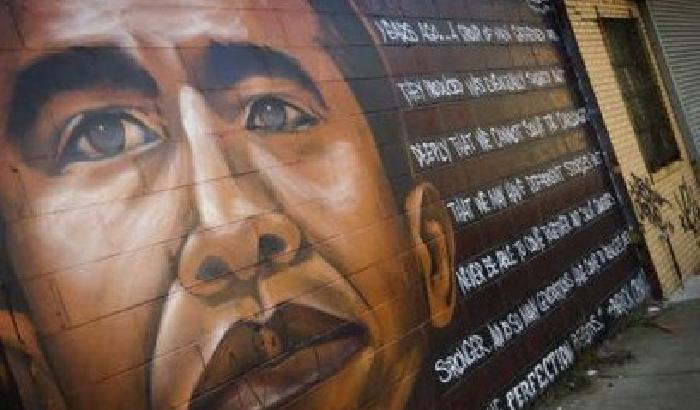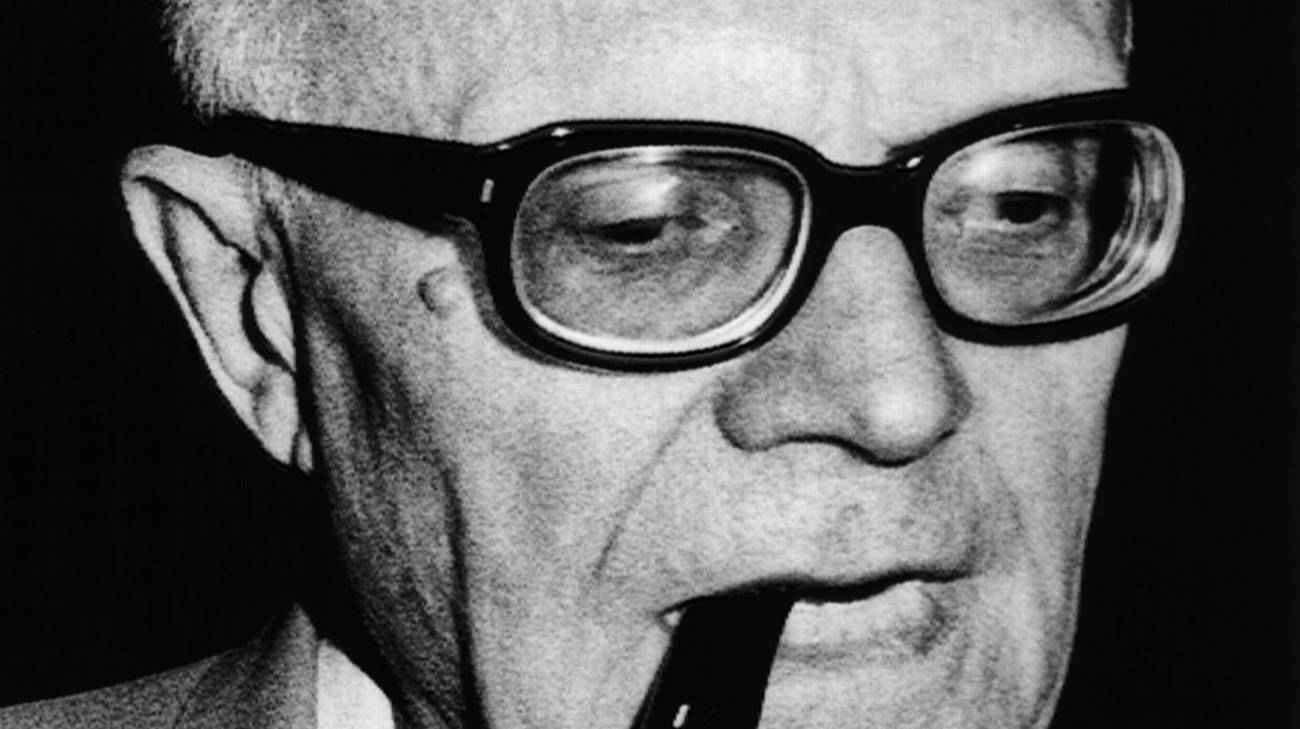Una nuova classe media di 300 milioni di persone può portare democrazia e buon governo a Sud del Sahara: il professor Mthuli Ncube, vice-presidente e capo economista della Banca africana di sviluppo (Bad), parla alla MISNA da Tunisi, culla della “primavera araba”.
Docente e preside di facoltà all’università sudafricana di Witwatersrand, poi “lecturer” alla London School of Economics, alcuni giorni fa questo esperto originario dello Zimbabwe ha presentato “The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa”, studio su una società e un continente che cambiano.
Professore, nella ricerca la crescita della classe media è definita “fenomenale”. Perché?
“La Banca africana di sviluppo ha messo insieme rilevazioni effettuate in 14 paesi e fondate sulle abitudini di consumo familiari. È una quantità di dati immensa. Viene fuori che la classe media cresce del 3,1% l’anno a fronte di un’espansione demografica del 2,6%. Oggi gli africani disposti ad avviare attività d’impresa, acquistare un’automobile, un frigorifero o beni di importazione sono 300 milioni. È un fenomeno finora ignorato, ma che esiste”.
Secondo lo studio, però, circa il 60% di questo segmento sociale rischia di continuo di scivolare in una condizione di povertà…
“I fattori di pericolo sono di due tipi, politico ed economico. Il primo è rappresentato da un crollo del sistema di governo, esemplificato di recente dalla crisi della Costa d’Avorio. La classe media è la prima a pagare il conto. Poi c’è il fattore economico, legato spesso alle congiunture internazionali: penso ad aumenti improvvisi dei prezzi dei generi alimentari di base o a forti rincari della benzina e dei costi di trasporto”.
Nelle ultime settimane tensioni sociali e proteste di piazza legate all’inflazione hanno attraversato diversi paesi, dall’Uganda al Botswana. Per l’Africa è un momento difficile?
“È un momento normale, nel senso che i cittadini reagiscono agli stimoli dei mercati. L’elemento caratteristico di questa stagione è semmai la rapidità con la quale si diffondono le informazioni. La disponibilità dei dati si ripercuote subito sui prezzi e un discorso simile vale in ambito politico. A Sud del Sahara i rivolgimenti in Tunisia ed Egitto sono stati seguiti con attenzione. Alcuni gruppi stanno imparando a organizzarsi in modo autonomo e a usare le nuove tecnologie. Il messaggio ai dirigenti politici è: ‘Attenzione, serve una crescita economica inclusiva’”.
C’è un legame tra classe media e democrazia?
“La classe media vive in città, è più informata, è connessa a internet. Per natura, è portata a chiedere democrazia. Nel 1990 in Africa contava 135 milioni di persone, nel 2000 quasi 200 milioni, adesso 300. Sì, l’Africa potrebbe diventare più democratica”.
Dove stanno andando la Tunisia e l’Egitto?
“La radice delle mobilitazioni popolari è stata la richiesta di lavoro e di giustizia, intesa anzitutto come crescita inclusiva. Nel medio periodo le rivoluzioni potrebbero favorire un’apertura del panorama politico, come suggerisce il gran numero di nuovi partiti registrati in Tunisia in vista delle elezioni di luglio. Ma sul piano dell’economia i tempi sono più lunghi. Oggi ho visitato l’Elgazala Technopark, un centro per lo sviluppo di tecnologie informatiche alla periferia di Tunisi nato nel 1997 e ancora in forte espansione. Per creare posti di lavoro bisogna rilanciare il turismo, ma quello va da sé, le spiagge nessuno le porta via. Più importante è la scommessa sull’economia della conoscenza, magari con l’obiettivo di diventare un nuovo polo per l’outsourcing delle produzioni ad alto contenuto tecnologico. La Tunisia potrebbe essere quello che l’India è stata per gli Stati Uniti e i paesi europei negli ultimi 20 anni”.
In molti paesi dell’Africa la chiave dello sviluppo è la gestione delle risorse naturali. Quale deve essere il ruolo dello Stato?
“Credo la strada migliore sia un’alleanza tra pubblico e privato. Un esempio positivo è Debswana, la società diamantifera frutto dell’accordo tra il gruppo sudafricano De Beers e il governo del Botswana. Il problema degli africani è però soprattutto la raccolta di informazioni attendibili sulle transazioni commerciali e la creazione di un sistema efficiente per la riscossione delle ‘royalties’ sullo sfruttamento del petrolio e delle altre risorse. Circa il 60% dei capitali illeciti esportati dal continente proviene dall’evasione fiscale o da fatturazioni gonfiate. Un altro aspetto importante è la capacità tecnica di stipulare contratti vantaggiosi per i governi e le popolazioni locali”.
Ci sono esempi da seguire?
“Anche in questo caso il Botswana offre un modello interessante. Come hanno fatto a Gaborone, la gestione dei proventi derivanti dal petrolio o da altre risorse strategiche potrebbe essere affidata a fondi sovrani. Queste strutture, sotto il rigoroso controllo dei governi, sono in grado di alimentare tre canali distinti: spese correnti che figurano nei bilanci annuali dello Stato, investimenti per progetti infrastrutturali mirati e fondi a lungo termine, messi da parte per le generazioni future”.