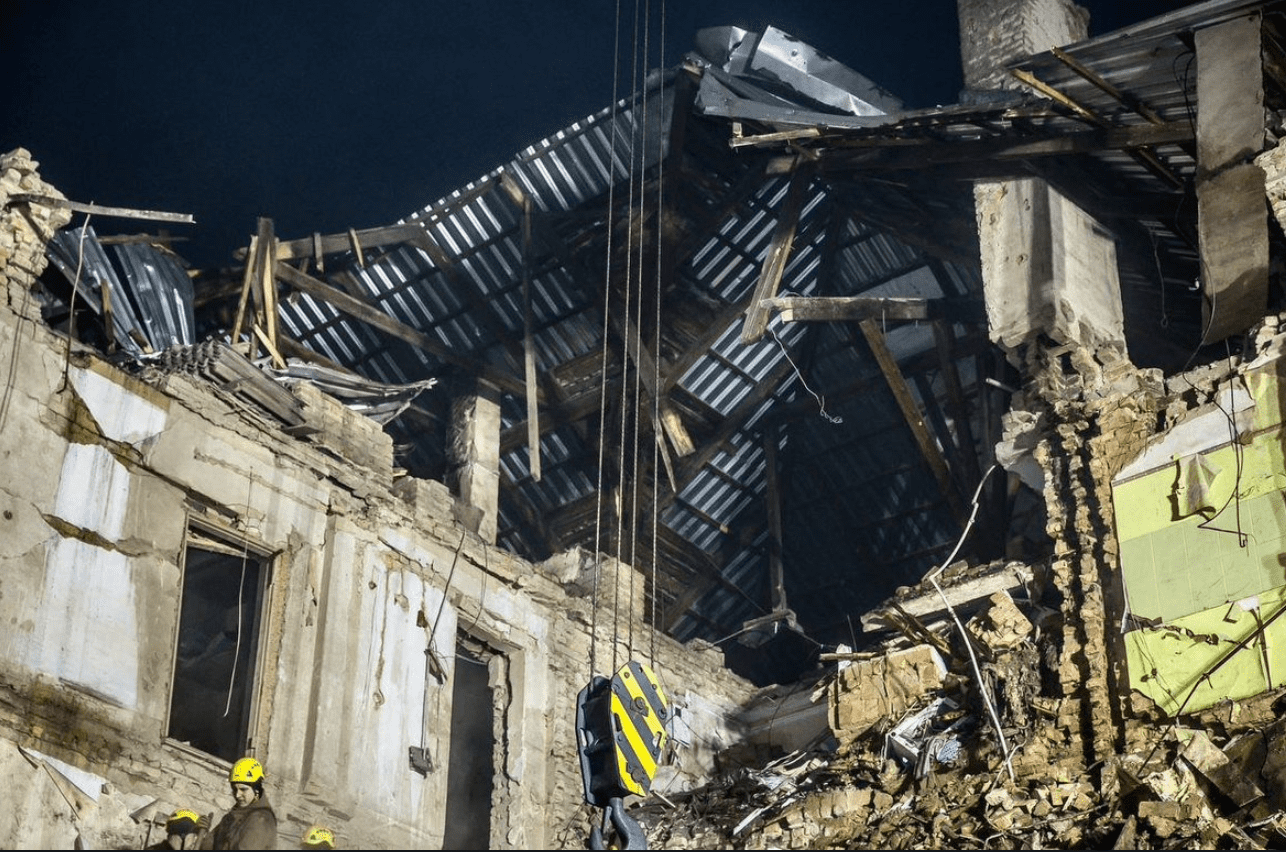di Alessia de Antoniis
6 e 9 agosto 1945. Ottant’anni fa, due ordigni nucleari rasero al suolo Hiroshima e Nagasaki. Ma questa è solo la parte della storia che conosciamo. Quello che spesso ignoriamo è che quelle due esplosioni furono l’inizio, non la fine, di un’era di sperimentazione nucleare che ha trasformato il pianeta in un laboratorio a cielo aperto.
Dal 1945 al 1996 (dopo il 1996 la Corea del Nord ha effettuato test nucleari), nove nazioni hanno condotto oltre 2.000 test nucleari. La potenza cumulativa equivale a 35.000 bombe di Hiroshima. Tonnellate di plutonio e uranio disperse in atmosfera, suolo e oceani. Un esperimento globale i cui risultati continuano a manifestarsi decenni dopo.
Esiste un atlante invisibile della contaminazione. Le Isole Marshall del Pacifico ospitarono 67 test americani tra il 1946 e il 1958. Oggi l’atollo di Bikini rimane inabitabile. Nel Kazakistan, l’Unione Sovietica condusse 456 test al poligono di Semipalatinsk: 1,5 milioni di persone furono esposte alle radiazioni. La Francia testò 210 ordigni nel Sahara algerino e in Polinesia. La Cina nel deserto del Gobi, la Gran Bretagna in Australia.
La geografia di questi test rivela un pattern preciso: territori remoti, spesso coloniali, dove il dissenso poteva essere facilmente silenziato. Popolazioni sacrificabili in nome della sicurezza nazionale.
Nel 1979, gli Stati Uniti costruirono il Runit Dome nelle Isole Marshall: una cupola di cemento (non rivestita e vulnerabile a innalzamento mare e uragani) per contenere 80.000 metri cubi di scorie radioattive. Oggi l’innalzamento del livello del mare la minaccia. L’Oceano Pacifico rischia di restituire quello che abbiamo cercato di nascondere.
C’è poi il paradosso della deterrenza. La teoria della deterrenza nucleare si basa su un presupposto fragile: che gli esseri umani siano sempre razionali e i sistemi sempre infallibili. La storia dimostra il contrario.
Nel 1983, il tenente colonnello sovietico Stanislav Petrov salvò probabilmente il mondo scegliendo di non credere ai computer. I radar segnalavano missili americani in arrivo, ma Petrov intuì che si trattava di un errore del sistema. Era il riflesso del sole su una nuvola.
Nel 1995, la Russia interpretò il lancio di un missile scientifico norvegese come un attacco americano. Boris Eltsin attivò la “valigetta nucleare” prima di capire l’errore. Nel 1966, un bombardiere B-52 si schiantò su Palomares, in Spagna, disperdendo plutonio su un’area di diversi chilometri quadrati.
Sono solo alcuni degli episodi che rivelano quanto sottile sia il filo che ci separa dalla catastrofe. Oggi esistono circa 12.241 testate nucleari nel mondo, di cui 3.912 dispiegate e circa 2.100 ad alta prontezza (dati Sipri). Nove paesi possiedono l’arma che può cancellare la civiltà in trenta minuti.
Ma il vero nemico non sono le armi nucleari in quanto tali, né gli Stati che le possiedono. Il vero nemico è il modo di pensare che giustifica le armi nucleari: l’esser pronti ad annientare gli altri qualora essi siano considerati una minaccia o un ostacolo.
Questa mentalità ha prodotto non solo arsenali sempre più sofisticati, ma anche una normalizzazione dell’inaccettabile. Abbiamo imparato a convivere con la possibilità dell’autodistruzione come se fosse un dato naturale.
Il disarmo nucleare non è quindi solo una questione tecnica o diplomatica. È prima di tutto un cambiamento culturale: smettere di considerare normale l’esistenza di armi progettate per annientare intere città.
Ecco perché è importante l’eredità degli Hibakusha. I sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, gli Hibakusha, hanno dedicato la vita a raccontare l’inaccettabilità dell’arma nucleare. Ma accanto alla loro testimonianza diretta, esiste un’altra testimonianza silenziosa: quella delle popolazioni esposte ai test nucleari.
I bambini nati deformi nei villaggi del Pacifico. I pescatori giapponesi del “Daigo Fukuryu Maru” contaminati dal test Castle Bravo nel 1954. Le comunità del Nevada che registrano tassi di leucemia superiori alla media. I nomadi del Sahara mai informati dei rischi. Sono gli Hibakusha invisibili di una guerra che non è mai finita davvero.
Ogni agosto ricordiamo Hiroshima e Nagasaki. Ma raramente parliamo di Moruroa, di Semipalatinsk, del Runit Dome. È una memoria selettiva che ci permette di commemorare le vittime del passato ignorando quelle del presente.
La lezione di Hiroshima non può limitarsi al ricordo. Deve diventare la base per un futuro diverso: quello in cui l’umanità sceglie di non tenere più il dito sul grilletto della propria estinzione.
Ottant’anni dopo, è tempo di completare il racconto. E di trarne le conseguenze.