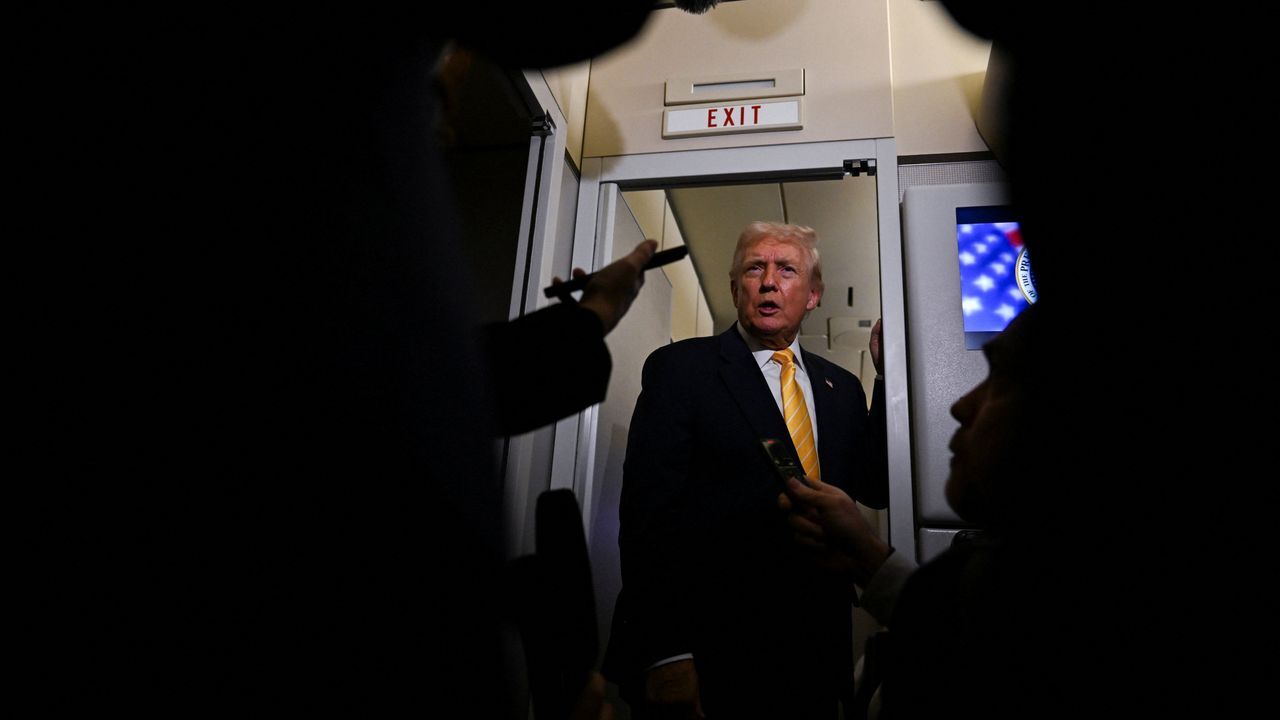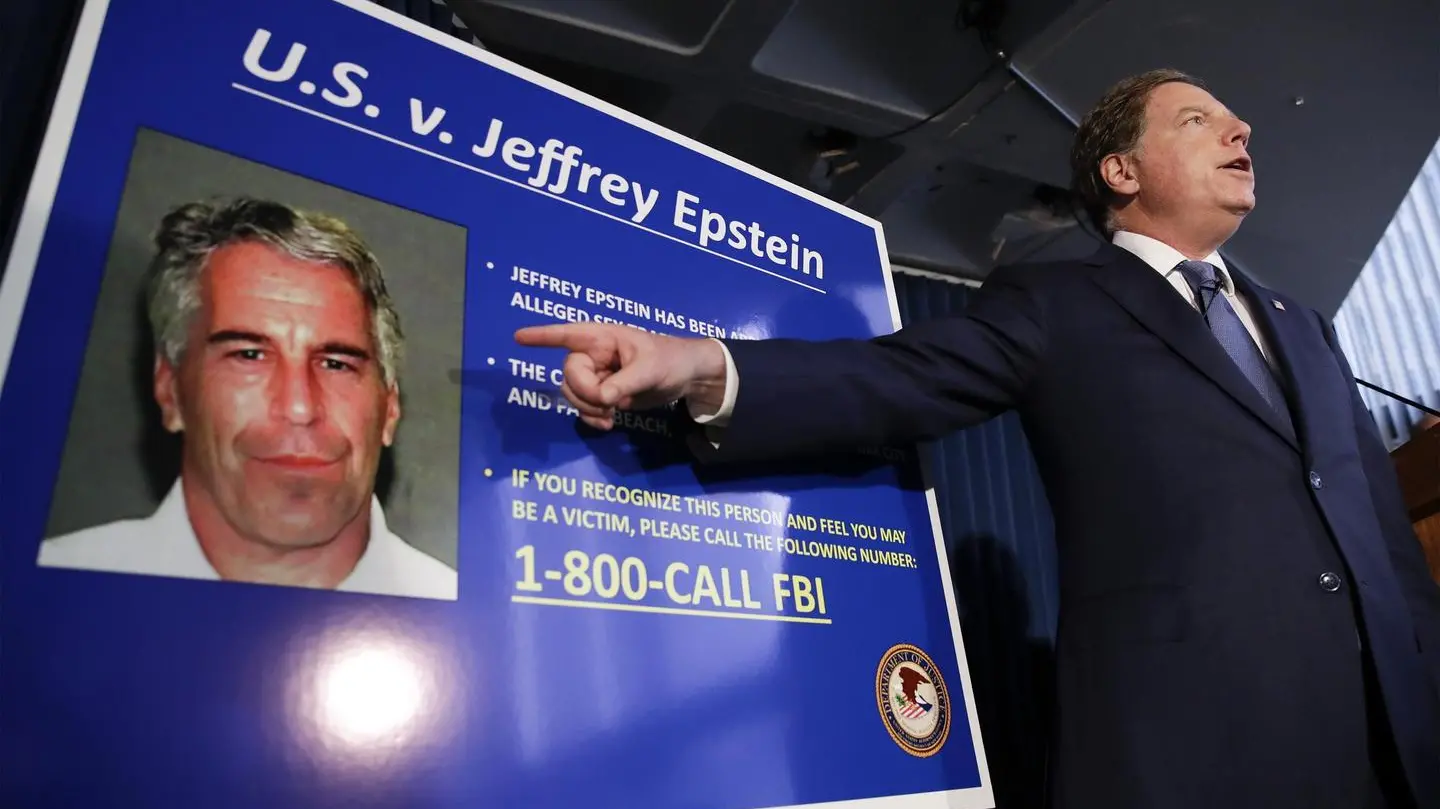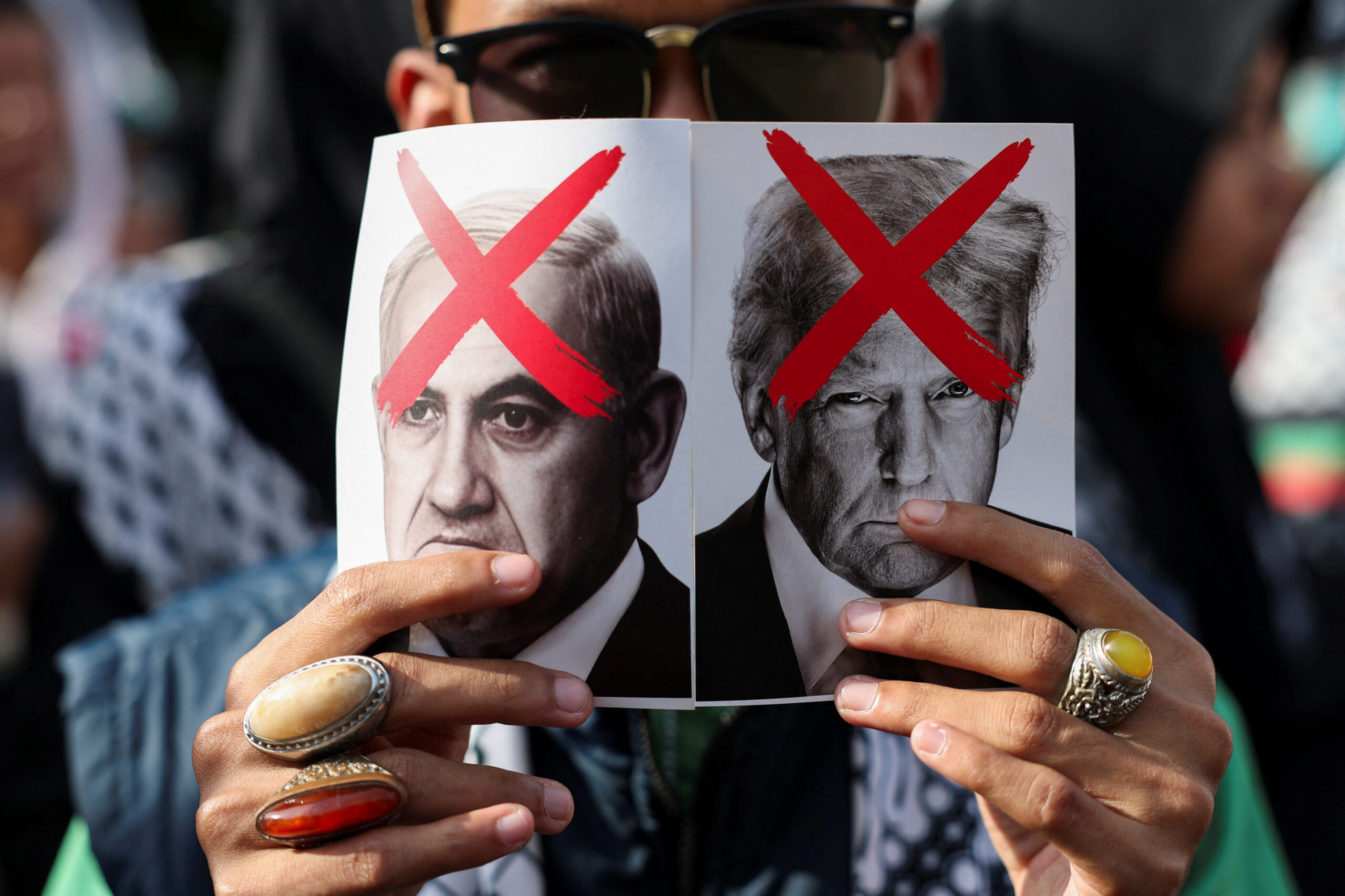di Rock Reynolds
Ci mancava pure che si intestasse la pace in Medio Oriente, dopo aver consentito a Israele di portare avanti un massacro indiscriminato e non aver mai cessato di armarlo, in perfetta continuità con la gestione del suo vituperato predecessore. E fortuna che, con una mossa salomonica, il comitato per il Nobel ha assegnato il prestigioso per la pace alla venezuelana María Corina Machado, figura tutto sommato controversa e incline a una certa animosità verbale, seppur nel solco di una contrapposizione politica violenta. Se il comitato del Nobel avesse soddisfatto le invocazioni infantili di Donald Trump, la prossima richiesta il presidente americano l’avrebbe fatta direttamente alla Santa Sede: della serie, trovatemi un posto nell’olimpo dei vostri santi. Ce ne sono parecchi, in fondo, e non tutti così meritori.
Ma fare dello spirito quando c’è di mezzo Trump è uno dei peggiori errori che si possano commettere e, dunque, chiedo immediatamente venia. Il discorso è serissimo e va affrontato con strumenti adeguati: conoscenza, studio e cifre.
Il saggio di recentissima pubblicazione Buio Americano (il Mulino, pagg 153, euro 16) fa esattamente al caso nostro. L’autore, Mario Del Pero, ordinario di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti all’Institut d’études politiques – SciencesPo di Parigi, ci aiuta a raccapezzarci in una materia sempre più al centro della discussione pubblica e sempre meno raccontata nel modo giusto. Basta dare una scorsa all’elenco degli elementi che, secondo Del Pero, hanno «definito la parabola degli Stati Uniti nell’ultimo mezzo secolo». Un elenco sconfortante: «Disaffezione politica e sfiducia nelle istituzioni; polarizzazione elettorale; riemergere della questione razziale; acute disuguaglianze; deindustrializzazione; crescita economica significativa, ma disomogenea in termini regionali o sociali; segmenti della società… che meno ne beneficiano e che talora sono espulsi dal mercato del lavoro».
La puntualità degli interventi di Mario Del Pero in vari programmi di informazione nazionale sono all’insegna del garbo e, soprattutto, della competenza. Le risposte alle nostre domande pure.
La democrazia più antica del pianeta, quella americana, pare a un crocicchio. Dispone ancora degli anticorpi per reggere l’urto a cui Trump la sta sottoponendo?
«Questa è ovviamente la grande questione. È democrazia antica, quella statunitense, ma anche democrazia molto vecchia, con una Costituzione anacronistica, scheletrica, piena di ambiguità riempite da consuetudine, dottrina e, soprattutto, decisioni delle Corti. Quali possono essere questi anticorpi oggi? L’equilibrio di poteri, il federalismo e il ruolo della società civile, per sintetizzare all’osso. Rispetto a un processo di slittamento autoritario contraddistinto da un crescente accentramento dei poteri nelle mani dell’Esecutivo, quello Legislativo è totalmente marginalizzato (credo che questo sia finora il Congresso dalla più bassa produttività legislativa della storia moderna degli Usa); il potere giudiziario è quello che finora si è più frapposto al ciclone Trump, con molte corti distrettuali che si sono opposte agli ordini esecutivi del Presidente, denunciandone l’illegalità e la incostituzionalità, ma – sia pure in forma spesso ambigua che procrastina a decisioni successive – la Corte Suprema è sovente intervenuta a favore del Presidente; società civile (che si mobilita) e media sembrano essere più deboli. Resta il federalismo, che è l’arena dove si sta spostando lo scontro tra potere federale e potere statale.»
Lei apre il suo libro dicendo che le parole del presidente degli USA hanno una valenza senza pari e possono definire il perimetro del dicibile. Com’è possibile che la narrazione di Trump si imponga anche laddove le cose dette sono platealmente impraticabili?
«Credo siano proprio saltati dei filtri e dei paletti. Le cose radicali, estreme – e non di rado violente o volgari – che Trump spesso dice stanno dentro un imbarbarimento del discorso pubblico e politico. Del quale Trump è il prodotto, non la causa; ma di cui, una volta alla Casa Bianca, è divenuto inevitabilmente l’agente primario. Le matrici di questo imbarbarimento sono tante, ovviamente. Incidono le nuove forme della comunicazione; pesa una polarizzazione che trasforma l’avversario politico in nemico assoluto ed esistenziale (che in quanto tale può e deve essere offeso e caricaturato); ha un effetto lo spostamento dello scontro politico su un terreno – primariamente culturale e identitario – dove il dialogo, il compromesso e la mediazione – il sale della politica e la precondizione della governabilità– diventano molto più difficili. Poi, non vi è al mondo figura politica più influente e potente del presidente degli Stati Uniti. Le cui parole definiscono appunto il perimetro del dicibile e dell’immaginabile. Che alterano narrazioni, percezioni e in una certa misura realtà. E oggi ci troviamo a discutere, seriamente, della possibile annessione statunitense della Groenlandia o del cambiamento della costituzione per decreto presidenziale.»
Come mai lo slogan MAGA ha fatto presa? Rendere nuovamente grande l’America significa ammettere che il paese così grande non è più…
«Sì, è una rappresentazione apocalittica e distopica dell’America quella che ne fa Trump (l’ “American Carnage” del suo primo discorso d’insediamento). Che fa presa su milioni di americani in oggettiva sofferenza; che cavalca e alimenta paure reali e rabbie conseguenti. E che trova nel ritorno al passato – un passato di grandezza unica e incontestabile – la sua risposta. La retorica trumpiana si nutre di nostalgie vivide e potenti per una parte di America. Il messaggio è semplice: abbiamo cessato di essere grandi per via del tradimento di élite corrotte e globaliste; ma basta poco per tornare grandi. Un messaggio che fa leva su due elementi fondamentali della tradizione e della cultura politica del paese: a) un’idea di nazione (e d’identità nazionale) molto essenzialista e razziale, centrata sull’idea che vi sia un’essenza profonda e immutabile – cristiana o giudeo-cristiana, bianca, occidentalista – che definisce gli Usa e deve essere ripristinata contro una visione civica, progressista, costituzionale ed evolutiva di cosa gli USA siano e debbano essere (di qui anche la popolarità di letture testuali e originaliste del testo costituzionale); b) che l’eccezione statunitense – il presupposto di un potente nazionalismo eccezionalista – poggi primariamente sull’esenzione degli Usa da quelle costrizioni storiche cui gli altri attori sono invece soggetti. Che recuperare sovranità – securitaria, economica, industriale, ecc – vuol dire recuperare eccezionalità.»
Lei parla di una forte nostalgia degli americani per una sorta di età aurea del paese che oggi pare una chimera. Ci vuole spiegare meglio cosa intende?
«Questi passati edenici sono artefatti e depurati di tutte le loro inevitabili contraddizioni. Quello più forte e centrale nel discorso trumpiano sono gli anni Cinquanta e Sessanta, prima delle grandi trasformazioni sociali e culturali post-68 (per semplificare). America bianca, prospera, consensuale, del boom dei consumi privati, del benessere e della sicurezza dei sobborghi, dell’industria più competitiva del mondo. Anche un’America della segregazione, di un modello familiare centrato sull’unico breadwinner maschile, del conformismo, di sacche di povertà estrema. Che nella narrazione trumpiana scompaiono ovvero vengono normalizzate, controcanti inevitabili della struttura della società.»
Lei definisce che l’accesso facile al credito una sorta di “ammortizzatore sociale indiretto”. Come fa il paese a reggerlo tuttora?
«In una certa misura l’stata, una droga. Con cui milioni di famiglie americane hanno consumato ben al di là delle loro possibilità; e grazie al quale ricchezze immense generate da diseguaglianze crescenti hanno trovato una lucrativa forma d’investimento, grazie al ritorno appunto sul credito al consumo (pensiamo solo al caso dei mutui subprime, così centrali nella crisi del 2008). In realtà, anche se i consumi individuali e familiari sono tornati a crescere in termini assoluti e come percentuali del PIL, l’apparato regolamentatorio introdotto dopo quella crisi – pensiamo solo alla legge Dodd-Frank – per quanto indebolito continua a operare. Gli interessi passivi sui mutui come percentuale del PIL rimangono di molto inferiori a quelli del pre-2008 e più alta è la percentuale del risparmio sul reddito disponibile. Ma quella dei consumi facili a debito è una nostalgia potente perché vivida è la memoria di quell’era e di quel benessere: artificioso, insostenibile, ma comunque reale per tanti americani. Ed è una nostalgia che Trump utilizza e alimenta.»
La caccia alle streghe comuniste è lontanissima. Eppure la parola socialismo è ancora un tabù nella discussione pubblica. Cos’ha ancor oggi di tanto spaventoso per l’americano medio la prospettiva di mettere in campo qualche politica sociale?
«In realtà il socialismo, nelle sue tante declinazioni, ha anche una storia americana, ed è una storia significativa e importante. Negli ultimi anni, a causa della crescita delle diseguaglianze e, di nuovo, della crisi del 2008, proposte politiche radicali in materia di tassazione, redistribuzione della ricchezza, tutele sociali si sono fatte nuovamente popolari, riflettendo una radicalizzazione che è il naturale portato della polarizzazione. Una popolarità che, talora, riflette anche l’apprezzamento per gli esiti di tali politiche, dalla crescita del salario minimo in tanti stati (e, da quasi due decenni, anche in diverse città) alla sanità pubblica, con un programma come Medicaid – amministrato a livello statale e destinato a individui e famiglie con redditi più bassi – molto popolare, anche tra una fetta dell’elettorato repubblicano.»
La debolezza dell’attuale opposizione è palese. Qual è la responsabilità maggiore del Partito Democratico?
«Ne indico in grande sintesi tre. L’immigrazione, con una disattenzione alla messa in sicurezza del confine meridionale che ha rappresentato uno dei principali asset elettorali per Trump e i repubblicani. Le guerre culturali, con posizioni – penso a un esempio che ho utilizzato anche nel libro, la questione dell’ammissione alle competizioni sportive femminili di atleti transgender (in sé una non-issue, visto che parliamo di pochissimi casi) – osteggiate da una larga maggioranza di americani o comunque incomprensibili a molti. La questione dell’assenza di leadership e di un vero ricambio generazionale, con il caso di Biden, ovviamente, ma anche con quelli della leadership congressuale (nel biennio di governo unitario, 2021-23, tutti i tre leader, il Presidente, il leader di maggioranza al Senato, Chuck Schumer, e la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, avevano più di 70 anni).»
Donald Trump è la causa o la conseguenza?
«Entrambe le cose. È la conseguenza della polarizzazione, della demonizzazione e deumanizzazione dell’avversario politico, della radicalizzazione che ne consegue, e dell’imbarbarimento e degrado del discorso pubblico e politico. Ma, una volta eletto, di tutto ciò è diventato agente primario. Il primo Presidente, in un certo senso, che non finge nemmeno di voler offrire un messaggio inclusivo e unitario e che alimenta e acuisce deliberatamente fratture e divisioni. È, per semplificare, l’effetto e la causa della polarizzazione e di quanto male essa fa alla democrazia americana.»
Perché USA rigettano tuttora la giurisdizione della Corte penale internazionale? Nel suo libro, lei scrive che quella del ricorso a doppi standard è un’abitudine talmente inveterata da essere entrata nel DNA degli americani. Perché manca quasi del tutto nel paese un livello minimo e salutare di autocritica?
«Credo si leghi a due dimensioni che si alimentano mutevolmente. L’eccezionalismo statunitense: un nazionalismo fondato sull’idea che la presunta eccezionalità degli Usa derivi anche dal loro poter essere un’eccezione, alle leggi della storia e alle costrizioni che ne conseguono. E l’impareggiabile potenza maturata nel tempo dagli Stati Uniti. Che conferma in teoria questo eccezionalismo, validandolo, e che permette materialmente di sottrarsi alle conseguenze delle violazioni del diritto internazionale.»
Mi pare di aver capito che, da Reagan in poi, istruzione e sanità siano due temi su cui non serve quasi discutere. Si spendono cifre mostruose per alimentare l’apparato militare e l’ordine pubblico, mentre l’istruzione pubblica è a livelli da quarto mondo e la sanità pubblica è in crisi. In che modo la politica (non solo Trump, per la verità) riesce a convincere i cittadini che è inutile cambiare, che le cose vanno bene come stanno?
«In realtà si spende tanto, sia in istruzione che in sanità. Nella seconda, la spesa complessiva come percentuale del PIL è tra le più alte al mondo. E quella per la sanità pubblica è di molto cresciuta, anche in conseguenza della riforma di Obama. Così come si spende in istruzione, che è capitolo di spesa tra i più elevati a livello statale. Si spende spesso male, soprattutto nell’istruzione di base. E sui finanziamenti federali alla ricerca qualche piccola ragione Trump la ha, se guardiamo ad esempio ai tanti sperperi e a come le università non di rado facciano la “cresta” su questi finanziamenti, con una percentuale elevatissima di overhead. Il dato che deve colpire probabilmente è come istruzione e sanità alimentino ulteriore diseguaglianza invece di alleviarla, in virtù delle monumentali differenze qualitative e quantitative nel modo in cui esse sono erogate, a seconda di dove uno sia nato e risieda.»
Mai un presidente aveva fatto un uso tanto spregiudicato dei decreti d’urgenza. E mai un presidente aveva fatto ricorso in modo così spregiudicato a poteri speciali di dubbia costituzionalità. La propaganda che mette la paura del diverso davanti ai cittadini americani – soprattutto se bianchi e non particolarmente abbienti – è così tossica da far passare ogni limitazione della libertà individuale come accettabile?
«C’è una sfiducia generalizzata nella politica, nei suoi rappresentanti e nelle istituzioni (il tasso di americani che esprime fiducia nel Congresso sta stabilmente sotto il 10%, tanto per fare un esempio). C’è rabbia e paura, che spesso si sfoga contro un diverso debole e colpibile, come appunto gli immigrati. C’è quella che alcuni studiosi definiscono un’”ansia da status” (status anxiety) di un pezzo d’America bianca oggettivamente in sofferenza, che vede il suo peso demografico relativo calare, che vede contestato il proprio ruolo e i propri simboli, che è vittima sia di meccanismi di discriminazione positiva che aiutano solo altri gruppi sia di una fiscalità, in parte progressiva (a favore di redditi più bassi, nei quali sovrarappresentate sono le minoranze ispanica e afroamericana) e in parte regressiva (a vantaggio di redditi da capitale o di profitti d’impresa). È una miscela altamente infiammabile che, come ci indicano tanti sondaggi, rende meno ostili a soluzioni radicali e finanche autoritarie.»
In un sistema democratico che si rispetti, servono pesi e contrappesi. Mi pare ne stia mancando uno che, storicamente, negli USA ha sempre fatto la sua parte: l’informazione. Che scenario vede e prevede?
«L’informazione classica – con i suoi pregi (alta qualità del giornalismo, attenzione ai fatti, consapevolezza di costituire un fondamentale contropotere) e difetti (elitismo, porte girevoli con la politica, rapporti non sempre trasparenti con potere economici) – è evidentemente in crisi. Il suo verticismo è stato sostituito da un modello orizzontale, sulla carta più democratico, ma che produce in realtà bolle in cui ognuno si abbevera alla fonte che conferma le sue certezze e dove l’assenza di filtri e controlli permette di far circolare notizie non verificate, alimentando teorie cospirative e verità alternative. Non vedo uno scenario che può indurre all’ottimismo, ahimè. E di nuovo Trump è l’effetto e la dimostrazione di tutto ciò, ma anche oggi un suo agente come vediamo nel tentativo di mettere sotto controllo i media, intimidendoli, o nella decisione di dare accesso senza precedenti a improbabili figure di blogger e podcaster della MAGA-sfera.»
Argomenti: donald trump