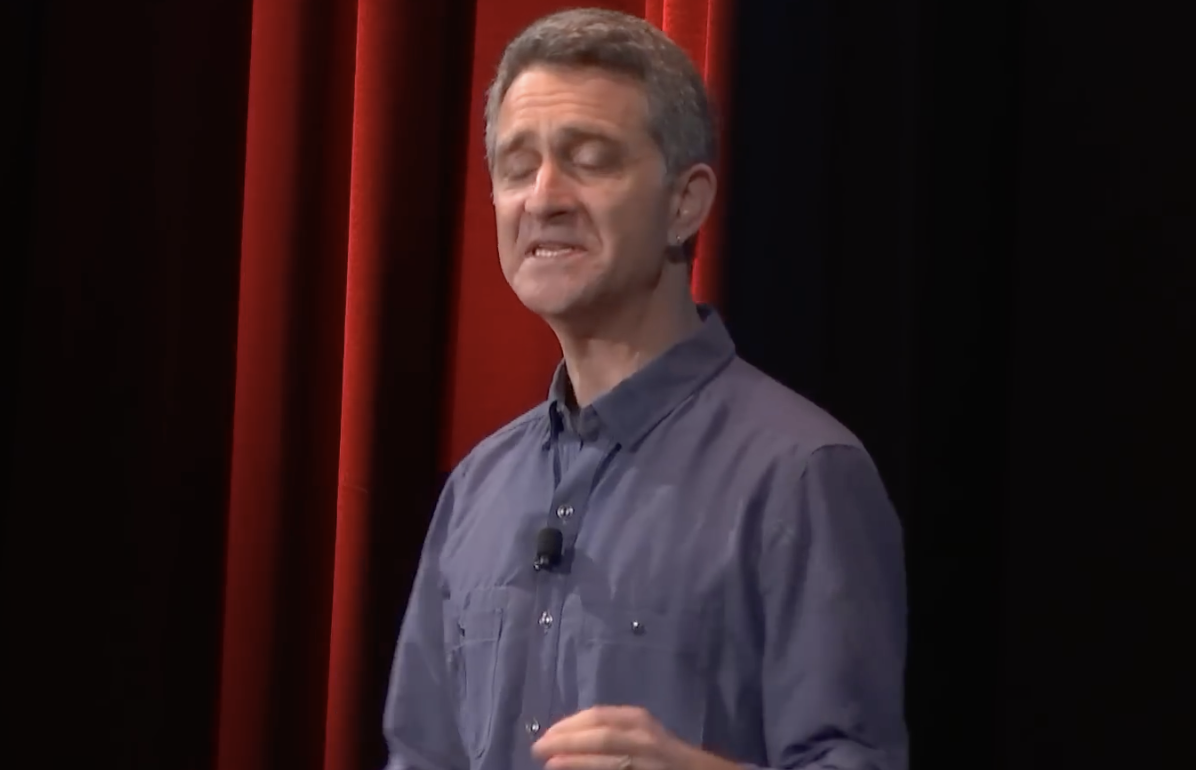di Rock Reynolds
La coperta è cortissima e, comunque vada, siamo rovinati.
Questo, in soldoni, è il messaggio de I metalli del potere (Aboca, traduzione di Maurizio Riccucci, pagg 319, euro 26) di Vince Beiser, un interessantissimo e attualissimo saggio scritto con cognizione di causa e capacità narrativa alla portata di profani e neofiti dell’argomento come il sottoscritto. La grande sfida dell’oggi e del domani, insomma, si apre con poche certezze e tanti dubbi. Comunque la si guardi, la situazione è drammatica: il tasso di crescita della società umana e di sfruttamento delle risorse del pianeta non può salire all’infinito.
L’avvento dell’era digitale e il passaggio alle energie “pulite” e alla decarbonizzazione non possono essere indolori. Serve comunque qualcosa che alimenti le dinamo che immagazzinano l’energia eolica e che consenta di caricare le batterie a energia solare. Sono fonti rinnovabili, a emissioni zero, in quello che è una sorta di “patto faustiano”. «Per imbrigliare l’energia del sole e del vento, nonché per trasmetterla e utilizzarla, abbiamo bisogno di macchine.» E, naturalmente, per costruirle e farle funzionare servono batterie che, a loro volta, necessitano di quantità crescenti di metalli diventati strategici, essenziali. Insomma, Vince Beiser non definisce quella per il loro controllo una vera e propria guerra, ma indica la crescente contrapposizione tra le due superpotenze USA e Cina, con una posizione di vantaggio sempre più evidente di quest’ultima: non che i miliardari americani del settore siano mai stati dei filantropi ambientalisti, ma i freni di una legislazione meno rigorosa e l’attenzione finora inferiore per i contraccolpi sull’ambiente dell’attività estrattiva hanno sbilanciato tale scontro.
La nuova era sotto la lente di ingrandimento di Beiser «si basa su tre fattori interconnessi: la tecnologia digitale e Internet; le energie rinnovabili; i veicoli elettrici». Ecco perché la battaglia industriale odierna si combatte sul terreno di come soddisfare la domanda dei milioni di tonnellate di metalli necessari al nuovo tipo di sviluppo. Per dare un’idea della portata del fenomeno, Beiser ricorda che soltanto nel 2012 si vendevano 120.000 veicoli elettrici al mondo in un anno e che nel 2022 lo stesso numero era quello delle vendite settimanali, con una proiezione di 30 milioni di unità vendute all’anno entro il 2030. Ecco come certe nazioni fino a poco tempo fa marginali – per esempio, il Cile o la Repubblica Democratica del Congo – hanno trovato un posto di rilievo sulla carta geografica commerciale del mondo, un po’ come l’Arabia Saudita si arricchì enormemente con il boom del petrolio. Non a caso, proprio l’Arabia sta facendo grandissimi investimenti nell’industria dei metalli critici.
Ma quali sono questi metalli sempre più determinanti nella nostra società orientata all’eliminazione progressiva degli idrocarburi? Nichel, cobalto e litio, prima di tutto.
L’attenzione al benessere dell’ambiente è sempre più un fattore. Ci sono, ovviamente, grandi gruppi di interesse a cui dell’ecosostenibilità sul piano etico non frega un accidente, ma che sanno di non poter più fingere che non sia una questione rilevante, di fronte al crescente numero di persone nel mondo, soprattutto occidentale, che sfoggiano la bandiera ecologista. Lo storico Jared Diamond scrive che «“Eliminare l’inquinamento è molto più costoso che prevenirlo: prevenire è meglio che curare, e costa meno”».
Il tema è delicatissimo perché, come si diceva all’inizio, la coperta è più che corta. Alimentare grandi motori o ricaricare grandi batterie con energie pulite richiede comunque lo sfruttamento di determinate risorse, il che non è mai a costo zero e ha inevitabilmente contraccolpi più o meno pesanti sull’ambiente e su chi lo abita. Il riciclo, che secondo alcuni è la risposta, risulta dannatamente complicato quando ne sono oggetto i metalli. La loro estrazione è sempre rischiosa e, se rappresenta in determinati luoghi della terra l’unica risorsa che consenta alla popolazione locale di sopravvivere, è pure fonte di indicibili disastri, solitamente connessi alla scarsa qualità dell’acqua (laddove non venga esaurita del tutto nel processo estrattivo) e all’irrespirabilità dell’aria.
Si sente spesso parlare di “terre rare”: «non sono né terre né rare. La maggior parte di esse è abbastanza comune, ma non si trovano quasi mai in forma pura… Per questa ragione, estrarle è difficile e costoso». Eppure sono essenziali per far funzionare buona parte dei dispositivi che popolano la vita della persona media nell’era digitale.
Una modalità classica dello sfruttamento minerario da parte degli Stati Uniti negli ultimi decenni è stata quella di delocalizzare la produzione in altri paesi, di fatto scaricando l’inquinamento su altri, ma al tempo stesso finendo per perdere il controllo su molti processi produttivi divenuti strategici. Una modalità che, fino a qualche tempo fa, non apparteneva invece all’altro colosso, la Cina. Ma anche in Cina qualche cosa si sta muovendo sul piano della coscienza ambientale e pure l’Impero del Drago ha scelto di investire in altri paesi in cui l’estrazione può svolgersi lontano da troppi occhi indiscreti. Già nel 1992, Deng Xiaoping disse che «Il Medio Oriente ha il petrolio. La Cina ha le “terre rare”».
Una delle prime figure illustri a esprimere dubbi sulla durezza delle condizioni dei minatori fu Ernesto “Che” Guevara, visitando nel 1952 il sito di estrazione del rame di Chuquicamata, nel Cile. Nel 1970, Salvador Allende nazionalizzò tali miniere e sappiamo tutti come andò a finire.
La ragione per cui la Cina ha scelto la strada delle auto elettriche, di cui è diventata assoluto leader mondiale, è chiara: riduzione dell’inquinamento atmosferico, che in quel paese spesso supera i livelli di guardia, minore dipendenza dai combustibili fossili di provenienza straniera, conquista di un ruolo primario in un settore fondamentale in cui il colosso cinese sarebbe stato incapace di recuperare lo svantaggio maturato.
Gli Stati Uniti, da parte loro, sono alle prese con un dilemma: estrarre metalli rari in casa ad alti costi ecologici o farlo all’estero. Per esempio, produrre cobalto all’interno del paese, nell’Idaho, oppure continuare a importare il cobalto congolese. Nel secondo caso, l’Idaho risparmierebbe un duro colpo al proprio paesaggio, ma gli USA sarebbero ancor più pesantemente dipendenti dal cobalto estratto nella Repubblica Democratica del Congo. Come scrive Beiser, quando ci sono di mezzo le «miniere, la scelta non è mai tra il male e il bene, ma solo tra un male maggiore e un male minore». Alla fine, il Congo è un bacino di risorse minerarie con pochi eguali al mondo e le sue riserve di cobalto sono pari praticamente a quelle del resto del mondo. Purtroppo, sappiamo che tipo di impatto abbia avuto sulla zona il colonialismo, con le nefandezze commesse dal criminale re Leopoldo del Belgio.
Ricco di descrizioni di ambienti minerari in tutti gli angoli del mondo e dei relativi impatti delle estrazioni sui territori e sulle loro popolazioni, I metalli del potere risulta essere una lettura gradevole, mai stucchevole malgrado l’abbondanza di dati scientifici.
La velocità con cui il progresso tecnologico avanza ci fa intendere che, come afferma Ryan Castilloux, fondatore dell’Adamas Intelligence – una società specializzata nella fornitura di informazioni di prim’ordine sui metalli critici – «La miglior tecnologia di oggi potrebbe rivelarsi la peggiore di domani».