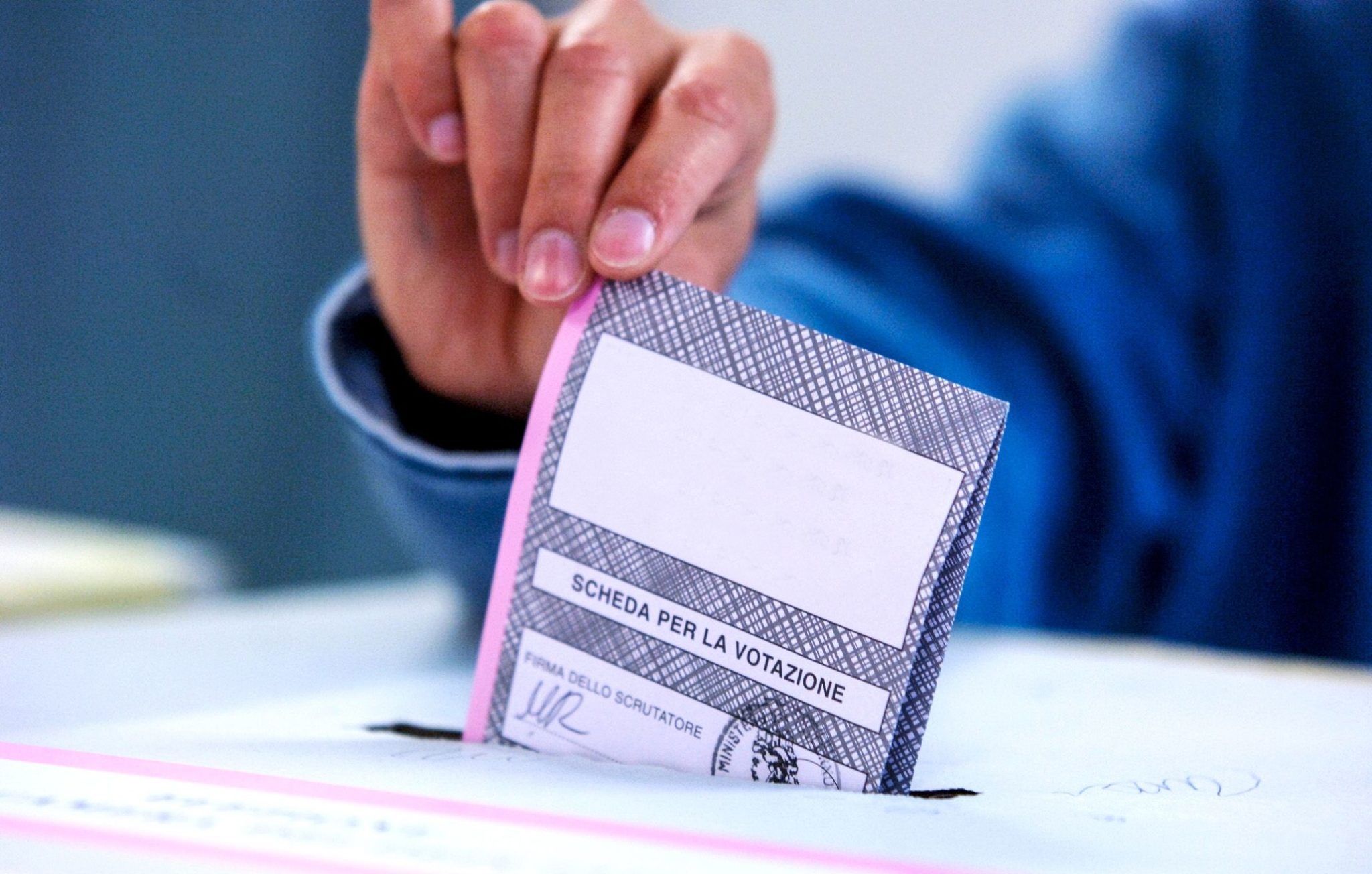di Dario Spagnuolo
Il grande sconfitto dell’attuale tornata di elezioni è il sistema elettorale. I governi sono divenuti più stabili, ma gli elettori non si sentono rappresentati e il distacco tra eletti e votanti è divenuto una voragine. Per la prima volta, in maniera generalizzata la gran parte degli elettori si è rifiutata di recarsi alle urne: è un dato che segna un cambiamento epocale nella società italiana.
I segnali di disaffezione sono da sempre più marcati nel Mezzogiorno, per questo fanno scalpore i risultati del Centro-Nord. Scende al di sotto del 50% la Toscana, passando dal 62,6% al 47,73% : circa 15% punti percentuali in meno, quanti basterebbero a formare un partito di maggioranza! Va persino peggio in Veneto, che passa dal 61,16% di votanti (regionali 2020) ad appena il 44,65% (-16,51%). Solo nelle Marche si giunge con grande fatica sopra il 50% (50,01% ha votato), con una perdita rispetto alle precedenti regionali del 9,72%.
Al Sud, la Puglia crolla dal 56,43% al 41,83% (-14,6) e la Campania dal 55,52% al 44,10%, perdendo un ulteriore 11,4% di votanti. Delle cinque andate al voto, la Calabria è l’unica regione che era già al di sotto del 50% di votanti, ma c’è stata comunque una ulteriore diminuzione anche se solo dell’1%.
E’ da ricordare anche la Val d’Aosta i cui numeri sono poco indicativi e dove, comunque, il partito più votato resta l’Union Valdotaine, seguito dagli autonomisti.
Non può stupire il cattivo risultato dei partiti della coalizione di governo, la cui durata è solo risultato dell’attuale sistema elettorale. Per il resto, non una delle promesse elettorali è stata mantenuta e la fine della sbornia dei fondi PNRR metterà termine anche alla minima crescita economica finora registrata. L’Italia è fanalino di coda dell’Unione europea e la situazione appare sempre più preoccupante per la distanza tra i temi oggetto di dibattito politico e la situazione reale del paese. Eurostat ha appena comunicato che tra il 2004 e il 2024 il reddito reale delle famiglie europee è aumentato, mediamente, del 22%. Solo in Grecia (-5%) e in Italia (-4%) è diminuito, ma non c’è traccia di preoccupazione per le condizioni di vita dei cittadini.
Ai numeri non esaltanti della coalizione di centrodestra non corrisponde una vittoria del centrosinistra che continua a dibattersi tra coalizioni larghe ed eterogenee, frutto di accordi di potere, e il tentativo di dotarsi di una linea di condotta alla quale attenersi e a cui aderire per convinzione e non per convenienza.
Se ci si sofferma solo sulla Campania, risultano evidenti alcune cose. Le liste minori hanno avuto un peso trascurabile. Su “Dimensione Bandecchi” si rimanda all’ampia aneddotica sul personaggio, “Forza del Popolo” risente delle vicende del candidato presidente, prima ritiratosi e comunque entrato in contrasto con il suo stesso partito. “PER Nicola Campanile”, formazione rappresentativa di una parte del mondo cattolico, solo a Napoli ha superato l’1%. E’ il limite di un partito interessante ma eccessivamente napolicentrico e costretto, inoltre, a correre in solitudine, probabilmente un errore per chi intendeva creare un “campo largo”. Discorso simile riguarda “Potere al Popolo”, che supera di poco il 2% ma soprattutto per i voti presi a Napoli. Rispetto a PER ha scelto di correre in solitudine, sperando probabilmente di speculare sulla rendita di posizione.
Considerando invece le due coalizioni, a sinistra i democratici pur non arrivando al 20% doppiano quasi il M5S, giunto al secondo posto con valori simili alla tornata del 2020, ovvero quando senza il campo largo De Luca vinse con quasi il 70% dei voti. In terza posizione c’è “A Testa Alta”, una lista deluchiana. Non particolarmente rilevante il successo della lista “Fico presidente”, a dimostrazione del fatto che intorno al neogovernatore gli entusiasmi sono freddi. Resiste, come sempre, l’area moderata.
A destra, percentualmente sono ottimi i risultati di FdI e FI, che raddoppiano il consenso rispetto al 2020, mentre la Lega si conferma.
Guardando poi agli eletti, compaiono diversi personaggi folcloristici, grandi frequentatori di social, rivenditori specializzati di fuffa e una folta pattuglia de “i soliti noti”: assidui frequentatori di scranni indipendentemente dal partito che li offre loro. In ogni caso, per sapere la vera composizione del consiglio si dovrà attendere la nomina degli assessori, un’operazione che a partire dai numeri appena richiamati rischia di suscitare più di un malumore.
Sul quadro generale, grava però l’incognita maggiore: il peso dell’astensionismo. Sempre in Campania, la coalizione vincente pur superando il 60% delle preferenze rappresenta appena un quarto degli elettori (25,8%). Nonostante il “campo largo”, insomma, la rappresentatività della coalizione che salirà al potere nel prossimo quinquennio, si è sensibilmente ridotta rispetto al 2020, quando rappresentava il 35,8% degli elettori. Se poi si considera solo il partito più votato, il PD è stato scelto solo dal 7,4% degli aventi diritto, registrando comunque una perdita di circa 28.000 preferenze rispetto al 2020.
Pochi giorni fa, l’ormai anziano Jurgen Habermas intervenendo a Monaco di Baviera ad un convegno sulla crisi delle democrazie occidentali illustrava il cambiamento in corso in tutti i regimi democratici, con il passaggio all’autoritarismo, l’accentramento dei poteri nella figura del leader, l’aperta ostilità al mondo universitario e il tentativo di imbavagliare la stampa. Il filosofo 96enne parlava soprattutto degli USA, ma gli esempi sono applicabili in diversa misura a tutte le democrazia occidentali. In assenza di una reale opposizione, i populismi stanno guidando i paesi alla rapida transizione da un sistema democratico ad un sistema in cui elezioni e rappresentatività hanno un valore esclusivamente simbolico.
C’è da domandarsi se tra le forze politiche che hanno partecipato all’ultima tornata elettorale ce ne sia almeno una che sia consapevole di quanto accade e, soprattutto, se qualcuna abbia o meno intenzione di correre in soccorso della democrazia. Al momento, il quadro è abbastanza sconfortante sia per l’assenza di visioni e di analisi. Si ragiona nel breve periodo, una legislatura o anche meno, e la politica sembra ridotta ad uno sterile culto di personalità che, per risultare tali, non sanno fare di meglio che esasperare i toni e prodursi in affermazioni tanto roboanti quanto fantasiose. Forse è bene chiedersi se tra coloro che non si recano più alle urne non ci siano anche coloro che vorrebbero parlare di futuro.
Argomenti: Elezioni